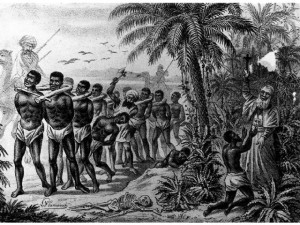Il 25 novembre 2016, al Museo di Storia Naturale di Milano, si è tenuto un incontro/convegno dedicato a Lidia Cicerale, già co-fondatrice, generosa mecenate e presidente del CSAA. L’iniziativa, focalizzata sulle tradizionali aree di ricerca del CSAA, ha visto la partecipazione di ricercatori e studiosi, italiani e internazionali, che con noi si sono occupati di questi temi. I contributi più significativi saranno pubblicati sul prossimo numero di “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”.
Archivio dell'autore: Giacomo
Le liriche d’amore dell’antico Egitto
Gilberto Modonesi
Introduzione
Intorno all’anno 1570 a.C. inizia il Nuovo Regno e con esso una nuova fase della civiltà egizia che si arricchisce di contatti con l’esterno non solo per certi aspetti tecnologici e militari, ma anche per un’apertura verso l’esotico che deriva da una fitta rete di rapporti diplomatici e di intensi scambi commerciali.
In questo periodo, ricco di nuovi fermenti, ha luogo una radicale revisione della civiltà faraonica ad opera del re Akhenaton. Il “monoteismo” solare di Akhenaton modifica alla radice il rapporto tra l’individuo e la società, così come il ruolo dello stesso sovrano. Prima di Akhenaton la concezione religiosa si manifestava come dialettica tra maat, l’equilibrio cosmico e sociale, e isefet, il caos. Il ruolo del sovrano era di garantire l’ordine della creazione combattendo il caos. L’individuo faceva parte del corpo sociale e anche i suoi comportamenti erano prescritti dalla maat. Il concetto di giustizia era l’elemento regolatore della società e della sua complessa articolazione.
Con il monoteismo amarniano non c’è nessuna dialettica. Aton è il solo e unico dio e Akhenaton è il suo profeta, colui che rivela e trasmette la Verità. La nuova concezione religiosa è basata sulla fede verso il dio solare Aton e colui che lo rappresenta sulla terra, suo figlio Akhenaton. Il male è ciò che si oppone a questa dottrina. Si rompe così l’antico e tradizionale elemento di coesione sociale e al suo posto si sviluppa un senso di pietà personale (1). Si afferma la centralità dell’individuo che si manifesta con la flessibilità dei comportamenti sociali: cade la rigida prescrittività dei comportamenti sociali, ora gli individui sono più orientati dai propri sentimenti.
Queste considerazioni valgono particolarmente per il sovrano che ora si mostra anche nei suoi momenti privati e di vita quotidiana: scene di vita familiare, il pasto, le corse sul cocchio. Ora nell’arte si esprimono anche le scene d’amore coniugale nell’ambito della famiglia regale superando il rigido schema delle statue binarie in cui i due sposi compaiono rigidamente affiancati.
Questi germi innovativi introdotti dalla riforma amarniana non si spengono con la morte di Akhenaton: anche dopo la restaurazione le innovazioni evolvono, favorite dal nuovo contesto in parallelo con il recupero della tradizione non più irrigidita in canoni fissi. Nel periodo ramesside i segni di questa maggiore elasticità intellettuale si manifestano con gli ostraka (2) (ad esempio con le rappresentazioni del “mondo alla rovescia”) e la produzione figurata di materiali “pornografici” (fra questi il più famoso è il Papiro erotico di Torino) che si integrano con elementi comici e satirici, in cui animali imitano gli umani e talvolta anche i comportamenti regali.
Le liriche d’amore sono componimenti unici nella produzione letteraria egizia e risalgono tutte al periodo ramesside (XIX-XX dinastia). Le liriche d’amore si inseriscono in un filone in cui la lingua si rinnova con parole e forme che appartengono al linguaggio parlato (il neo-egiziano), una evoluzione della lingua che forse ha origine dalla volontà di formalizzare nella forma scritta componimenti orali.
Le liriche d’amore sono classificate come “divertimenti del cuore” (sxmb-ib), una espressione che viene usata per indicare piacevoli situazioni conviviali.
I temi compositivi e i rimandi letterari
Merut (mrwt) è il male d’amore, quasi una malattia che ha come soluzione l’unione dei due amanti. In una lirica il canto è concepito come un incanto amatorio che richiede la presenza di un ritualista con i suoi incantesimi.
Nelle liriche vi sono parecchie citazioni di testi mitici e varie assonanze con testi e inni religiosi. In questo senso la “sorella” (= l’amata) può trasformarsi in un corpo divino (Hathor, la dea della bellezza e dell’amore), così come il “fratello” (= l’amato) può essere considerato un dio.
Gli egizi non disdegnavano temi pornografici, come dimostra il Papiro erotico di Torino che proviene dallo stesso ambiente che ci ha tramandato le liriche d’amore ed è dello stesso periodo. Nelle liriche non c’è pornografia ma sentimenti d’amore e il desiderio degli amanti di congiungersi, un desiderio ben naturale per dei giovani amanti.
Nelle liriche l’erotismo si avverte e probabilmente non mancano i doppi sensi. Alcuni di questi risultano evidenti da altre fonti in cui certe espressioni vengono usate con espliciti riferimenti erotici. Altri doppi sensi sono probabili ma non certi. Oggi la loro percezione dipende dall’attualità di certe battute e da un certo nostro grado di malizia personale che può influenzare la lettura.
I canti esprimono focosi sentimenti amorosi che non sorprendono se vengono manifestati da giovani uomini innamorati. Ma anche le fanciulle sono tutt’altro che reticenti e manifestano con altrettanto ardore la loro passione amorosa e il desiderio di congiungersi all’amato. Abbiamo in questi canti la prova della libertà sessuale di cui godevano le fanciulle prima del matrimonio oppure questi toni accalorati sono l’indizio che essi sono stati composti da uomini?
Nel complesso delle liriche l’amore corrisposto, che giunge alla sua naturale conclusione, è concepito come una forma di gioco tra i due innamorati, un gioco alla pari, senza imposizioni e forzature da una delle due parti, tipicamente l’uomo. Quando si è avvinti da uno struggente sentimento d’amore la controparte ci appare come un’entità assolutamente unica: “Tu sei l’unico/a, non c’è nessun altro/a come te”. Esattamente il contrario di quando l’amore decade: “Sei come tutte le altre”. Questo sentimento ambivalente dell’amore costituisce il canovaccio letterario delle liriche d’amore dell’antico Egitto.
Le fonti principali
La raccolta delle liriche d’amore consta di 94 poesie, molte in frammenti.
1 – Papiro Chester Beatty I (conservato al British Museum)
Il papiro, acquistato da Chester Beatty, proviene da una tomba di Deir el-Medina: la tomba di Amonnakht, figlio di Ipuy. Questo e altri papiri erano nascosti nella sovrastruttura ora scomparsa. Il papiro contiene anche un inno a Ramesse V e la versione popolare del mito con la contesa di Horus e Seth. L’inno a Ramesse V lo data alla XX dinastia; ma le poesie d’amore potrebbero essere state ricopiate. Sul verso del Papiro le poesie d’amore hanno come titolo: “Inizio dei componimenti della grande gioia del cuore”. Sul recto il titolo è: “Dolci versi trovati in un cofanetto”.
2 – Papiro Harris 500 (conservato al British Museum)
Acquistato da Harris, proviene da Deir el-Medina o da Medinet Habu. E’ datato alla XIX dinastia. Il papiro contiene anche “Il canto dell’arpista”, la “Storia del principe predestinato” e “La presa di Ioppe”. Le poesie d’amore hanno come titolo: “Inizio dei componimenti di svago. La bellezza della sorella giunge dai campi”.
3 – Papiro di Torino (venduto al Museo da Bernardino Drovetti)
Il papiro, di grande formato, riporta anche un testo di carattere amministrativo. Le liriche hanno come titolo “I canti del boschetto” perché protagonisti sono tre alberi: “Il melograno parla…”, “L’albero di fico apre la bocca…”, “Il giovane sicomoro…”
4 – Ostraka vari
Quasi tutti questi ostraka provengono dal grande pozzo di Deir el-Medina. In totale sono 27 e risalgono alle dinastie XIX-XX.
Le occasioni in cui venivano recitate o cantate le liriche d’amore
Le rappresentazioni egizie delle tombe della XIX e XX dinastia ci mostrano spesso scene conviviali. Molte di queste scene si riferiscono a banchetti funerari in cui parenti e amici del defunto celebravano un pasto in occasione della “bella festa della Valle”, festività in cui la statua del dio Amon attraversava il Nilo e visitava i templi “funerari” dei sovrani e le necropoli della riva ovest.
Altre scene sono meno convenzionali e mostrano leggiadre fanciulle che suonano i loro strumenti, accennano a passi di danza e sembra che cantino. Si può presumere che giovani delle classi elitarie si incontrassero in amichevoli convivi animati anche da musica, danze e canti. Momenti felici e spensierati come d’altra parte annunciano i titoli di alcuni componimenti lirici: “Inizio dei componimenti della grande gioia del cuore”.
Ogni lirica d’amore ha come protagonista il giovane innamorato o la fanciulla innamorata. Secondo logica si dovrebbe pensare che le poesie fossero recitate o cantate, secondo i casi, da un maschio o da una femmina. In realtà non c’è nulla che provi questa alternanza: le scene che si possono attribuire con certezza a tali occasioni conviviali mostrano solo orchestrine di fanciulle. E’ anche possibile che le liriche fossero composte da maschi e recitate da fanciulle. In effetti la conoscenza della scrittura era molto più diffusa tra i maschi che tra le femmine; inoltre le rappresentazioni di orchestrine di questo periodo mostrano solo fanciulle musicanti e tra loro sembra che si possano riconoscere delle cantatrici.
Nota sui caratteri formali dei testi
Le liriche ci trasmettono i giovanili e vitali sentimenti di persone vissute più di tre millenni fa. Le loro voci ci emozionano perché i loro sentimenti li rendono così attuali e simili a noi in alcuni momenti della nostra vita.
I filologi che sono in grado di leggere e tradurre queste poesie possono anche apprezzare i caratteri formali di questo genere letterario.
L’unità di base dei canti è il distico (strofa di due versi) eptametrico (sequenza normativa di 7 unità): si tratta di una struttura fissa del verso, soggetta però a variazioni e ripetizioni che hanno lo scopo di produrre un ritmo più deciso.
La costruzione dei versi ricorre spesso all’allitterazione (assonanze prodotte dalla ripetizione a fini stilistici di parole che hanno simili composizioni sillabiche) e alla paronomasia (l’accostamento di due parole omofone per mettere in risalto l’opposizione dei significati).
Note
(1) La “confessione negativa dei peccati” del capitolo CXXV del Libro dei Morti ne è la prova evidente, così come l’istituzione nei templi di un posto dedicato al “dio che ascolta le preghiere” dove i fedeli possono confidarsi con la divinità. Le stele con la rappresentazione di orecchi esprimono un’altra modalità di comunicazione diretta con la divinità.
(2) Sono così chiamate le scaglie di calcare e i cocci di vasi che recano disegni o dipinti e iscrizioni.
Bibliografia
Mathieu B., La poésie amoureuse de l’Egypte ancienne. Recherches sur une genre littéraire au Nouvel Empire, IFAO, Le Caire 1996. Questo volume è essenziale per la traduzione di tutte le poesie conosciute, la pubblicazione dei testi, l’apparato critico e vari tipi di analisi formale.
Ciampini E., Canti d’amore dell’antico Egitto, Salerno Editrice, Roma 2005. Nell’introduzione l’autore presenta le poesie d’amore nel contesto del periodo come risultato delle novità introdotte nel periodo amarniano e nel contempo ispirate ai canoni tradizionali. Il presente testo ha come riferimento principale i temi sviluppati nell’“introduzione” di Ciampini.
Vernus P., Chants d’amour de l’Egypte antique, Imprimerie Nationale, Paris 1992.
Bresciani E., Le liriche d’amore, in Letteratura e poesia dell’antico Egitto, Einaudi Tascabili, Torino 1999, pagg. 453-477.
Fowler B.H., Love Lyrics of Ancient Egypt, The University of Carolina Press, Chapel Hill and London 1994.
Derchain Ph., Pour l’érotisme, in Chronique d’Egypte, LXXIV (1999), fasc. 148, pagg. 261-267. Nell’articolo l’autore critica l’analisi strettamente filologica di Mathieu che non concede nulla all’erotismo delle liriche che invece è nella natura di questi testi.
Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, vol. II: The New Kingdom, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, pagg. 181-193.
Mathieu B., L’univers végétal dans les chants d’amour égyptiens, in Encyclopedie religieuse de l’Univers végétal, vol. I, Université Paul Valery – Montepellier 1999, pagg.99-106.
Donadoni S., La letteratura egizia, Sansoni-Accademia, Firenze 1967, pagg. 203-217. L’autore riporta numerosi brani delle liriche per evidenziare di volta in volta il ritmo delle poesie, l’ispirazione intellettuale, i rimandi letterari e i virtuosismi formali.
- (1) Liriche amorose
- (2) Liriche amorose
- (3) Liriche amorose
- (4) Liriche amorose
- (5) Liriche amorose
- (6) Liriche amorose
- (7) Liriche amorose
- (8) Liriche amorose
- (9) Liriche amorose
- (10) Liriche amorose
- (11) Liriche amorose
- (12) Liriche amorose
- (13) Liriche amorose
- (14) Liriche amorose
- (15) Liriche amorose
- (16) Liriche amorose
- (17) Liriche amorose
Archeologia Africana – Saggi Occasionali – numero 18/19, 2012/2013
 Testi in italiano, inglese e francese, 84 pagine, 68 illustrazioni (b/n), bibliografie
Testi in italiano, inglese e francese, 84 pagine, 68 illustrazioni (b/n), bibliografie
Prezzo: Euro 10
Indice:
– Redazionale di Giulio Calegari
– Beppe Berna “Il ‘Maestro dei sorrisi’. Il mistero di un artista transculturale”
– Giulio Calegari “Paleolitofonie”
– Franco Di Donato “Arco tellem del XI-XII secolo”
– Dragos Gheorghiu “Visual rhetorics and immersion in imagined pasts (the “maps of time project”)”
– Edyta Lubińska “La chiesa profetica e i profeti tra gli zande mbomou nel cuore dell’africa”
– Gilberto Modonesi “La concezione antropologica nell’immaginario egizio”
– Paolo Mottana “Visitazione immaginale”
– Elio Revera “Negli occhi di un altro: lo sguardo ‘nero'”
– Gaetano Roi “Sperimentare archelogia – arte ci vuole”
– Antonello Ruggieri “Arslantepe: la magia dell’argilla”
– Giorgio Samorini “Le ninfee degli antichi egizi un contributo etnobotanico”
– Margherita Sbanchi “Art préhistorique et comportements symboliques”
TESTI E IMMAMAGINI SULL’AFRICA NELLA PRODUZIONE EDITORIALE EUROPEA DELL’ETA’ MODERNA
Francesco Surdich
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia
TESTI E IMMAMAGINI SULL’AFRICA NELLA PRODUZIONE EDITORIALE EUROPEA DELL’ETA’ MODERNA
(articolo pubblicato in “In viaggio: scritti immagini e immaginario africano nell’epoca delle scoperte” a cura di Gigi Pezzoli, Milano, 2005)
Nonostante le spedizioni promosse lungo la costa occidentale dell’Africa dalla corona portoghese che portarono Gil Eannes a doppiare, nel 1434, il Capo Bojador, situato tra il Marocco e la Mauritania e considerato allora un limite invalicabile dalle leggende medievali e dalle superstizioni dei marinai, e che, proseguendo con continuità nei decenni successivi, permisero, alla fine del secolo, a Bartolomeo Dias di doppiare il Capo di Buona Speranza ed a Vasco de Gama di raggiungere le Indie Orientali dopo aver circumnavigato l’intero continente; e, nonostante l’incarico di raccogliere notizie sulla costa orientale affidato nel 1487 ad Afonso de Paiva ed a Pedro de Covilham, le conoscenze e la percezione di questo continente da parte dell’Europa cristiana, limitate soprattutto alle zone costiere, dove vennero creati degli insediamenti e costruite delle fortificazioni nei punti più favorevoli all’attività commerciale, apparivano ancora largamente ancorate alla tradizione classica e medievale nella quale l’immaginazione e l’elemento favoloso avevano avuto un ruolo rilevante, come ci fa capire, ad esempio, la stravagante rappresentazione dell’Africa meridionale, del Madagascar e di Zanzibar fornitaci nel 1492 dalla carta di Martin Behaim, che peraltro aveva compiuto un viaggio nel golfo di Guinea.
Si può considerare questo il caso dell’Etiopia che ancora alla fine del Quattrocento continuava ad essere ritenuta la più probabile sede del Prete Gianni, cioè della speranza, sempre inseguita ed accarezzata, fino a renderla credibile, che al di là del mondo islamico fosse situato un regno cristiano in grado di aiutare i suoi lontani correligionari a sconfiggere gli infedeli, convinzione alimentata anche dall’identificazione, allora molto frequente, fra India ed Etiopia. Così, all’inizio del Cinquecento, un erudito veneziano, Marco Antonio Coccio, detto il Sabellico (1436-1506), in una sua opera di carattere storico-enciclopedico pubblicata per la prima volta nel 1504, le Enneadi, parla, a proposito dell’Etiopia, di un grande paese, ricco di magnifici templi, dominato da 62 re tutti soggetti al Pretojan, che aveva a sua disposizione un esercito di un milione di uomini, cinquecento elefanti ed un gran numero di cammelli e di cavalli (1).
Ma se l’immagine del Prete Gianni avrebbe continuato a sopravvivere ancora per diverso tempo, la letteratura di viaggio del Cinquecento legata alla costruzione dell’impero coloniale portoghese nelle Indie Orientali ne avrebbe gradualmente ridimensionato il ruolo ed il significato, a cominciare dalle due lettere scritte dall’India nel 1516 e nel 1517 dal fiorentino Andrea Corsali, che molto probabilmente morì in Etiopia dove, secondo la testimonianza di un religioso abissino di passaggio per Venezia nel 1524, avrebbe esercitato l’attività di tipografo. In queste lettere, stampate e diffuse subito dopo il loro arrivo, il Corsali faceva sapere come il Prete Gianni (al quale attribuì però un regno enorme, che occupava quasi tutto l’interno dell’Africa a sud dell’Egitto e si estendeva fino al regno del Congo, traendo così in inganno, per almeno due secoli, molti cartografi) non avesse alcun palazzo, ma vivesse “alla campagna con padiglioni e tende di sete e varie sorte di panni”.
Con la pubblicazione, nel 1521 a Lisbona, di un opuscolo di 14 fogli (Carta das novas que vieram a el Rey nosso Senhor do descobrimento do Preste Joham), contenente le notizie fornite dal portoghese Rodrigo de Lima inviato l’anno precedente come ambasciatore alla corte etiope, dove trovò ancora in vita il Covilham (2); nonché delle lettere di risposta del sovrano etiopico edite a Bologna nel 1533, assieme ad una digressione sull’impero del Prete Gianni e sui regni confinanti, dal fiammingo Jacob Keymolen da Alost; ma soprattutto della Verdadera informaçam das Terras do Preste Joam das Indias, redatta nel 1527 e stampata postuma a Lisbona nel 1540, del cappellano dell’ambasceria, Francisco Alvares, che durante i sei anni (1520-1526) trascorsi in Abissinia ebbe anche l’opportunità di sentire dal Covilham il resoconto delle sue vicende (3), l’Etiopia cominciò però ad acquistare tratti gradatamente più precisi e realistici. Questa sarebbe stata la caratteristica anche delle relazioni, solo in minima parte diffuse a stampa, redatte dagli ambasciatori e dai diplomatici portoghesi come il medico João Bermudes, vissuto a lungo, a partire dal 1520, alla corte abissina ed autore, dopo essere stato consacrato patriarca “in partibus infidelium”, di una Breve relação da embaixada que (…) trouxe do Imperador da Ethiopia, chamado vulgarmente Preste João, pubblicata a Lisbona nel 1565; ma soprattutto dai Gesuiti (4) che C. F. Beckingham ha definito “highly educated men of great intellectual curiosity”, dal momento che le relazioni e le lettere da loro scritte “contain much of historical, topographical and anthropological value” (5).
Fra le testimonianze trasmesse da questi missionari che operarono in quel territorio a partire dalla missione guidata da João Nunes Barreto, eletto Patriarca di Aksum da papa Giulio III, fino alla loro espulsione decretata nel 1633 dal Negus Fasilidas, gran parte delle quali comparvero nelle Litterae Annuae, spiccano sia la Historia de Ethiopia, redatta in portoghese in quattro libri verso il 1620 da padre Pedro Paez che visse per quasi vent’anni in Etiopia (la percorse in ogni direzione fino a raggiungere anche le sorgenti del Nilo Azzurro, scambiate con quelle del vero Nilo, nel lago Tana (6), quando nel maggio 1618 visitò la piccola città di Geesh), imparò perfettamente l’arabo, il gheez e l’amarico e potè esaminare gran parte dei codici conservati ad Axum; sia la Historia de Etiopia di Jeronimo Lobo, nominato vicario generale del Tigré nel 1625, pubblicata a Coimbra nel 1659 e che nell’arco di pochi decenni conobbe un rilevante numero di edizioni e traduzioni per l’ampiezza e la precisione dei riferimenti alle pratiche religiose degli Etiopi, ma anche alle loro forme di governo, ai loro costumi, nonché alla flora ed alla fauna (7) di quel territorio.
Ma vanno ricordati anche i tre trattati storici intitolati, il primo Do estrado da santa fé romana en Ethiopia, il secondo Do reino de Tigré e seus mandos en Ethiopia (8) ed il terzo Da cidade de Adem, compilati da padre Emanuele Barradas che soggiornò in Etiopia (quasi sempre nel Tigré) dal 1624 al 1633; oltre che la Historia de Ethiopia a alta, ou Abassia, imperio do Abexim, cujo Rey volgarmente hé chamado Preste Joam, composta in dieci libri da padre Manoel d’Almeida, superiore della missione. Tutti questi manoscritti, insieme ad altri documenti originali come i quattro libri dell’Expeditionis aethiopicae del patriarca Afonso Mendez, redatti nel 1650 e rimasti sepolti per oltre due secoli negli archivi della Congregazione di Gesù, sarebbero stati utilizzati dal provinciale dei Gesuiti in Portogallo, Balthazar Tellez, per la sua Historia geral de Ethiopia a alta, pubblicata a Coimbra nel 1660, con la quale vennero divulgate via stampa l’enorme quantità di notizie e conoscenze fino ad allora raccolte su quel territorio dai suoi confratelli.
Più rare furono invece le testimonianze non connesse con l’attività di evangelizzazione, come quella (Relation abregée du Voyage que M. Charles Poncet, Médecin français, fit en Ethiopie en 1698, 1699 & 1670) redatta da un medico francese che accompagnato dal gesuita Xavier de Brévedent, nel 1698 si recò a Gondar per cercare di guarire il Negus Iasu I Tellac da una specie di scorbuto che lo affliggeva da tempo e sembrava degenerare in lebbra; o quella di Giacomo Baratti, autore della relazione di un viaggio compiuto in Etiopia nel 1656 che ci è arrivata attraverso la traduzione inglese, pubblicata a Londra nel 1670, di due precedenti edizioni italiane delle quali si sono perse le tracce. In questo resoconto, oltre ad una serie di considerazioni piuttosto insolite sulla tradizione religiosa abissina, della quale vengono rimarcati soprattutto il rispetto per la libertà dell’individuo e l’atteggiamento estremamente tollerante, risultano analizzati e descritti con precisione e ricchezza di dati e particolari, che nel loro complesso appaiono sempre piuttosto attendibili, anche tutti gli altri aspetti del mondo etiopico: dalla vita di corte alla struttura politica ed amministrativa dell’impero, dalle caratteristiche geografiche dei vari territori agli usi e ai costumi delle diverse popolazioni, dalle curiosità e leggende alle principali risorse e prodotti del suolo, ecc. (9).
Per essere stati considerati a lungo l’opera più autorevole sull’Abissinia ed in grado di offrire ancora agli studiosi spunti e indicazioni utili ed interessanti, che spaziano dalle caratteristiche dei territori abissini e dall’indole degli abitanti alla struttura ed alla situazione religiosa, oltre che alla cultura letteraria ed alle risorse economiche di quello stato, spiccano fra tutti questi testi i quattro libri, pubblicati a Francoforte nel 1681 e comprendenti anche una carta dell’Etiopia ornata dal rinoceronte e da altri animali fantastici, della Historia Aethiopica, sive brevis & succincta descriptio Regni Habessinorum, quod vulgo male Presbyteri Johannis vocatur, compilata da Hiob Ludolf, profondo conoscitore delle lingue orientali che per ben 26 anni rivestì la carica di consigliere aulico del Duca di Sassonia Gotha e fu precettore dei suoi figli (10). Dopo quest’opera bisognerà però aspettare sino alla fine del Settecento per avere di nuovo un quadro articolato, anche se pieno di imprecisioni, del territorio e delle popolazioni abissine con i cinque volumi, dedicati al re d’Inghilterra, dei Travels to discovery the sources of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773, pubblicati ad Edimburgo nel 1790, relativi alla spedizione compiuta alla ricerca delle sorgenti del Nilo dal medico scozzese James Bruce che raggiunse però solo quelle del Nilo Azzurro come avevano già fatto tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento i missionari portoghesi (11).
Sulla scia dei viaggi di pellegrinaggio in Terrasanta, ancora almeno per tutto il Cinquecento, consistente sarebbe stato pure, per quel che concerne l’Africa orientale, il flusso di informazioni e notizie sull’Egitto, altrettanto oscillanti fra mito e realtà, dal momento che, come ha scritto Jeannine Guérin Dalle Mese, sottolineando un atteggiamento che sarà comune peraltro a tutta la letteratura di viaggio sull’Africa, “les voyageurs qui visitent l’Egypte ne peuvent rester indifférents” perché “ils sont sans cesse tiraillés entre l’admiration, la fascination et la répulsion, ils aiment ou il détestent, et souvent aiment encore lorsqu’ils détestent”. Difatti “le pays fertile les attire dans sa luxuriance; le desert fait peur mais séduit en même temps, il est la mort que l’on brave et dont on triomphe, il découvre à qui le parcourt jour après jour des beautés insoupçonnées. Mais plus que le contrastes de la nature, ce sont les habitants de ce pays qui suscitent les sentiments mêlés des voyageurs: on les aime et ont les hait, on leur réserve parfois les pires injures, il sont “l’autre” qui dérange parce que different, qui n’a pas la même couleur, n’est pas de la même race, ne vie pas de la même façon, pire, n’a pas la même religion, mais en même temps, on admire sa foi et sa pratique religieuse” (12).
Fra i più attenti e concreti si possono collocare i numerosi medici che si recano in Egitto nella seconda metà del Cinquecento raccogliendo una quantità infinita di osservazioni sulla storia naturale, come Pierre Belon du Mans che nel 1557 pubblica a Parigi i Portraits d’oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres, hommes et femmes d’Arabie et d’Egypte; il tedesco Leonhart Rauwolff che, nel suo Beschreibung der Reyss in die Morgenländer edito ad Augusta nel 1581, descrive e studia le piante ma anche le concezioni religiose ed i costumi dei paesi visitati; il bellunese Andrea Alpago che rivolge la sua attenzione pure alla cultura islamica (fu autore, ad esempio, di una De Arabicorum nominum significatu e Arabicorum nominum interpretatio inserita nel contesto di una sua traduzione del Liber canonis di Acvicenna apparsa a Venezia nel 1562); ed il vicentino Prospero Alpino, medico condotto presso il consolato veneziano al Cairo dal marzo 1582 all’ottobre 1584: i suoi quattro libri di Rerum Aegyptiarum, che costituiscono la prima parte delle Historiae Aegypti naturalis, pubblicati postumi nel 1735, erano nati forse, secondo Giuliano Lucchetta, come un quaderno di appunti di viaggio che si è andato “via via allargando e strutturando in un panorama di geografia generale ed umana” per “darci una visione unitaria di quel paese tanto vario e dalle sorprendenti contraddizioni”, di cui lo colpirono l’ambiente umano, i costumi ed il comportamento della gente comune che affolla le vie del Cairo, chiassosa e fantasiosa, i ciarlatani e gli incantatori di serpenti, gli abilissimi attori del teatro delle ombre e le danzatrici beduine, mezzo funambole mezzo prostitute, il rispetto con cui quel popolo tratta i bambini, i mendicanti, i forestieri che accoglie sempre onorevolmente (13).
Una visione complessiva dell’Egitto è anche quella fornita da Filippo Pigafetta, consanguineo per un ramo collaterale del più famoso Antonio, che prese parte al primo viaggio di circumnavigazione attorno al globo. Uomo d’arme, umanista, diplomatico, Filippo, che compì diversi viaggi in Europa e nell’Estremo Oriente, visitò l’Egitto fra il 1576 ed il 1577 interessandosi con spirito critico sia ai resti archeologici sia alle strutture urbane e sociali, al patrimonio culturale ed all’ambiente naturale, descrivendo il tutto con ricchezza di particolari in un’ampia relazione, rimasta inedita fino al 1984 (14), da lui dedicata e personalmente presentata nel 1585 a papa Sisto V appena salito al soglio pontificio. Nella seconda parte del suo resoconto, in cui racconta l’avventuroso viaggio nella penisola del Sinai fino al monastero di Santa Caterina ed il ritorno attraverso il mar Rosso, travagliato da venti furiosi e da disagi di ogni genere su una malsicura imbarcazione, il Pigafetta espone, ad esempio, le sue minuziose osservazioni sullo sviluppo della costa, sulla morfologia del sistema montuoso, dei fondali marini e dei banchi coralliferi, sulle secche, sulle maree e sui venti costanti: osservazioni che rappresentano il primo studio organico sulle coste della penisola sinaitica e sulla navigazione nel Mar Rosso (15).
In linea di massima altrettanto attendibili fin dai primi approcci, oltre che pervase qua e là da una certa attenzione per il nuovo e l’insolito nel rapporto che seppero instaurare in qualche caso fra esperienza concreta e adesione all’autorità, furono le informazioni che si vennero accumulando e diffondendo sulla costa africana atlantica e sulle popolazioni che allora le abitavano grazie alla spedizioni promosse da Enrico il Navigatore ed alle conseguenti relazioni come quelle di Alvise Ca’ da Mosto, Gomes Eanes de Zurara o Diogo Gomes, per arrivare, infine, all’Esmeraldo de Situ Orbis, redatto probabilmente tra il 1505 ed il 1508 (ma pubblicato solo nel 1892) da Duarte Pacheco Pereira, il quale si spinse a sottolineare che “l’esperienza ci rende disillusi degli errori e delle favole che taluni tra gli antichi cosmografi scrivevano a proposito della descrizione della terra e del mare”, permettendo di comprendere che “tutto ciò è falso e che le cose sono del tutto differenti”:
“E’ l’esperienza – puntualizzava infatti – che è stata nostra maestra poiché durante i numerosi anni e stagioni in cui abbiamo navigato e circolato in questo paese dell’Etiopia di Guinea, in numerosi punti abbiamo rilevato la altezza del sole e la sua declinazione per conoscere per ogni luogo la distanza in gradi che lo separi in latitudine dall’equatore nei riguardi di ognuno dei poli. Abbiamo trovato che questo circolo [dell’equatore] passa di sopra di questo promontorio e riteniamo per sicuro che in quel luogo i giorni e le notti si equivalgono o se vi è una differenza è così piccola che non ci se ne accorge quasi” (16).
Questa relazione, compilata per favorire una migliore gestione dei rischi e degli utili della navigazione lungo la costa occidentale dell’Africa, si presentava infatti ricca di dati e di indicazioni concrete, come ci dimostra, ad esempio, questa presentazione della foce del fiume Benin:
“Questo fiume Benin ha una foce molto vasta che ha una larghezza di una lega abbondante da un punto all’altro; il paese che è situato in direzione Sud-Ovest ha un bosco così regolare che sembrerebbe che nessun albero sia più alto dell’altro. All’interno e a destra della sua foce vi è un albero molto alto e frondoso tale da superare di molto le cime degli alberi e più in là, oltre quest’albero ve ne sono altri due alti allo stesso modo. La foce di questo fiume è dovunque poco profonda e non supera 8 braccia e 2 palmi di profondità e tutto vi è di melma molle in modo che una nave può passare in mezzo braccio di melma senza danno. Questo basso fondo si protende nel mare per circa 2 leghe. L’ingresso ed il canale passano lungo la costa sinistra” (17).
Esigenza questa, di precisione e di realismo, dettata soprattutto dalla necessità di risultare utili all’aspetto speculativo e pratico delle spedizioni, presente pure nel Tratado breve dos rios de Guiné di André Alvares de Almada, nel Roteiro da carriera da India, compilata attorno al 1536 da Diogo Afonso e nel Roteiro de D. João de Castro, redatto fra il 1538 ed il 1541, come pure nella Descripçam de Cepta por sua costa de Mauritania e Ethiopia pello nomes modernos proseguindo as vezes alguas do sartão da Terra firme, compilata nel 1507 da Valentim Fernandes, lo stampatore boemo che lavorava per il re Manoel e che nel 1503 era stato nominato fiduciario dei mercanti tedeschi di Lisbona, per un manoscritto dal titolo De insulis et peregrinatione Lusitanorum, nel quale raccolse una serie di testimonianze sulle iniziative di esplorazione promosse dai Portoghesi nel corso del Quattrocento, attingendo tra l’altro anche al De inventione Africae maritimae et ocidentalis, videlicet Geneae, per Infantem Heinricum Portugalliae che il famoso cosmografo Geronimo Münzer stava redigendo proprio in quello stesso periodo (18).
Se si eccettuano però queste opere rimaste inedite che, nonostante le inevitabili concessioni all’autorità ed alla tradizione, cercavano in qualche modo di cogliere e segnalare gli elementi di novità proposti dai viaggi promossi dai Portoghesi pur non suscitando un’attenzione corrispondente a quanto di originale contenevano, i testi che furono pubblicati (19) continuarono invece a presentare, anche nel corso del Cinquecento, accanto ad alcune notazioni fondate, larghe concessioni a luoghi comuni ed a schemi concettuali consolidati da una tradizione secolare, soprattutto per quel che concerne le aree interne del continente, di cui d’altra parte la logica stessa del processo di espansione politico-commerciale della corona portoghese, interessato soltanto alla ricognizione ed al controllo della zona costiera, non poteva favorire una capillare ricognizione.
Non vanno ad ogni modo dimenticati i tentativi compiuti da Diogo Cão che, alla ricerca di un passaggio che congiungesse l’Oceano Atlantico con quello Indiano, risalì, fra il 1482 ed il 1484, parte del corso del basso Congo, stabilendo anche rapporti duraturi col re locale e ponendo le premesse all’avvio dell’evangelizzazione di quei territori che avrebbe dato vita, dopo l’arrivo dei missionari portoghesi (1491) e la conversione del sovrano Nzinja Nkuwu, ad un regno cristiano destinato a durare piuttosto a lungo; come pure le spedizioni lungo lo stesso fiume compiute successivamente da Simão da Silveira (1512), Gregorio de Quadra, Manuel Pacheco e Balthassar de Castro (1520), che giunsero probabilmente allo Stanley Pool rendendo convinti i Portoghesi di aver trovato il grande lago equatoriale, dal quale, secondo una versione medievale delle concezioni tolemaiche, si pensava allora che nascessero tutti i grandi fiumi africani.
Una particolare attenzione venne rivolta, soprattutto quando si cominciò a risalire lo Zambesi ed il Limpopo, al favoloso regno del Monomotapa (20), situato a quattrocento miglia dal Capo di Buona Speranza, lungo il canale di Mozambico nel territorio dell’attuale Zimbabwe meridionale, che inglobava allora cinque reami ricchi di argento, oro e pietre preziose ed al quale faceva già riferimento un opuscolo, dal titolo Calcoen, pubblicato ad Anversa in fiammingo nel 1504, relativo al secondo viaggio alle Indie Orientali di Vasco de Gama (1502). Ma, dopo le spedizioni di Antonio Fernandes, svoltesi tra il 1511 ed il 1514, raccontate al re del Portogallo da una lettera di Gaspar Veloso del 1502 e di João Vaz de Almeida del 1516, il primo a parlarne in forma approfondita presentandolo come il “regno di Benamatara”, sarebbe stato Duarte Barbosa nel suo Livro redatto fra il 1517 ed il 1518; ed ancora più preciso e circostanziato si sarebbe dimostrato nelle sue decadi, pubblicate a partire dal 1552, quando il mito del re di Monomotapa avrebbe cominciato a sovrapporsi ed a sostituirsi a quello del Prete Gianni, il cronista portoghese João de Barros, che cercò di unificare in un unico racconto tutte le informazioni di viaggio, le cronache ed i rilevamenti dei marinari portoghesi di cui potè facilmente disporre dal suo osservatorio di corte (21) costruendo, come ha sottolineato Alessandra Mauro, “un’ottima fonte per rintracciare le tappe di quella delicata dinamica” che, come cercheremo di far vedere in questo nostro contributo, “trasforma le informazioni in testo scritto e quindi materiale per l’elaborazione cartografica” (22).
Il Barros si soffermò anche sulle cerimonie della corte, sui costumi, sulle leggi e sulle concezioni religiose di quelle popolazioni e non esitò a celebrare i progressi compiuti dai Portoghesi rispetto alla Geografia di Tolomeo, che allora costituiva un imprescindibile punto di riferimento nella conoscenza della parte meridionale del continente africano, facendo rilevare che:
“Nella parte della terra di Africa sopra l’Etiopia, che Ptolomeo chiama interiore, dove è posta la regione Agisymba, che è la più australe terra di che lui ebbe notizia e dove fa la sua meridionale computazione, giace un’altra terra che ne’ suoi tempi non era da lui conosciuta, e al presente è notissima la parte sopra il mare, dapoi che abbiamo discoperto la India per questo nostro mare oceano. Al principio della quale, cominciando nella orientale parte di lei, è il Prasso promontorio, che Ptolomeo situò in quindeci gradi verso ostro, e in tanti sta per noi verificato, il quale li naturali della terra chiamano Mozambique, dove al presente abbiamo una fortezza che serve di scala o porto delle nostre navi in questa navigazione dell’India; e la parte occidentale di questa terra a Ptolomeo incognita finisce in la latitudine di gradi cinque della parte di ostro, che confina con gli Etiopi, che quello chiama Esperii per nome comune, che sono li popoli pangelungi sudditi al nostro re di Manicongo, fra li quali duoi termini orientale e occidentale resta il grande e illustre capo di Buona Speranza, già tanti anni incognito al mondo” (23).
Tuttavia, se attorno alla metà del Cinquecento il profilo costiero del continente africano appariva ormai chiaramente delineato, soprattutto sul suo versante occidentale, ed erano state determinate con sufficiente approssimazione le coordinate geografiche ed erano stati riportati con esattezza sulle carte gli aspetti geografici minori (promontori, insenature e foci dei fiumi) e con una certa verosimiglianza quelli maggiori (la grande curva del golfo di Guinea, il corno del capo Guardafui, ecc.); e se, come ci ha fatto notare Carlo Zaghi prendendo in considerazione anche le ricognizioni successive, – “l’aver navigato il Shirè nel XVI e XVII secolo, o attraversato lo Zambesi tra Tehe e Kazembe nel ‘600, o visitato nel ’600 la ‘grande acqua’ (cioè il lago Nassa) esistente nel paese dei Maravi, a 34 giorni dalla costa, già conosciuta dagli arabi, o l’essersi spinti fino a Kaseh, il grande centro commerciale dell’Unyamowesi, se non al lago Tanganica (il lago Ujiji degli arabi) e l’aver avuto notizia della montagna del Kilimangiaro, sulla strada del lago Ukerewe (tutti territori in stretto contatto con Zanzibar e con la costa fin dall’antichità e abitati da popolazioni che avevano l’istinto e la vocazione del commercio)”, si possono considerare “fatti indubbiamente di grande importanza storica e geografica”, queste acquisizioni non furono in grado di far ‘camminare’ le conoscenze, perché non entrarono immediatamente nel circolo dei geografi, dei cartografi e degli esploratori, diventando patrimonio della cultura del tempo (24).
Infatti, se già nel 1489 il cartografo tedesco Enrico Martello aveva disegnato in un suo planisfero un profilo dell’Africa che si distaccava nettamente dalle concezioni tolemaiche e che, per quanto vistosamente scorretto soprattutto nella parte meridionale ed orientale, si richiamava alle scoperte dei Portoghesi; se la Charta del navicare per le isole nuovamente trovate in la parte dell’India, attribuita ad un portoghese e procurata nel 1502 al duca di Ferrara, Ercole d’Este, dall’ambasciatore Alberto Cantino, presentava per la prima volta il Madagascar disegnato in forma quasi rettangolare e posto parallelamente alla costa sud-orientale del Sud-Africa, oltre ad un corretto profilo costiero (solo leggermente allungato in senso longitudinale) del continente africano; e se il mappamondo firmato dal genovese Niccolò de Caverio, redatto fra il 1502 ed il 1505, che sarebbe stato ampiamente utilizzato da Martin Waldseemüller nella sua Cosmographia Universalis, conteneva, relativamente alle coste africane, già trecento toponimi, tutti portoghesi, compresi quelli indicati da Vasco de Gama, una maggiore fedeltà alle tradizioni, ed in particolare ai modelli tolemaici, sarebbe rimasta presente invece nella cartografia a stampa, destinata naturalmente ad una maggiore diffusione che aveva preso le mosse proprio dal moltiplicarsi, dopo la prima versione latina apparsa a Firenze nel 1475, delle edizioni, corredate da un apparato cartografico via via più ricco, della Geografia di Tolomeo il cui influsso risultò piuttosto evidente, ad esempio, nel disegno della rete idrografica settentrionale e del bacino del Nilo, come nel caso dei mappamondi a cuore di Bernardo Silvano e di Pietro Apiano del 1520 e del primo mappamondo del Mercatore (1576) (25).
Proprio per ovviare ai limiti ed alle approssimazioni di queste opere che non esitava a definire “molto imperfette rispetto alla gran cognizione che si ha oggi” dell’Africa e dell’India, il Ramusio, che all’Africa avrebbe riservato parte del primo volume della sua raccolta di viaggi (26), inserendovi anche la lettera inviata al padre nel 1504 dal mercante fiorentino Giovanni da Empoli contenente una delle prime descrizioni degli Ottentotti (27), affermava, nella dedica della sua opera a Gerolamo Fracastoro, di
“aver stimato dover essere caro e forse non poco utile al mondo il mettere insieme le narrazioni degli scrittori de’ nostri tempi che sono stati nelle sopradette parti del mondo e di quelle han parlato minutamente, alle quali aggiungendo la descrizione delle carte marine portoghesi, si potrian fare altrettante tavole che sarebbero di grandissima satisfazione a quelli che si dilettano di tal cognizione, perché sarian certi dei gradi, delle larghezze almanco delle marine di tutte queste parti, e de’ nomi di luoghi, città e signori che vi abitano al presente, e potriano conferirle con quel tanto che ne hanno scritto gli autori antichi” (28).
Ma, nonostante le intenzioni del Ramusio, anche nel Cinquecento continuarono ad imporsi ed a circolare immagini preconfezionate che si sarebbero mescolate con i dati acquisiti attraverso l’esperienza diretta e con le elucubrazioni della fantasia, per cui l’Africa, che Leon Battista Alberti definì terra di “mostri” e di “portenti”, nella quale poteva trovare ospitalità ogni stranezza, ogni aberrazione, ogni anomalia, sembrò resistere ostinatamente, come ha sottolineato Alessandro Triulzi, alla conoscenza di sé, in quanto “la sua esuberanza di clima, di razze e di costumi ‘altri’ disorienta gli osservatori europei, così come […] aveva disorientato alcuni secoli prima i viaggiatori arabi colti (al-Umasi, al Bakri, o ibn-Battutah) che li avevano preceduti”, poiché “per entrambi l’immaginario, l’onirico, il fantasioso, la ‘scienza delle meraviglie’ (‘ilm ‘aja ib) sembra imporsi, e a volte correggere, la stessa realtà visitata” (29).
Il fatto è, secondo Gino Benzoni, che “la navigazione oceanica, i peripli costieri, gli avviati commerci, l’iniziato sfruttamento, le postazioni stabili, gli affondi nel territorio, le risalite più o meno titubanti del corso dei grandi fiumi, i sondaggi per ulteriori penetrazioni, le sbirciate sempre meno timide verso l’interno non tagliano di netto col chiacchiericcio antico e medievale, non tacitano d’un tratto una semisecolare vociferazione. Le storie producono così altre storie, la favole ridondano in mille altre favole”. La cultura e l’erudizione di quel periodo procedono infatti in avanti dal punto di vista della conoscenza “non senza alleggerirsi del fardello dei vetusti giudizi e, semmai, zavorrandolo di nuovi pregiudizi e, comunque, adeguando ora questi ora quelli sia distintamente sia, anche, congiuntamente. Donde non già l’interruzione e l’accantonamento del flusso affabulatorio proveniente dal passato…”, che invece “via via cresce, ché l’Africa non è più racchiudibile in forme univoche, ma si sfaccetta in immagini contraddittorie: piramidi e casupole; grandi città e minuscoli villaggi; paganesimo ostinato e ‘habitatori facili al cristianesimo’, schiavitù ed indomita fierezza; elaborate manifatture e agricoltura e pastorizia primitive; immensi ‘tesori’ e abissi di miseria; ‘ottimi frutti’ spontanei e sabbie senza fine; sole implacabile e piogge diluviali; deserti e foreste; giganti e pigmei; nudità malamente coperte di stracci e ‘vestire pomposo’. E, nel crescere, si complica e s’intorbida per l’interferire, l’intrecciarsi, il confondersi, il moltiplicarsi delle motivazioni – ora implicite ora esplicite, chiaramente enunciate ora camuffate e mistificate – d’un approccio aggressivo all’interno del quale ribollono e premono avidità di guadagno, spirito d’avventura, esasperate curiosità, brama di dominio, sete di conoscenza, zelo missionario” (30).
A questo tipo di approccio e di interpretazione della realtà africana corrispondono anche le due più importanti relazioni pubblicate su alcune zone dell’Africa nel corso del Cinquecento. Vale a dire la Descrizione dell’Africa e delle cose notabili che ivi sono, redatta in italiano, probabilmente prima del 1523, anche se poi fu aggiornata fino al 1526 da Hasan ben Mohammed al-Wazzan al-Zaiyati, un dottore della legge coranica nato a Granada attorno al 1485, ma cresciuto a Fez, dove la sua famiglia si era rifugiata nel 1492 e “donato” a papa Leone X che lo fece battezzare nel 1520 col nome di Giovanni Leone, dopo essere stato condotto come schiavo a Napoli dai pirati cristiani che avevano catturato la nave sulla quale viaggiava nei pressi delle coste tunisine; e la Relatione del Reame del Congo et delle circumvicine contrade, compilata nel 1591 da Filippo Pigafetta, sulla base degli “scritti et ragionamenti” di un mercante portoghese, Duarte Lopes, vissuto per dodici anni nel Congo, il cui re lo aveva inviato nel 1589 come ambasciatore presso la Santa Sede.
Divulgato da Giovanni Battista Ramusio, che nel 1550 lo inserì nel primo volume della sua raccolta, dopo averlo sottoposto, come lui stesso ci fa sapere, “a non pochi cambiamenti di stile e di contenuto”, il contributo di Leone l’Africano, celebrato da Jean Bodin come “le seul historien à avoir découverte l’Afrique en (31) sevelie depuis mille ans dans une triste barbarie et dans l’oubli des autre hommes” ed a “l’avoir révélée à la conscience universelle”, per quanto significativo per l’area alla quale fa riferimento (Berberia, Numidia, Libia e Terra dei negri), per cui l’Africa islamica, dove nessun europeo riuscirà a penetrare fino all’inizio dell’Ottocento, sarebbe diventata, per un paio di secoli, più conosciuta delle regioni estreme, sia settentrionali sia orientali, della stessa Europa (32), si limita alla zona compresa tra l’Oceano, il Sudan, la riva sinistra del Nilo ed il Mediterraneo. Del resto, per quanto dotato di strumenti culturali che gli permisero di scegliere, nel bagaglio delle proprie nozioni ed esperienze, quelle che più potevano essere utili ad una conoscenza non superficiale (basti pensare all’attenzione da lui riservata a tutti gli aspetti della cultura materiale dei paesi che ebbe la possibilità di visitare direttamente), anch’egli si affidò in diverse circostanze alle descrizioni di autori più antichi; ed, in ogni caso, l’Africa equatoriale, anche quando vi fece riferimento, gli rimase del tutto estranea, dal momento che gli apparve abitata da popolazioni non strutturate in compagini statali, piene di vizi e non partecipi di alcuna forma di civiltà (33).
Una riscrittura, che conobbe una particolare fortuna, soprattutto in Francia, della Descrizione dell’Africa di Leone l’Africano si può considerare la Descripcion general de Affrica redatta in lingua spagnola da Luis de Marmòl y Carvajal, originario di Granada, dove venne pubblicato il primo volume nel 1573 (il secondo apparve a Malaga nel 1592), e che Oumelbanine Zhiri non ha esitato a definire “une étape importante dans l’evolution da la lecture de Léon comme dans celle de la vision d’Afrique” (34) per l’opera di revisione, integrazione ed aggiornamento operati dallo scrittore spagnolo che nel 1556 aveva preso parte ad una spedizione allestita dal sultano del Marocco per conquistare l’impero Songhay del Sudan, rispetto al testo sul quale si era largamente basato, col ricorso ad un certo numero di autori che si inseriscono nel patrimonio delle conoscenze europee dell’Africa, con particolare riguardo agli abitanti della Barberia per i quali ha fatto ricorso alle fonti arabe.
Al di là delle informazioni precise e puntuali, come quelle relative ai porti delle coste dell’Africa compresi tra la foce del Congo ed il Mar Rosso, o alla fauna ed alle condizioni climatiche ed ambientali, che sarebbero servite a colmare vuoti e lacune che neppure un secolo di rapporti e contatti politici e religiosi con quel territorio erano riusciti ad eliminare, anche la Relatione del Pigafetta, di cui abbiamo già ricordato il viaggio in Egitto, dettata principalmente dall’obiettivo di esaminare la possibilità di diffondere il Cristianesimo in un Congo già segnato dalla volontà divina con miracoli e prodigi facendo vedere come, per aggirare il Gran Turco, da questo territorio si potesse arrivare al regno del Prete Gianni attraverso un reticolato idrografico particolarmente adatto allo scopo, presenta un mondo popolato da antropofagi che mangiano solo gli amici e tigri che divorano solo i negri, nonché da crudeli guerrieri che vagano su strani “legnetti” e dalle Amazzoni, un corpo regolare del Monemuci (“re dell’acqua”), sovrano di un regno situato a Nord-Est di quello del Congo.
Frutto di una rielaborazione di notizie riferite da altri, in un gioco di specchi tra l’esperienza dell’intervistato e la cultura dell’intervistatore, permeata quest’ultima dal sostrato scientifico, politico e sociologico della cultura europea di fine Cinquecento, anche Pigafetta ci propone un’Africa simbolica che si accinge a diventare luogo geometrico di tutte le velleità espansionistiche; un’illusione doppiamente “falsa”, in quanto “narrata” e “riscritta” su disparati livelli di senso: un fantasma destinato a dominare nei secoli l’immaginario occidentale e che lo incatenerà alla dimensione di feticcio etnologico, adorato e odiato sull’altra scena dell’ossessione coloniale. Da questa relazione – concludeva Giorgio Raimondo Cardona – alla Heart of Darkness, alle Impressions d’Afrique, au Voyage au Congo non c’è che uno stesso percorso, scandito da obbligatori atti di devozione, teso da un continuo sforzo di misurarsi non con quello che dall’Africa vediamo, ma quello che dell’Africa già sappiamo, di riempire quel simulacro-portolano che “infine ad ora niuno ha così ben rappresentato” (35).
Così quando Duarte Lopes gli parla di animali che non potevano non sembrargli fantastici, Pigafetta, mescolando cultura e realtà, ci propone come credibili descrizioni di mostri che nulla avevano di vero se non la loro derivazione dalle fantasie e dai testi della cultura classica e medievale:
“Vi sono anco certi altri animali che grandi quanto un montone a guisa di Draghi hanno le ali e la coda e il muso lungo con diversi ordini di denti, e mangiano carne cruda: e il suo colore è azzurrino e verde, e la pelle hanno dipinta in maniera di scaglie, con due piedi, li negri gentili sogliono adorarli come Dei e ora se ne veggono alcuni serbati da loro in meraviglia e per essere molto rari conservansi dalli signori i quali li lasciano ancor adorare da’ popoli con loro grande profitto e oblazione, che loro porgono” (36).
Come ci ha fatto notare Ezio Bassani nel suo commento al catalogo di una mostra sull’immagine dell’Africa nera e degli Africani nelle illustrazioni europee dal Cinquecento al Settecento, anche le due carte geografiche e le otto tavole fuori testo che arricchiscono la prima edizione della Relatione del Pigafetta “esemplificano in modo paradigmatico la mescolanza della realtà descritta da un testimone con la fantasia di un sedentario”. Lo si può notare da tre tavole (la sesta, la settima e l’ottava) che illustrano il trasporto di persone in uso allora nel Congo secondo sistemi che trovano riscontro in altre testimonianze coeve e che appare riprodotto pure in manufatti congolesi del secolo scorso, nelle quali la scena è “ambientata in un paesaggio montagnoso tipicamente europeo e, soprattutto, hanno tratti tutt’altro che africani e troverebbero posto senza stonatura in un’immagine di Roma antica dipinta nel Rinascimento, sia per la posa monumentale dei trasportatori e del trasportato, nobilmente atteggiato, sia per la resa della muscolatura e del panneggio”. Statuarietà classicheggiante ancora più evidente nelle tavole tre e quattro nelle quali sono illustrati degli abiti maschili e degli abiti femminili: gli uomini sono dei signori rinascimentali e le dame sono delle nobili matrone romane su uno sfondo di città turrite tipiche dell’Europa settentrionale” (37).
In un contesto del genere saranno le opere di alcuni cartografi a raccogliere ed a fornire le informazioni più attendibili ed aggiornate sull’Africa, allontanandosi gradualmente dall’impostazione tolemaica, come nel caso de Il disegno della Geografia moderna de tutta la parte dell’Africa che Giacomo Gastaldi, cartografo che ebbe stretti rapporti di collaborazione ed amicizia col Ramusio, aveva cominciato ad elaborare nel 1545-1546, per inciderlo poi nel 1564, dando inizio alla cartografia moderna sull’Africa. In questa carta sono indicati infatti più di seicento toponimi costieri tratti in prevalenza dalle carte di tipo nautico portoghesi, completati, per la parte mediterranea e marocchina, da quelli desunti dalla Descrizione dell’Africa di Leone l’Africano, e sono riprese anche le informazioni fornite dalla prima decade del Barros, da Andrea Corsali, da Duarte Barbosa, da Alvise Ca’ da Mosto e dalla relazione del viaggio in Etiopia di Francisco Alvares (38). Fonti queste alle quali si sarebbe rifatto pure un altro veneziano, Marco Livio Sanudo, del quale nel 1588 apparve postuma una Geografia in dodici libri completata dieci anni prima, nelle cui tavole relative all’Africa molti fiumi, che il Gastaldi aveva messo in collegamento col Nilo, formavano invece un sistema idrografico autonomo che sfociava nell’Oceano Indiano a sud della Somalia (39).
Quasi contemporaneamente a quella del Gastaldi apparve la carta del mondo del 1569 di Gerardo Mercatore, nella quale la raffigurazione dell’Africa, per quanto non del tutto corretta, denotava un generale miglioramento rispetto a quella del cartografo piemontese, di cui venne tuttavia utilizzata la toponomastica relativa ai regni meridionali ed alla zona costiera (in particolare dell’Etiopia), soprattutto per quel che concerne la rete idrografica del Nilo (40).
Se la cartografia cerca pertanto, sia pure con alcune incertezze ed approssimazioni, di tenersi in linea di massima al passo con le nuove conoscenze prodotte dall’intensificarsi dei rapporti commerciali, politici e religiosi col continente africano, le stesse esigenze di aggiornamento non sembrano invece presenti nella trattatistica storico-geografica di questo periodo, che recepì, alimentò e diffuse di conseguenza un’immagine dell’Africa che, secondo Marica Milanesi, poteva e doveva “servire” all’Europa, sia “in senso commerciale e politico, ma anche in senso profondo come luogo di proiezione di ansie, bisogni, sicurezze o illusioni collettive” (41).
Per trovare ampi riscontri a questa considerazione basterà passare in rassegna le principali cosmografie del periodo rinascimentale, come quella di Guillaume Le Testu che, sulla scia dei mappamondi medievali, nella sua Cosmographie universelle, pubblicata nel 1556, popolò le zone interne dell’Asia e dell’Africa di Blemmi, Sciapodi ed Arimaspi. Per questo pilota di Le Havre, l’Africa ospitava serpenti di settecento piedi di lunghezza, capaci di ingoiare capre e buoi; basilischi che potevano uccidere uomini coi loro sguardi; satiri; uomini senza testa; cinocefali o colopedes. Lo stesso si potrebbe dire per la Suma de Geografia, pubblicata a Siviglia nel 1519, di Castellan Martin Fernandez de Enciso, che a partire dal 1507 soggiornò alcuni anni a Mombasa, ma che, come ha fatto notare L. Morales Oliver, collocò nella Sierra Negra “hombres con cabeza de ferro que ladran, hombres sin cabeza” e collocò “sin embargo, en las tradiciones, tantas cosas raras, entre ella la existencia de hienas que un año son machos y otras hembras, hienas que, ademàs, hablan como los pastores, y se ponen a hablar y los engañan. Hienas que tienen la virtud de que quando ven un perro y se lo quierera comer, lo primero que hacen es mirarlo y o deján quieto; luego le proyectan su sombra, y entonces el perro ya no puede ladrar e inmediatamente lo rodean y lo dejian como de pietra y asì los devoran” (42).
Ed anche Sebastian Münster, che dedicò all’Africa il sesto ed ultimo libro della Cosmographia universalis, pubblicata a Basilea in tedesco nel 1544 e poi in latino nel 1550, sostenne che nessuna terra presenta “bestes qui soient si dangereuses comme en la seule Afrique” e sottolineò come le aree interne di questo continente fossero in larga parte sconosciute perché “située soubz la cinture brulante” (43). A sua volta Giovanni Botero, nel riferirsi ai Cafri nel terzo libro della prima parte delle sue Relazioni universali, che ebbero una larga diffusine in tutta Europa, scriveva che
“Non hanno terre, ma sparsi per le selve e per li mondi, vivono più presto a guisa di bestie, che di uomini; crudeli, nemici di ogni natione, dediti alle stregherei, e a gli augurii; et si come nella Barberia i Nazamoni, così costoro corrono, quali uccelli di rapina, là dove rompe qualche nave et si pascono delle miserie de’ naufraganti” (44).
Attorno alla metà del Cinquecento queste immagini circolavano anche in Inghilterra, dove erano disponibili riassunti e traduzioni dell’opera di Plinio che, assieme all’Omnium Gentium mores, leges et ritus di Giovanni Boemo (1520), venne utilizzato sia in The Fardle of Fashions di William Prat, un’opera in cui viene concesso largo spazio alla fantasia, situando all’interno del continente africano gli Acridofaghi (che si cibavano di cavallette), gli Ittiofagi, gli Ilofagi, i Spermatofagi, ecc. Elementi fantastici presenti anche nei resoconti dei viaggi in Guinea ed al Benin, promossi da alcuni “mercanti avventurieri” londinesi, di Thomas Wyndham nel 1553 e di John Lock ad Elmina nel 1545-1555, raccolti e pubblicati da Richard Eden, che premise ad essi una breve descrizione dell’Africa, nella quale pure sono frammisti elementi credibili con vecchie credenze, come nella descrizione delle coste del re del Benin comprendente anche alcuni riferimenti al leggendario Prete Gianni (45) .
Nonostante lo sviluppo dei viaggi di esplorazione e delle iniziative commerciali e l’avvio di rapporti politici e religiosi, l’Africa avrebbe così continuato ad essere, agli occhi degli Europei, “la terra dove può trovare compenso l’imagerie che attinge ai repertori del mai visto, del non percorso, dove i mostri più inverosimili prodotti dalla fantasia umana possono trovare un corrispondente fisico quasi reale, che l’occhio umano può ammirare stupefatto, dopo aver creduto che potessero esistere solo come visioni frutto di una fittizia, ma indispensabile, allucinazione”. Infatti “anche gli esploratori che riescono ad andare direttamente in loco si vedono molto spesso costretti a dar corpo narrativo alle esperienze e ai fenomeni più strani, pur precisando che essi non sono frutto di esperienza diretta ma di racconti raccolti fra gli indigeni. Molto spesso però, la frase dubitativa che accompagna la narrazione ha una tendenza ad essere tralasciata ed annullata dai lettori che tramandano il racconto come vero: da ciò l’assoluta fiducia nella veridicità dei fenomeni apparentemente più surreali” (46).
La mentalità europea, prigioniera di una concezione fantasmagorica, avrebbe pertanto teso a cogliere ed a rappresentare con orrore nel continente africano “le chaos originel toujours a l’oeuvre, son mélange des éléments et des règnes, son indistinction entre la vie et la mort” ed avrebbe riconosciuto, non senza terrore, nei suoi abitanti “le visage des ses propre ancêtres tels qu’ils les imaginait, participant ancore de la bestialité, ne disposant que d’un langage inintelligible et confus, quasi inexistant, émergeant des profondeurs d’une terre perfide et ennemie des hommes, partageant leur territoire avec des animaux sauvages tout puissants”. In sostanza “une anti-Europe, un anti-monde”, che “renvoyait l’image angoissante de ce que le monde et l’Europe avaient été” (47): una terra di tutte le ombre che si agitano nel nostro passato e nella nostra cattiva coscienza. In questo modo l‘immaginazione riuscì quasi sempre ad annullare l’immagine e vecchi miti e pregiudizi vennero riproposti e resi ancora una volta credibili, a cominciare dall’impercettibile confine che separava il mondo umano da quello animale e dal motivo dell’antropofagia e della sfrenatezza sessuale di cui veniva assunta a simbolo la diffusione della poligamia, per passare alle forme di organizzazione politica e sociale presentate quasi sempre come manifestazioni irrazionalmente autoritarie e coercitive anche quando l’esercizio del potere ed il suo significato rientravano in un sistema di tradizioni politiche e religiose e di equilibrio di forze consolidate nei secoli che risultava però incomprensibile alla mentalità dei colonizzatori (48).
Di conseguenza non si può considerare casuale che un filosofo francese, Scipion du Pleix, cercasse di spiegare, all’inizio del Seicento in un capitolo sui mostri di un suo trattato sulla “physique ou science des choses naturelles” (49), perché il continente nero pullulasse di esseri mostruosi, sostenendo che in Africa “toutes sortes d’animaux se trouvent ensembles pres des eax pour boire s’y accouplent ordinairament sans discretion d’espece: et de tels accouplements ne peuvent anitre que des monstres” (50); e che un viaggiatore italiano, Francesco Negri, esortasse i suoi lettori a scegliere ed a percorrere soltanto itinerari europei dopo aver affermato “che novità porta quella [Africa] se non di orribili draghi e mostruosi serpenti” (51).
A tutti i livelli l’Africa, terra ostile e rifiutata, sarebbe diventata il simbolo di ogni forma di degenerazione e della maledizione che non risparmia nulla, neppure il suo clima che, secondo Jules Joseph Virey, “annerisce secca e carbonizza, per così dire, gli uomini, gli animali e le piante esposte ai suoi ardenti raggi”, per cui l’uomo diventa un negro e, come lui, “il gatto, il bue, il coniglio si anneriscono in egual misura. La pecora abbandona la sua lana bianca e setosa, per diventare irta di peli fulvi e duri come crine (52). La gallina si copre di piume di un nero scuro (53)”. Un clima, secondo un inglese impegnato, all’inizio del Seicento, nella tratta degli schiavi nella zona del fiume Gambia, ammorbato da esalazioni venefiche prodotte “sia dai vegetali infetti, sia da un’infinità di animali velenosi, come i rospi, gli scorpioni ed i serpenti” (54). Ma anche chi, come il gesuita Alonso de Sandoval, si dimostrerà preoccupato dell’educazione religiosa e della salvezza degli schiavi prelevati lungo le coste dell’Africa, in un trattato, dal titolo De instauranda Aethiopum salute, pubblicato a Siviglia nel 1627, ribadirà la convinzione della presenza di mostri (basilischi, dragoni, liocorni, pegasi, leucrocote, ecc.) sul continente africano continuando ad attingere ampiamente alle tradizioni classiche ed agli scritti dei Padri della Chiesa (55).
In particolare, poiché solo dall’immoralità e dalla brutalità dell’Africano, come pure dall’irrazionalità del mondo e dell’ambiente che lo circondavano, poteva scaturire la giustificazione di un fenomeno devastante come la tratta, numerosi testi a avrebbero contribuito a diffondere nel corso del Seicento e del Settecento, quando smisurate ricchezze si andarono accumulando assieme a stereotipi e pregiudizi dettati e giustificati dal persistente richiamo alla maledizione contro Cam e i suoi discendenti (56), un ritratto tendenzialmente negativo della complessa ed articolata realtà del mondo africano, insistendo in maniera particolare su quegli aspetti delle sue manifestazioni culturali che, presentando una maggiore estraneità alle convenzioni sociali europee, fornivano eccellenti e facilmente persuasivi esempi di sauvagerie da combattere e sradicare (57).
Lo avrebbe continuato a fare ancora alla fine del Settecento, dopo ormai tre secoli di presenza europea lungo le coste nord-occidentali dell’Africa e nei territori immediatamente retrostanti, uno dei tanti colonizzatori che operarono in quel contesto, Archibald Dalzel, inizialmente (a partire dal 1763) chirurgo in Costa d’Oro al servizio della Compagnia dei Mercanti che commerciava con l’Africa, che nel 1767 lo nominò direttore del forte di Whydah, sulla costa degli Schiavi, allora principale sbocco del commercio del Dahomey, e nel 1791 lo designò governatore di Cape Coast Castle, autore di una History of Dahomy, pubblicata a Londra nel 1793, redatta sulla scorta del materiale fornitogli da un suo predecessore, Lionel Abson.
La History of Dahomy risulta essere infatti prima di tutto, come tanti altri testi che la avevano preceduta (58), un trattato a sostegno e giustificazione della riduzione in schiavitù degli Africani (59) fondata su stereotipi e paure da sempre nutriti ed alimentati nei confronti del diverso che tendevano a metterne in evidenza la presunta irrecuperabilità culturale ed etica, di cui in questo caso i comportamenti e gli atteggiamenti (pigrizia, violenza, crudeltà, mancanza di coraggio, superstizione, ecc.) della popolazione del Dahomey, “educata unicamente alla guerra ed alla razzia”, sembravano offrire, spingendosi fino all’accenno ad una forma di antropofagia rituale associata al sacrificio umano, eloquenti esemplificazioni che dovevano rimarcare la differenza, compresa quella del colore della pelle, intesa automaticamente come segno di inferiorità perchè, secondo Dalzel, “lo stesso Grande Essere creò entrambi, e dal momento che gli è sembrato opportuno distinguere l’umanità con opposte carnagioni, presumere che possa esservi una altrettanto grande discordanza nella natura del loro pensiero è una corretta conclusione” (60).
“Dalzel, quindi, – ha sottolineato Cinzia Miotti -, difettando di criticità nel suo etnocentrisomo, spontaneamente o, più spesso, intenzionalmente, finiva col rapportare i valori della società analizzata ai parametri comportamentali, speculativi e religiosi occidentali, allo scopo di negarne la razionalità” e tutto ciò generava ovviamente oscurità ed incomprensione nei confronti dei caratteri originari della cultura in questione; però è e proprio a questo riguardo che forse si può valutare l’apporto dell’History of Dahomy, come di tante altre opere sulla realtà africana elaborate in quel periodo che proprio per questo continuano a restare utili ed interessanti, alla comprensione degli effettivi influssi esercitati dall’attività e dalla presenza europea sui sistemi indigeni, perché, nonostante i limiti evidenti di questi scritti, “è indubbio che l’esperienza africana dei mercanti di schiavi è stata estremamente più importante di quella che si poteva avere nel contatto con Africani in Europa o all’interno del sistema delle piantagioni in un periodo in cui le istituzioni sociali e culturali africane non erano ancora state sconvolte dal colonialismo”, per cui l’opera del Dalzel e di tanti altri autori si impone e si raccomanda anche come preziosa “testimonianza di un rapporto avuto con Africani non come individui isolati, o come massa abbrutita e ribelle, ma come nucleo indigeno all’interno di un più vasto sistema comunitario”, dalla quale, indipendentemente dalla ideologia che spesso li richiama e li ricorda solo a scopo di condanna e di derisione, riescono ad emergere, nonostante tutto, i valori culturali (61).
E’ una considerazione questa che si può senz’altro estendere, tenendo naturalmente conto delle specificità di ogni singolo testo, all’intero corpus, che si presenta piuttosto consistente rispetto a quelli prodotti fra il Cinquecento ed il Settecento per altre aree del continente africano (62), delle testimonianze relative ai territori che si affacciano sul Golfo di Guinea (63), a cominciare dal resoconto, pubblicato ad Amsterdam all’inizio del Seicento (Beschrijvinghe ende historische vrehael van het Gout Koninckrijk van Gunea anders de Gout-Couste de Mina Genaemt Leggende in Het Deel von Africa), della spedizione in Costa d’Oro compiuta per finalità commerciali, fra il gennaio 1601 ed il gennaio 1602, dal fiammingo Pieter de Marees, comprendente anche una descrizione dell’emporio di Bénin firmata da D. R. (probabilmente Dierick Ruiter, un marinaio zelandese che fra il 1627 ed il 1634 prese parte a quattro spedizioni commerciali nel Senegal) ed un’altra anonima dell’estuario del Gabon e di Capo Lopez: un resoconto inserito subito nella famosa raccolta, corredata da un ricco apparato di incisioni su rame, di Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et occidentalem edita fra il 1590 ed il 1634 prima da Théodore de Bry e poi dai suoi figli Jean Théodore e Jean-Israèl (64).
Quest’opera, che fornisce diverse informazioni di carattere etnografico (comprende anche una piccolo vocabolario Duyts-Guneets) e di interesse commerciale e si sofferma in maniera puntuale sui villaggi del litorale sulla base delle esperienze dirette del suo autore integrate da alcune descrizioni ispirate dal capitolo sulla “descrizione della Guinea, del Congo, dell’Angola e degli altri paesi costieri dell’Africa” della Navigatio et Itinerarium in Orientalem Indiam di Jan Huyen von Linschoten, pubblicata ad Amsterdam fra il 1595 ed il 1596, può essere considerata infatti un vero e proprio prototipo, dal momento che per oltre un secolo avrebbe costituito, secondo una prassi allora largamente diffusa, un punto di riferimento, spesso al confine col plagio (65), per la gran parte dei resoconti successivi. I suoi elementi sostanziali sarebbero infatti rifluiti, ancora nel 1730, nel Voyage du chevalier Des Marchais en Guinée, isle voisines, et à Cayenne fait en 1725, 1726 et 1727 redatto di Jean Baptiste Labat che, come precisa il sottotitolo, conteneva “une Description très exacte et très Ètendue de ces Pais e du Commerce qui s’y fait, enrichi d’un grand nombre de Cartes et Figures en tailles”, e delle cui fonti Karine Delaunay ci ha fornito un preciso albero genealogico che, sia pure assimilando arbitrariamente “plagiats et influences presque inconscientes d’un auteur sur un autre”, fa emergere in maniera chiara “l’imbrication des chaînes de transmission successives” (66).
E’ stato così possibile a Karine Delaunay mettere chiaramente in evidenza il meccanismo che ha alimentato, in questo come in altri testi dello stesso genere, la costruzione e la diffusione di una serie di informazioni che, assieme ad un corredo di immagini trasmesse anch’esse da un testo all’altro, si sono imposte e consolidate, in questo caso, attraverso la pubblicazione di opere come quelle di Arnout Leers (Pertinente beschryving van Africa… getrocken en vergader uyt de resboeken van Johannes Leo Africanus, Rotterdam, 1665); Nicolas Villault de Bellefond (Relation des Costes d’Afrique appelées Guinée, avec la description du pays, moeurs et façons de vivre des habitants, des productions de la terre et de marchandises qu’on en apporte, avec des remarques historique sur ces costes…, Parigi, 1669), frutto di un viaggio commerciale compiuto nel corso del 1666 e 1667 a bordo di una nave condotta da un equipaggio olandese; Godefroy Loyer (Relation du voyage du Royaume d’Issiny, Côte d’Or, pays de Guinée, en Afrique, Parigi, 1714), un missionario domenicano che dal giugno 1701 al marzo 1703 soggiornò ad Assini con l’incarico di Prefetto Apostolico della Guinea (67); e soprattutto di un medico e geografo danese, Olfert Dapper (Nauwkeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten van Egypten, Libyen, Biledulgerid, Negrosland, Guinea, Ethiopia, Abyssinie, Amsterdam, 1668).
Quale fosse stato, a sua volta, il consistente debito di quest’ultima opera di mera compilazione nei confronti della preesistente letteratura sull’argomento, dopo che erano stati ringraziati “ceux qui veulent bien se donner la peine de lire plusieurs Auteurs, qui traitent de la même matiere, de ramasser judicieusement ce que chacun a de particulier, & d’y ajoûter les découvertes qu’on a faites soi-même sur ce sujet”, dal momento che “les Auteurs ne faisent pas grand’conscience de se copier les une les autres (68); & ceux qui viennent après commettent d’ordinaire les mêmes fautes, que ceux qui ont précedez”, veniva messo esplicitamente in evidenza dalla Prefazione all’edizione francese del 1686:
“Il a eu la patience – si sottolineava infatti a proposito del Dapper – de lire un nombre prodigieux de Geographes & de Voyageurs Anciens & Modernes, Latins, François, Espagnols, Italiens, Anglois & Flamans, outre une description manuscrite de la côte des Caffres, qui a été presque inconnue jusques à present, & dont on trouvera ici une relation assez circonstantiée. Toute celle du pais de Negres est aussi fort exacte, & je ne pense pas qu’on en ait de sembrarle en nôtre Langue” (69).
Un elenco posto subito dopo la Prefazione fornisce una lista di sessantotto autori ai quali il Dapper, che risulta non essersi mai avventurato in Africa essendosi basato soprattutto sulle relazioni e le fonti avute da influenti membri della WIC, avrebbe attinto: un elenco che, accanto ai geografi dell’antichità classica, tra cui non figura peraltro quello di Erodoto, ed autori ai quali tutti avevano continuato ad attingere come Leone l’Africano e Filippo Pigafetta, comprende numerosi olandesi. In questo modo, “mutuando spesso di sana pianta – come ha sottolineato Teobaldo Filesi, che dimostra di apprezzare soprattutto l’attenzione del Dapper per l’ambiente naturale, oltre che per gli usi, costumi e strutture tradizionali dei singoli paesi – da questo o da quell’autore, egli riesce a darci una composizione del continente con l’abilità artigianale del mosaicista” senza che in nessuna parte del suo ponderoso lavoro di lettura, selezione e ricompilazione, di cui sono evidenti i limiti di originalità ed organicità, dia “l’impressione di dire o di aggiungere gran che di proprio”, per cui “se talune parti del disegno sono più rifinite e più chiare il merito è da attribuire […] più alla fonte utilizzata che non al Dapper” e “dove è mancata la possibilità di avvalersi di testi più circostanziati, il tessuto mostra una trama meno robusta o addirittura labile” (70).
Su queste basi, dopo aver trattato dell’Africa in generale in un capitolo iniziale di circa trenta pagine, Dapper dedica uno spazio ben più ampio alle regioni dell’Africa settentrionale (dall’Egitto ai regni del Marocco, di Fez, di Algeri, di Tunisi e di Tripoli) per passare poi alla regione sahariana ed all’Africa nera scendendo via via dal Golfo di Guinea al Congo, all’Angola ed all’Africa meridionale prima di occuparsi della parte orientale fino all’Etiopia. Una certa attenzione viene dedicata alla trattazione delle isole (in particolare del Madagascar), fra le quali vengono curiosamente inserite anche Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria.
A metà strada fra il resoconto di viaggio, che si propone di mettere in evidenza i frutti dell’esperienza diretta acquisita nel corso di tredici anni di presenza in diverse postazioni della Costa d’Oro, e l’opera di compilazione si presenta invece un’altra delle più note e diffuse relazioni sulla Guinea redatte all’epoca della tratta, la Nauwkeurige beschryvinge van de Guinese Goud- Tand-en Slave-Kust, una sorta di apologia dell’attività svolta per conto della WIC, pubblicata ad Utrecht nel 1704, sotto forma di ventidue lettere (71) inviate dall’Africa ad un amico, dall’olandese Willem Bosman, il quale ammette, nella sua Prefazione, di avere sempre amato i buoni libri e tra questi le storie e le relazioni di viaggio da cui si possono ricavare elementi estremamente utili, dal momento che grazie ad esse si possono conoscere i nomi dei popoli stranieri e soddisfare quella curiosità che sembra essere connaturata a tutti gli uomini:
“Mais si j’avais une forte passion pour le voyages écrits avec fidélité, je n’avais pas moins d’aversion – precisava poi – pour ceux dont les Auteurs débitent des mensonges pour des vérités; car, comme ils n’ont jamais sorti de leur pays, ils reçoivent comme véritable tout ce qu’on leur dit des pays étrangers sans l’examiner […]. Je dirai que parmi toutes les raisons que j’ai eues de quitter l’Europe, la lecture des Voyages a été le principal motif qui m’y a oblige, ayant fait naître en moi la curiositè d’examiner par moi-même la vérité de ce que j’avais lu […] (72)
Questo rapporto fra fonti letterarie ed esperienza diretta ha orientato, in proporzioni e forme di volta in volta diverse, i contenuti e le chiavi di approccio alla realtà africana anche di opere come quelle di Jacob de Lange (Demonomanie of(te) Der Mooren Wonderheden: zjinde een verhael, of voiague nae het Moorse Koninckrijk van Guinea, Amsterdam, 1658), che compì un viaggio in Guinea e sulla Costa degli Schiavi fra il 1621 ed il 1622; Michael Hemmersam (Guineische und West Indianisch reissbeschreibung de An 1639 biss 1645 von Amsterdam nach St Joris de Mina, Norimberga, 1663), un orafo di Norimberga che soggiornò dal 1639 al 1645 a Sao Jorge de Mina come soldato prima e responsabile poi della WIC; Wilhelm Johan Muller (Die afrikanische auf der guineischen Gold-Cust gelegene landschafft Fetu, Amburgo, 1673), un pastore luterano di Hannover, che dal 1662 al 1669 visse a Frederiksborg (forte danese ad oriente di Cape Coast) come predicatore per gli impiegati della Compagnia danese per l’Africa (Compagnia di Glückstadt); Otto Friedrich von der Groeben (Guinesche reisebeschreibung, nebst einem anhange der expedition in Morea, Marienwerder, 1694), che visitò diversi villaggi del Cap des Trois Pointes fra il 1682 ed il 1683 per trovare la località adatta a fondare un forte per l’elettore del Brandeburgo; Eric Tilleman (En liden enfolding beretning om det landskab Guinea, Copenaghen, 1697) che, dopo essere stato luogotenente del forte danese di Christianbourg ad Accra, della cui regione fornisce un’importante descrizione, all’inizio del 1690, vi fece ritorno nel 1697-1698 per ristabilirvi l’ordine e rilanciare il commercio; James Houstoun (Some new and accurate observations… (on) the Coast of Guinea, Londra, 1725), un medico inglese che, su incarico della Royal African Company, nel corso del 1722 visitò tutti i forti della Costa d’Oro per ispezionare gli schiavi venduti; Nathaniel Uring (A history of the voyages and travels of capt. Nathaniel Uring, Londra, 1726), un inglese che tra il 1711 ed il 1712 viaggiò lungo la Costa d’Oro e la Costa d’Avorio; William Smith (A new Voyage to Guinea, Londra, 1744), un agrimensore inglese che nel 1726 venne incaricato dalla Royal African Company di redigere la planimetria degli stabilimenti della Costa d’Avorio e della Costa d’Oro ed eseguire i disegni di queste coste; e Francis Moore (Travels into the inlands parts of Africa; containing a description of the several nations for the space of six hundred miles up to the river Gambia, Londra 1738):
“Scrissi il diario – faceva presente nella presentazione della sua relazione, nella quale venne dedicato ampio spazio all’organizzazione politica e sociale dei Mandingo, questo agente della Royal African Company presso James Fort, la più solida ed estesa delle stazioni commerciali della Compagnia sul fiume Gambia, dove visse dal novembre 1730 al maggio 1735, rivendicando, come erano soliti fare tutti questi viaggiatori, l’autenticità e l’originalità della loro testimonianza solitamente contrapposte alla scarsa attendibilità delle altre – quando mi trovavo in Gambia, non con il proposito di farlo pubblicare, ma per arricchirmi culturalmente e tenere a mente gli avvenimenti di un certo rilievo. Ero, allora, molto giovane, e non avevo né il tempo né la capacità di fare quelle osservazioni che la gente istruita poteva desiderare; ma ciò che ho riportato è vero ed è un esatto resoconto di un territorio sconosciuto […]. Un resoconto delle parti interne dell’Africa che si era curiosi di conoscere e sulle quali pochi resoconti sono, finora, stati pubblicati; gli stessi risultano o molto antichi o fiabeschi” (73).
Per identificare le diverse entità politiche con le quali gli Europei dovevano interagire per sviluppare i traffici della tratta questi testi riuscivano in genere a mettere bene in evidenza le attività economiche prevalenti nei differenti centri della zona costiera e le attività di scambio nelle quali queste si collocavano. Inoltre l’attenzione agli aspetti politici nei loro rapporti con le condizioni del commercio europeo si accompagnava spesso alla contestualizzazione delle vicende in grado di modificare i rapporti di forza interni o concernenti i potenziali economici delle diverse regioni, nonostante che alcune informazioni passassero meccanicamente di testo in testo senza un’opera di revisione od aggiornamento.
Meno consistente dal punto di vista quantitativo ed allo stesso tempo anche meno articolato nei suoi contenuti e nei suoi schemi di lettura ed interpretazione della realtà descritta ed osservata si presenta, nel corso del Seicento e del Settecento, rispetto a quello relativo ai territori ed alle popolazioni oggetto della tratta sui quali ci siamo già soffermati, il panorama delle testimonianze concernenti la zona “barbaresca”, vale a dire l’Africa settentrionale (Tripolitania inclusa), in larga parte per il fatto che questa area cominciò a perdere già dalla prima metà del Cinquecento, come ha messo in evidenza Marica Milanesi, il ruolo di mediazione, esercitato per secoli, dei traffici commerciali tra il mondo mediterraneo e le regioni subsahariane, per rinchiudersi sempre più in se stessa fino alla conquista francese dell’Algeria: non si può pertanto ritenere un caso “che Leone l’Africano sia l’ultimo a portare in Europa notizie di questa area, e che l’Europa, nei trecento anni che seguono, non cerchi il bisogno di saperne qualcosa di più” (74).
Nonostante questa affermazione possa sembrare in qualche misura esagerata (75), è tuttavia indubbio che in quell’ampio arco di tempo le presenze europee nell’area maghrebina e le relative testimonianze si siano limitate, in linea di massima, alle iniziative di natura politico-diplomatica e religiosa (76) ed abbiano prodotto di conseguenza un’informazione circoscritta e parziale, per cui, come ha fatto rilevare Guy Turbet-Delof, “l’Afrique barbaresque s’est presente à la conscience française, durant les XVIe et XVIIe siècles, comme un enchevêtrement compactes d’incertitudes et d’apories” (77), anche se non sono mancate esperienze di altro genere più aperte alla complessità della realtà affrontata e presa in considerazione. Si può considerare questo il caso di Giovanni Pagni, medico dell’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, giunto nel 1667, su richiesta del bey, a Tunisi, dove si trattenne un anno informando Francesco Redi con delle lettere (78) su quanto ebbe l’opportunità di osservare relativamente ai costumi degli abitanti (cerimonie nuziali, preghiere rituali, festività e riti religiosi che scandivano il corso dell’anno musulmano, i riti funerari e le manifestazioni di lutto) ed agli aspetti naturalistici del paese, con particolare riguardo alle erbe ed alle piante più diffuse (79).
Un altro genere di testimonianze relative a quest’area dell’Africa settentrionale, che “rencontrèrent un certain succes auprès les lecteurs européennes, dont ils éveillaient à la fois la sympathie pour les naufragés et la curiosité pour ces peuple pratiquemment inconnus et un peu mystérieux, qui emmenaient parfois leurs prisonniers jusqu’à Tomboctou” (80), sono i resoconti di quanti ebbero la sventura di essere catturati e fatti schiavi dai pirati barbareschi e che quindi osservarono e descrissero all’interno di questa loro particolare condizione quello che ebbero la possibilità di percepire, offrendo delle preziose indicazioni non soltanto sulle caratteristiche geografiche del territorio, ma sulle usanze e sulle attività commerciali di quelle popolazioni, nonché sulle relazioni tra le differenti tribù ed i loro rapporti col sultano del Marocco a Nord e con la colonia francese del Senegal al Sud.
Uno dei più interessanti (81) fu quello dell’inglese Thomas Pellow che, fatto prigioniero nel 1715 al largo di Gibilterra dai pirati di Salé, sarebbe rimasto protagonista, per ben ventitre anni, di una singolare serie di avventure, raccontate, dopo il suo ritorno in Inghilterra, da un resoconto (The History of the Long Captivity and Adventures ot Thomas Pellow in South Barbary), pubblicato a Londra tra il 1743 ed il 1744; un’opera costellata qua e là da precisi accenni alla fauna, alla botanica, alla geografia, alla storia ed alla medicina dei territori berberi che si presentavano però del tutto privi di sistematicità. Più originali e più attendibili, oltre che più interessanti, si possono considerare le osservazioni sulla vita di corte e sui vari aspetti del mondo islamico coi quali Pellow ebbe l’opportunità di entrare in contatto: dal matrimonio tra i Mori alle abitudini alimentari (fornì, fra l’altro, la prima ricetta del cous-cous apparsa su una pubblicazione inglese) (82).
Un corpus di relazioni con caratteristiche per alcuni aspetti a se stanti, perché originati e quindi influenzati principalmente dalle esigenze e dalle finalità dell’attività di evangelizzazione, si può considerare il complesso di testimonianze, in larga parte ancora inedite, legate alla cosiddetta Missio antiqua (83), che dal 1645 al 1835 vide impegnati oltre quattrocento cappuccini italiani nell’ “incredibile zona torrida” (84) attraversata dal Congo e che costituiscono ancor oggi una fonte di primaria importanza per la ricostruzione sia delle vicende e dei problemi connessi all’espansione politica, economica e religiosa delle potenze europee in quei territori, sia delle vicende interne di quegli stati, nonché delle caratteristiche delle loro strutture sociali, politiche, religiose e culturali, al di là dell’inevitabile tendenza dei missionari ad anteporre alla comprensione di un mondo e di un ambiente così lontani dai loro parametri culturali degli atteggiamenti di rigido rifiuto, accompagnati e sostenuti da perentori quanto immotivati giudizi di condanna e di disprezzo soprattutto dei modi di vita e delle pratiche e concezioni religiose delle popolazioni indigene:
“Nessuno si meravigli – scriveva ad esempio Antonio da Gaeta (ma valutazioni dello stesso tenore si possono trovare in tutti i resoconti dei suoi confratelli) -, ch’io chiami questi Neri Etiopi, uomini bestiali, o bestie poco meno che irragionevoli, perché in verità non sanno ciò, che ad un’huomo è necessario sapere, convengono nell’essere, nel vivere, e nel sentire con gli altri animali, ma nel discorrere, e saper discernere il bene dal male, la virtù dal vitio, l’utile dall’honesto, il giusto dall’ingiusto, par che non habbino uso di ragione, e privi affatto siano d’intelletto; avvenga peraltro barbari, fieri, crudeli, ed inumani si dimostrino, e nella malattia, nelle doppiezze, nelle furberie, nelle finzioni, e ne gl’inganni siano come volpi astutissime” (85).
Giudizi del genere, dettati dallo zelo apostolico, venivano estesi, da parte di chi era pienamente convinto che il messaggio cristiano rappresentasse non solo “la totalità della verità religiosa, ma anche la totalità della civiltà” (86), a tutti i comportamenti giudicati antitetici a quelli propri abitualmente dei colonizzatori, per cui tecniche e sistemi di coltivazione finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle comunità provocavano un giudizio di scarso rendimento attribuito alla pigrizia degli indigeni. Non esitò a farlo, ad esempio, padre Antonio Zucchelli, per il quale “questi Negri hanno la poltroneria ben radicata, e fissata fino dentro le midolla dell’ossa” e “non si vogliono punto affaticare nel coltivare terre […] capacissime di dare le raccolte molto abbondanti, fin tre volte all’anno, di tutto ciò che può produrre il Paese” (87).
Lo stesso si può dire per la sistematica denuncia della poligamia, considerata l’espressione più evidente della sfrenata lussuria che veniva attribuita a queste popolazioni, dal momento che i missionari non potevano comprendere e tanto meno giustificare le motivazioni sociali ed economiche sottese a tali istituzioni nell’ambito di un sistema che assegnava alla famiglia soprattutto la funzione di un raggruppamento produttivo al cui interno si articolava la divisione sociale del lavoro:
“Che maraviglia dunque – scriveva, ad esempio, Francesco Maria Gioia a proposito dei Giaghi -, ch’essendo eglino così gelosi e ghiottoni, siano anco così dediti al vitio della carne, e della lussuria, gli stimoli della quale, come quei, che sono di calidissima complessione, non potendo sofferire, corrono impazienti, senza alcuna vergogna, a guisa di giumenti, a sfogar i loro sfrenati appetiti, e dishoneste voglie. E sono per questa loro saldezza così lussuriosi, e fecondi, che di un certo Signor principale confinante di questo Regno, a cui per essere hora vecchio, e decrepito, se ben mancano le forze di più servire a’ piaceri, e diletti di Venere; non manca però la volontà, e’l disio, si dice per cosa certa, c’habbia avuto più di duecento figli delle sue mogli, e concubine” (88).
Nonostante queste chiavi di lettura dettate dagli inevitabili condizionamenti prodotti dall’incontro tra due identità culturali del tutto antitetiche, questi testi contenevano anche notizie ed informazioni che presentavano alcuni aspetti di interesse ed originalità, a partire dal primo (in ordine cronologico) resoconto di una certa ampiezza che venne pubblicato (89), quello redatto da padre Giovanni Francesco da Roma (Breve relatione del successo della Missione de’ Frati Minori Cappuccini del Serafico P. S. Francesco al Regno del Congo e delle qualità, costumi, e maniere di vivere di quel Regno, e suoi Habitatori), edito a Roma nel 1648 dalla tipografia della Sacra Congregazione de Propaganda Fide.
Su questa falsariga un panorama articolato di notizie ed informazioni di ogni genere sarebbe stato proposto e diffuso, negli anni successivi, da una serie di testi, fra i quali va ricordato il Viaggio del P. Dionigi de’ Carli da Piacenza, e del P. Michel Angelo de’ Guatini da Reggio Capuccini, Predicatori, e Missionarij Apostolici nel Regno del Congo, pubblicato a Reggio Emilia nel 1671, il cui pregio maggiore va ricercato, secondo Calogero Piazza, in “una sorta di naïveté e bonomia religiosa che ne rende la lettura dilettevole” (90); ma soprattutto la Istorica descrittione de’ tre regni Congo, Matamba et Angola, redatta da Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo che operò in Congo prima dal novembre 1654 al settembre 1667 e poi dal dicembre 1673 al 1677 quando ricoprì l’incarico di prefetto unico delle missioni: una ponderosa relazione suddivisa in sette libri e pubblicata postuma nel 1687 dopo che le note manoscritte del Cavazzi (91), accusate dalla Congregazione di Propaganda Fide di eccessive concessioni al fantastico ed al miracolistico, erano state riviste da padre Fortunato Alamandini (92). L’autore riuscì a mettere a frutto le esperienze compiute negli anni passati in terra di missione, integrandole con i dati desunti dagli archivi dei cappuccini e della Congregazione de Propaganda Fide e componendo su queste basi un’opera che è stata definita una “summa non solo rispetto a quante l’avevano preceduta, ma anche rispetto a quante l’avrebbero seguita” e che “nonostante taluni difetti di forma […], e nonostante il tono talvolta declamatorio e trionfalistico […], ha un respiro sempre ampio […]” (93).
Fra gli elementi degni di attenzione di questi e degli altri (compresi i molti rimasti manoscritti) resoconti dei cappuccini che operarono in Congo va ricordata l’attenzione dedicata da questi missionari alla tradizione orale, diligentemente raccolta anche quando non adeguatamente interpretata, relativa alle origini sia del regno del Congo che di quello di Matamba, con particolare riguardo alla figura del fabbro ferraio, piuttosto ricorrente nella mitologia e nel ritualismo dei popoli di lingua bantù: una tradizione che, come ci ricorda Calogero Piazza, va ricollegata all’importanza avuta dalla metallurgia nella storia delle genti kongo (94) e tocca assai da vicino la sensibilità dei più recenti filoni di ricerca storica, particolarmente interessati alla ricostruzione dell’evoluzione della realtà politica e culturale del mondo africano nell’epoca che precedette la colonizzazione.
Va poi da sé che del tutto predominante si possa considerare il contributo offerto dai resoconti dei cappuccini della Missio antiqua alla ricostruzione delle complicate e spesso assai confuse vicende politiche che caratterizzarono la storia dei territori congolesi nel corso del Seicento e del Settecento, come pure del controverso rapporto tra autorità indigene e corona portoghese. E’ in tale ambito che va collocato lo spinoso problema della tratta degli schiavi su cui molti missionari, pur non riuscendo di fatto a contrastare concretamente il fenomeno, cercarono ripetutamente di richiamare l’attenzione, non tacendo i soprusi e le atrocità di ogni tipo inflitte ai negri fatti prigionieri.
Non sono poi da sottovalutare nemmeno le informazioni acquisite e trasmesse da questi missionari sulla realtà geografica (quasi metà dell’imponente relazione del Cavazzi è dedicata, ad esempio, a questo argomento), ma anche sulla flora (in particolare sulle piante utilizzate per finalità terapeutiche) e sulla fauna di un immenso territorio fino ad allora pressoché sconosciuto agli Europei. Ma sono soprattutto l’etnostoria e l’antropologia culturale che, utilizzando in maniera adeguata questi testi, possono oggi ricavarne una molteplicità di elementi utili all’identificazione ed alla comprensione di usi e costumi, delle strutture sociali, delle pratiche e credenze (culti propiziatori, feste e danze rituali, cerimonie iniziatiche, riti funerari e di tumulazione, pratiche terapeutiche, ecc.) diffuse tra le popolazioni dell’antico Stato del Congo, come ci dimostra l’articolata trattazione di questi argomenti nei saggi di W. G. L. Randles e di G. Balandier, costruiti quasi esclusivamente sulle testimonianze dei missionari (95).
Un materiale passibile, pertanto, di ulteriori studi ed approfondimenti, la cui potenzialità, da questo punto di vista, è stata messa concretamente in evidenza da Maria Giovanni Parodi da Passano che, completando alcune analisi già avviate in questa direzione da Vittorio Maconi (96), ha saputo utilizzare in maniera molto proficua gli Avvertimenti salutevoli all’apostolici missionarij ne’ regni del Congo, Angola e circonvicini di padre Giovanni Belotti da Romano per far riemergere, ad esempio, gli aspetti essenziali della struttura sociopolitica e del ciclo della vita individuale (usi e riti natali, norme matrimoniali, condizioni e ruolo della donna, malattie e morte) dell’etnia bantù dei Kimbundu, stanziata tra lo Zaire e l’Angola, riuscendo così a verificare ”come i dati emergenti dal manoscritto non soltanto siano convenientemente inseriti nel contesto culturale risultante dai recenti studi sui Kimbundu, ma contribuiscano a completarne il quadro” (97), considerazione questa che si può sicuramente estendere a tutte le fonti dello stesso genere.
Ad ulteriore conferma dell’utilità, per chi sappia interpretarle, di queste testimonianze, anche Calogero Piazza, commentando la relazione di Girolamo da Montesarchio aveva messo in evidenza che il resoconto di questo frate poteva servire a ribadire l’esistenza, sulle due rive del fiume Congo, di comunità fondate sul rispetto di una dualità della struttura politica che si manifestava, da un lato, in una contrapposizione tra potere dei vassalli e autorità regale simile, almeno all’apparenza, a quella dell’Occidentale feudale; dall’altro, nel tacito giustapporsi, per la tutela del bene comune, delle potestà dei capi tradizionali (98).
Un discorso a sé stante meritano infine i riferimenti presenti in queste fonti alle lingue delle diverse popolazioni indigene, di cui sono talora riportati alcuni termini, in qualche caso pure con la relativa spiegazione, anche se più precise da questo punto di vista si possono considerare alcune rudimentali grammatiche, come quella kikongo compilata da padre Giacinto Brugiotti da Vetralla e pubblicata a Roma nel 1659 (99).
Molti dei resoconti redatti nel corso del XVII e del XVIII secolo, sui quali ci siamo soffermati, relativi ai diversi territori del continente africano (100) sarebbero stati ripresi in forma integrale o parziale nelle numerose raccolte di relazioni di viaggio, compilate nelle lingue più usate e conosciute come l’inglese ed il francese, che avrebbero messo questi testi a disposizione di un pubblico più ampio a partire dalla Recueil de divers voyages faits en Afrique et en Amérique di Henri Justel, pubblicata a Parigi nel 1674; dalla Rélation de divers voyages curieux, qui n’ont point été publiés di Melchisédech Thévenot, pubblicata sempre a Parigi nel 1696; dalla Recueil des voyages qui ont servi a l’établissement et aux progrès de la Compagnie des Indes orientale hollandaises, pubblicata ad Amsterdam in cinque volumi tra il 1702 ed il 1706 e riproposta in sei volumi fra il 1707 ed il 1719 ed in dieci nel 1730; e da A Collection of Voyages and Travels, some now first printed from original manuscripts; others translated out of foreign languages, and now first published in English, apparsa a Londra nel 1704 in quattro volumi per iniziativa dei fratelli Awnsham e John Churchill e ripubblicata in sei volumi nel 1732 ed in otto tra il 1744 ed il 1746 (101).
Fra tutte queste raccolte si impose, sia per le sue dimensioni sia per la sua impostazione, la Histoire générale de toutes les relations de voyage ou nouvelle collection de toutes le relations de voyage par terre et par mer, qui ont étè publiées jusqu’à présent dans les différents langues de toutes les nations connues, realizzata in sedici eleganti volumi in 4° di circa sette-ottocento pagine (102), impreziositi dalle carte di Jacques-Nicolas Bellin, idrografo del re di Francia, e dalle incisioni di Charles-Nicolas Cochin e Jacques-Nicolas Tardieu, fra il 1746 ed il 1761 (103), grazie anche al sostegno ed all’incoraggiamento del ministro della Marina Maurepas che intendeva in questo modo promuovere ed incentivare la politica coloniale francese, dall’abate Antoine-François Prévost d’Exiles (1697-1763). Un’opera la cui importanza valicò i confini di quanti erano interessati esclusivamente alla letteratura di viaggio e che, secondo Jean Sgard, ha rappresentato, per la seconda generazione dei filosofi del Settecento, ciò che il Dizionario era stato per la prima e ciò che l’Enciclopedia sarebbe stata per la terza, perché permise di fare il punto sulle conoscenze geografiche ed etnologiche fino ad allora acquisite, come dimostrano le opere di Buffon, Voltaire, Helvétius, Rousseau, Diderot, Raynal, De Pauw, ecc. che attinsero a piene mani all’inesauribile deposito di curiosità e di ogni genere di notizie presenti in questo vasto repertorio (104).
L’Histoire générale des voyages si presenta infatti come una sorta di enciclopedia ragionata in cui sono messe in ordine un insieme di conoscenze geografiche e storiche che offrono un quadro completo dei costumi e della civiltà. Per quel che concerne l’Africa è possibile, ad esempio, trovare in essa una messa a punto sul fiume Niger, in cui si esamina se il Senegal ed il Gambia ne costituiscono dei bracci; una storia delle diverse Compagnie di commercio operanti in quel continente; un elenco delle colonie europee dislocate lungo la costa della Guinea, del Benin e dell’Angola; un elenco delle varie tribù ottentotte; alcune osservazioni sulla lingua del Madagascar, ecc.
I singoli gruppi etnici, le tribù e le nazioni sono attentamente descritti e colti nelle loro manifestazioni peculiari attraverso un metodo di comparazione costante che permette di mettere in luce conformità e diversità, là dove il primo sguardo dell’Europeo tenderebbe a percepire, come a lungo era stato fatto, solo degli aspetti uniformi, dal momento che per Prévost il vero viaggiatore è un dilettante illuminato, curioso di ogni cosa e capace di osservare tutto ciò che può interessare l’insieme dei suoi lettori, ai quali ha cercato di dimostrare che si poteva leggere con profitto le loro relazioni e correggere ed integrarle l’una con l’altra, considerando vero soltanto ciò che risultava confermato da diverse testimonianze (105).
Frutto dell’aspirazione alla dimensione enciclopedica dell’informazione storica e geografica caratteristica di quel periodo si possono considerare anche alcune ponderose storie universali che abbracciano pure il continente africano (106), come l’Histoire Générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, dell’abate Pierre Joseph André Roubaud, edita a Parigi in quindici volumi tra il 1770 ed il 1775, e la Modern History or the Present State of all Nations, describing their respective situations, persons, habitus…, redatta da Thomas Salmon e pubblicata a Londra, a partire dal 1731, in ben 32 volumi, nei quali di ogni paese preso in considerazione sono esposte le caratteristiche fisiche ed urbane, quelle economiche e culturali e quelle politiche e religiose. Due di questi volumi, che nelle edizioni italiane apparse a Venezia ed a Napoli furono presentati col titolo di Lo stato presente di tutti i popoli del mondo naturale, politico e morale, vennero riservati interamente al continente africano, collocato, nel capitolo introduttivo, “fra le parti del Mondo ancora incognite e non discoperte” e quindi da presentare al lettore sulla base di quanto era stato “raccolto dalle migliori notizie, e fondato sulle più ragionevoli congetture che sieno state fatte in tal proposito” con particolare riguardo alla cosiddetta “Cafraria” (107) o “Paese degli Ottentotti”. A questo sono dedicati cinque capitoli del primo tomo contenenti degli interessanti riferimenti pure al “Governo Civile ed Economico degli Olandesi al Capo di Buona Speranza”; mentre una didascalia di una carta di una zona costiera dell’Africa sud-occidentale parla ancora di “nazione selvaggia che si dice non abbia neppure l’uso della parola” ed un’illustrazione, intitolata “Beccaria di Carne umana” fa riferimento alla pratica dell’antropofagia da parte degli Anzichi, ai quali già il Pigafetta aveva attribuito delle “beccherie di carne umana come qui di vaccina e di altre bestie”, contaminando l’immagine di una macelleria con quella di un santuario europeo nel quale sono esposti degli ex-voto che riproducono gli arti dei miracolati (108).
L’incontro con gli Ottentotti (ma anche coi Cafri, che spesso vennero confusi coi primi) mise infatti i viaggiatori europei che si recavano nelle Indie orientali facendo sosta all’altezza del Capo di Buona Speranza, di fronte ad una “alterité inattendue, radicale et stupefiante”, come ci ha fatto notare Dominique Lanni, perché “fascinés par leur prodigieuse physionomie, leur inintellegible vocalité, leur odor fétide, leurs répugnantes moeurs phagiques, les voyageurs européens […] ne manquent pas de s’apitoyer sur leur misérable état” e “en s’appliquant à recenser et stigmatiser quasi scrupuleusement les marques de leur extrême étrangeté pour exiger de leur profonde misére et les reléguer aux confins de l’humanitè […] s’appliquent en réalitè moins à décrire ces êtres du bout du monde qu’ils ne les inventent ou les fantasment”, per cui il ritratto di questi “selvaggi” continuerà ad oscillare tra mito (109) e realtà. Si passa così da “une imagerie mythique foncièrement négative dont la pérennité et l’efficacité procèdent de l’étonnante vitalité d’un imaginaire hérité des autorités antiques et médiévales, des édifiantes representations véhiculées par les sources historiques et viatique contemporaines”, al, in seguito, “renversement de l’egard qui s’amorce lentement sous la plume des historiens, des missionnaires, des philosophes et qui se caracterise par une réevaluation systématique des savoirs, une réconsideration de l’aptitude des sauvages à être ou à ne pas être convertis, une profonde réflexion sur la viabilité des sociétés athées” (110).
Per quel che concerne l’aspetto bestiale e ripugnante degli Ottentotti l’opera del Salmon non avrebbe fatto altro che riproporre i luoghi comuni che risalivano ai viaggiatori del Seicento e del Settecento (111), come quelli contenuti nel resoconto, corredato anche della prima immagine degli Ottentotti apparsa in Inghilterra (112), di Thomas Herbert (Some Years Travels in Africa and Asia the Great, Londra, 1638) che faceva parte dell’ambasceria al re persiano Abbas I guidata da Dodmore Cotton; o del tedesco Christophorus Schweitzer (Journal und Tage-Buch seiner sechs-jahrigen Ost–Indianische Reise, Tubingen, 1688) che, per conto della WOC, soggiornò a Città del Capo nel 1676, dove dal 1669 al 1675 o 1676 risiedette, sempre al servizio della stessa Compagnia, anche il connazionale Johan Schreyer, autore della Neue Ost Indianische Reisz-Bescheribung (Saafeld 1679) (113) un capo nonché nelle osservazioni del medico e botanico olandese Willhelm Ten Rhijne, pubblicate in latino a Shaffausen nel 1686 con il titolo Schediasma de promontorio Bonae Spei eiusve tractus incolis Hottentottis in cui, oltre ad essere accusati di sporcizia, questi “selvaggi” venivano dipinti come idolatri (con riferimento ad un misterioso culto della Luna), crudeli e dediti a pratiche sessuali animalesche e brutali. Il resoconto di Ten Rhijne ricordava inoltre il rituale della semi-castrazione degli adolescenti praticato con l’intenzione di evitare parti gemellari e faceva riferimento per la prima volta al misterioso “grembiule” delle donne ottentotte, una specie di prolungamento delle parti sessuali femminili che sarebbe stato oggetto per lungo tempo di molta curiosità e di controverse interpretazioni scientifiche.
Questi elementi, ripresi anche da un medico olandese al servizio della Compagnia delle Indie, Nicolaas de Graaf, che si soffermò ripetutamente sull’aspetto bestiale degli Ottentotti, i quali secondo il suo resoconto, “n’ont rien d’humaine que la figure”, vanno vestiti di pelli e adorni delle interiora putrefatte degli animali, non possiedono nessuna nozione della divinità e, per quanto rozzi ed ignoranti, “ne manquent pas d’intelligence pour faire du Mal”, rivelandosi, se necessario, piuttosto vendicativi” (114), saranno riproposti, sia pure con qualche indulgenza verso il mito del “buon selvaggio”, nella famosa descrizione dell’Africa australe tracciata nel 1719 dall’astronomo tedesco Peter Kolb, nella quale raccolse tutto ciò che aveva potuto osservare in ben dieci anni di soggiorno in quel territorio, dove era stato inviato nel 1705 dal barone von Frisigk, consigliere privato alla corte di Prussia. La versione francese abrégée del 1741 di questo resoconto diventò in breve tempo il testo di riferimento sui costumi degli indigeni del Capo, utilizzato da Buffon e citato come fonte nelle più celebri raccolte di viaggio di quegli anni (115).
Concezioni perciò a circolare (e non soltanto sugli Ottentotti) concezioni e immagini negative che appaiono efficacemente sintetizzate nel decimo e ultimo volume, dedicato per l’appunto all’Africa, de lle Mélanges intéressants et curieux pubblicate fra il 1763 ed il 1765 da Jacques-Philibert Rousselot de Sourgy, in cui a proposito dei negri si sostiene che
“Tous le voyageurs qui les ont fréquentés, tous les écrivains qui en ont parlé, s’accordent à les représenter comme une nation qui a, si l’on peut s’exprimer ainsi, l’âme aussi noir que le corps. Tout sentiment d’honneur & d’humanité est inconnu à ces barbares: nulle idées, nulle connossainces qui appartiennent à des hommes. S’ils n’avoient le don de la parole, il n’auroient de l’homme, que la forme […].
Point de raisonnement dans les Nègres, point d’esprit, point d’aptitude à aucune sorte d’étude abstraite. Une intelligence qui semble au-dessous de celle qu’on a admirée dans l’éléphant, est le guide unique de toutes leurs actions; l’intérêt de leur conservation, de leurs plaisirs, est le seul mobile de tous leurs mouvemens […]. Livrés à leurs passions comme des brutes, ils ne connoissent que la jouissance. Leur attachement à leur enfans, à leur famille, ne dure qu’autant que dans les bêtes, jusqu’à ce que leurs petits puissent se passer d’eux. La force seule peut les contenir dans le devoir, & la crainte est le seul motif qui les fasse agir; ils n’ont réellement point de Coeur, & par consequent le germe de vertus leur manque. La brutalité, la cruauté, l’ingratitude, voilà ce qui forme leur caractère. Leur naturel est pervers; toutes leurs inclinations sont vicieuses […]. On seroit tenté de croire, d’après ce portrait, que les Négres forment une race de créatures qui est la gradation par la quelle la natura semble monter, des Orang-Outangs, des Pongos, a l’homme” (116).
Un approccio all’Africa che stentava quindi a liberarsi da atavici pregiudizi sistematicamente rilanciati dalle esigenze della tratta e dei progetti espansionistici e che presentava ancora molte approssimazioni ed incertezze anche per quel che concerne le conoscenze geografiche, come ci fa capire Le Géographe Manuel, contenant la Description de tous les Pays du Monde, leur qualités, leur climat, le caractère de leur habitants…, un’opera di grande successo redatta dall’Abbé Expilly attorno alla metà del Settecento, nella quale non si fornivano molte notizie sul continente africano al di là della grandezza, posizione, clima, principali caratteristiche del regno animale e vegetale per limitarsi ad affermare in maniera estremamente sbrigativa che “dell’Africa non si conoscono che le coste, essendo l’interno di troppo difficile accesso, sia a causa della quantità di animali pericolosi che vi si trovano sia a causa della rarità di acqua e di abitanti e di altre cose necessarie ai viaggiatori”. L’unica immagine concreta ed un po’ più dettagliata risultava quella dell’Africa islamica e gli unici popoli ad essere nominati e descritti nella loro specificità culturale erano gli Arabi, detentori di una lingua, di una religione, una storia; mentre tutto il resto scompariva “nel panorama indifferenziato della razza negra, dell’idolatria, di un insieme indeterminato di lingue sconosciute e incomprensibili, insomma in una specie di deserto culturale e naturale” (117).
Prendendo in esame i contenuti ed il significato della produzione editoriale sull’Africa sino alla fine del Settecento ci si trova pertanto di fronte ad una forma di percezione e conoscenza di questo continente dal carattere per lungo tempo oscuro ed incerto che gradualmente tende a farsi sempre più ambigua e contraddittoria, rivelando tutti i dubbi e le incertezze di un approccio che si sarebbe fatto più preciso solo in rapporto ad interessi più concreti. Questo complesso e dilacerante atteggiamento che ha sempre guidato ed orientato la coscienza e la mentalità europee nel confronto con l’alterità, viene registrato anche dall’apparato iconografico che accompagna ed arricchisce molti testi, come ci ha fatto notare Genoveffa Palombo puntando l’attenzione sulle immagini proposte da Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo del Salmon, ed in particolare di quelle dedicate agli Ottentotti (118), per sottolineare come ancora nella metà del Settecento l’immagine complessiva di questo mondo tendesse a riconfermare una simbologia ed una tradizione plurisecolari perché nella conoscenza di questa parte della Terra nessun elemento nuovo era ancora intervenuto, o per lo meno nessun elemento era stato considerato in misura tale dirompente da arrivare a modificare un tipo di raffigurazione consacrato dalla tradizione: la trasformazione sarebbe avvenuta in maniera radicale nell’arco di alcuni decenni con l’esplorazione sistematica e profonda di questo continente conosciuto fino ad allora più attraverso antichi ricordi che tramite notizie recenti (119).
Proprio in quegli anni infatti si sarebbero messe in moto diverse spedizioni dettate da finalità e obiettivi di natura prevalentemente scientifica, alimentate anche dalle nuove prospettive economiche ed espansionistiche connesse con la crisi del sistema schiavistico destinata a trasformare l’Africa in territorio adatto ad offrire ogni tipo di risorsa e a dar vita a colonie di popolamento, contestualmente allo sviluppo di un processo di revisione ed aggiornamento della rappresentazione cartografica di questo Continente promosso fin dall’inizio del Settecento dall’attività di geografi come Guillaume Delisle e Jean-Baptiste Bourguignon D’Anville (120), grazie al quale, se molti misteri della parte interna del continente avrebbero dovuto attendere ancora più di un secolo per essere svelati, molti luoghi comuni tramandati per secoli e tradizioni cartografiche non basate su sufficienti elementi probanti, soprattutto per quel che concerne l’apparato idrografico, avrebbero cominciato invece ad essere messi in discussione fino a rilevarsi del tutto fallaci (121).
Michèle Duchet ci ha ricordato a questo proposito che partire dagli anni Sessanta i Francesi avevano cominciato a porsi il problema di valorizzare le regioni semi-sconosciute dell’Africa come risulta dalla Corrispondenza delle Colonie, perché, secondo un loro amministratore, “la Francia non può guardare con indifferenza all’Africa” dal momento che “è questa parte del mondo che dà valore ai suoi possedimenti americani”, potendo, come precisava un progetto di insediamento nel Senegal e di sfruttamento delle miniere di Bambouk, “mettere a disposizione […] ricchezze pari a quelle del Perù e del Brasile, che non avrebbero neppure l’inconveniente di essere acquistate mediante la schiavizzazione delle popolazioni che le possiedono né l’indebolimento della metropoli” (122).
Così, partito come elemosiniere per Gorea nel 1763, l’abate Demanet, dopo aver creato una società con un capitale di 400.000 franchi per il commercio sulle coste e nell’interno dell’Africa ed aver firmato dei trattati coi re di Arguim e di Portendic riuscendo ad ottenere un privilegio per tutti gli scali commerciali compresi fra il Capo Bianco e la Sierra Leone, scriverà una Nouvelle Histoire de l’Afrique Française (Parigi, 1767) che venne accolta favorevolmente dai fautori di una politica di espansione verso l’interno dell’Africa e che, nonostante errori geografici e favole grossolane, fu apprezzata sia da Cornélius de Pauw sia dall’abate Guillaume-Thomas Raynal, assieme all’Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes d’Afrique, un lavoro di mera compilazione redatto dall’abate Liévin-Bonaventure Proyart, il quale nel 1772 aveva guidato una missione composta da sei preti e da un gruppo di laici destinati a costituire l’embrione di un “colonato” in Congo. Indipendentemente dai limiti e dalla scarsa originalità di questi testi, “grazie a tali relazioni – fa notare Michèle Duchet – una certa immagine dell’Africa e dei suoi abitanti si è sostituita all’affresco assai tenebroso fornito dall’Histoire des voyages […]. Quest’Africa rassicurante, alla vigilia dell’avventura coloniale, offre ancora tracce di barbarie, ma il quadro d’assieme non ha più nulla che possa scoraggiare i tentativi di colonizzazione. L’Africa maledetta dei trafficanti di schiavi comincia ad esercitare sugli spiriti un fascino riservato fin allora al Perù e al Brasile” (123).
Da questa necessità di sfruttare meglio le risorse della terra, di guadagnare col commercio, di colonizzare si scatena, nell’ambito della botanica, come ha sottolineato Jeannine Mouniama, “la guerra dei vegetali e delle spezie e ogni potenza europea si allena allo spionaggio economico – tentando di rubare culture esotiche, segreti di coltivazione – e alla ricerca di nuove piante alimentari o industriali da monopolizzare e da commerciare” (124).
In questo contesto si colloca la vicenda di Michel Adanson che si può assumere come rappresentativa di altre esperienze di viaggiatori-scienziati sviluppatesi in quegli stessi anni. Convinto di avere “un vaste camp d’observations à moissonner” (125), all’età di ventidue anni questo naturalista, formatosi alla scuola del Jardin du roi (l’attuale Jardin des plantes), si imbarca a Lorient, in Bretagna, come impiegato soprannumerario della Compagnie des Indes Occidentales, costituita nel 1687 dal Colbert, che deteneva il monopolio del commercio francese sulla costa occidentale dell’Africa, dove possedeva diversi comptoirs per la tratta degli schiavi ed il commercio della gomma. Per quattro anni percorre senza soste la vallata del Senegal fino a Podor, la regione del Capo Verde e del Gambia, raccogliendo, cacciando e classificando più di quattromila specie animali e vegetali; ma contestualmente svolge anche delle osservazioni metereologiche, scandaglia il fiume Senegal, studia il regime dei venti e la loro influenza sulla vegetazione e trascrive delle favole wolof fornendone la traduzione, come era solito fare un naturalista in un periodo in cui “la scienza era ancora un cespuglio ricco di germogli però non ancora sbocciati nelle diverse specializzazioni” (126).
Procedendo con rigore e con metodo sgombra il suolo africano dalle favole e dalle leggende alternando narrazione e descrizione, spiegazione scientifica e riflessione filosofica ed il testo, che si può collocare nella categoria della volgarizzazione scientifica, nasce da un compromesso tra la tentazione di essere preciso ed esauriente e il desiderio di non annoiare il lettore con descrizioni troppo dettagliate. Il Senegal viene in questo modo presentato “in una successione di quadri, che ricordano i mosaici ellenistici, a motivi nilotici, o le tavole di repertori geografici, dove scene di vita locale (pescatori, nuotatori, lavori rustici nei campi, feste e balli…) si alternano alla rappresentazione della fauna e della flora (gru, aironi, ippopotami, coccodrilli annidati fra le piante acquatiche… cinghiali, rinoceronti ed elefanti sulle rive…). La vegetazione e gli animali sono sempre presentati nel loro ambiente e localizzati nel territorio: tutto quello che producono il fiume e le sue sponde, la savana […] e la foresta tropicale (127), viene inserito in ecosistemi precisi, inventariati e descritti nel loro paesaggio naturale” (128).
La cornice, metaforica e reale al tempo stesso, di tutta questa esperienza è la pure nature (129) del Second Discours di Rousseau, quella che caratterizzava la vita dell’uomo nel suo stadio primitivo quando, organizzato in piccole società, viveva in un mondo armonioso, tranquillo ed allegro, ben diverso da quello ostile ed inquietante che i viaggiatori erano soliti attribuire all’Africa e che era allora presente pure nella voce Senegal dell’Encyclopédie, redatta da Louis de Jaucourt, che segnalava l’opera di Adanson ma di fatto faceva ricorso all’Histoire des voyages del Prévost presentando, fra l’altro, i Wolof come esseri corrotti, vili, vendicativi, mentitori ed ubriaconi, che vendevano i loro figli e si vendevano fra loro (130). Una natura che serve da sfondo alle attività di un uomo “bello, sano, vivace, dolce, ospitale e felice”, frutto di un’antropologia, fatta propria da Adanson, che faceva dello stato di civiltà il termine ed il fine di tutte le società umane, per cui anche l’Africano avrebbe potuto progredire e perfezionarsi, e che “prende in contropiede il ritratto negativo (brutto, tonto, pigro, libidinoso e per giunta nero) diffuso da Linneo e soprattutto da Buffon” (131).
Con questo tipo di viaggiatori e con le relazioni da essi trasmesse ha di fatto inizio una nuova fase nella conoscenza dell’Africa e dei popoli africani che diventa lo strumento di una politica accuratamente concertata in cui al gusto del narratore ed alla curiosità od alla edificazione del lettore si sostituisce il desiderio di informare e di essere informati prendendo le distanze dall’insolito e dal meraviglioso che aveva caratterizzato fino ad allora la letteratura di viaggio e quella sull’Africa in particolare. A queste esigenze avrebbero cominciato a corrispondere anche le relazioni di quanti si dedicarono in quegli anni all’esplorazione di altre aree del continente africano, come gli Olandesi che, partendo dalla loro colonia del Capo, fondata nel 1652 dal chirurgo Jan van Riebeck per conto della Compagnia delle Indie Orientali, intrapresero una sistematica ricognizione dell’entroterra (132). Nel 1752, infatti, il governatore Rijk Tulbagh organizzò una spedizione alla quale, nel 1761, fece seguito quella di Hendrik Hop che guidò una carovana di ottanta persone raggiungendo il fiume Orange ed avventurandosi fra i Namachi, dove per la prima volta degli Europei videro delle giraffe (133).
Ma, accanto a quelli conseguiti già dall’astronomo Nicolas-Louis de La Caille, che soggiornò al Capo per due anni dal 1751 al 1753, correggendo, nel suo Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance pubblicato postumo nel 1763, molte delle affermazioni sugli Ottentotti, da equiparati ai “Gaulois sauvages”, di padre Kolb, definita un “roman tissu des faibles” (p. 31), le osservazioni ed i risultati più innovativi sarebbero giunti anche in questo caso da alcuni naturalisti, come l’allievo di Linneo Anders Sparrman, membro dell’Accademia delle Scienze di Stoccolma, dove dirigeva il gabinetto di Storia Naturale, che accompagnò James Cook nel suo primo viaggio intorno al mondo e fra il 1772 ed il 1776 soggiornò, sia all’andata che al ritorno, al Capo con l’intento di raccogliere e classificare alcune rare e sconosciute specie botaniche, penetrando nel territorio degli Ottentotti e dei Cafri. Questo viaggiatore mosso da intenti esclusivamente scientifici, respingendo la convinzione secondo la quale “un uomo che ha lasciato il suo paese natale e ha viaggiato intorno al mondo spinto da un carattere attivo e dal desiderio di vedere, specie se ha viaggiato nel paese degli Ottentotti e attraverso regioni diverse dell’Africa” avrebbe dovuto necessariamente riportare “un insieme di fatti curiosi”, nella prefazione al resoconto dell’edizione francese delle esplorazioni da lui compiute, metteva in guardia i lettori che si sarebbero aspettati dei “racconti meravigliosi” riconoscendo che la loro attesa era “mal fondata”:
“La natura – precisava infatti – mi si è presentata in effetti sotto forme diverse, sempre degna di ammirazione, spesso incantatrice, a volte terribile e circonfusa di orrore: ma devo prevenirvi che non si troveranno nel mio resoconto quei grandi prodigi, quei fenomeni miracolosi dei quali la lettura di alcuni autori ci ha riempito l’immaginazione […]. Gli uomini con un piede solo, i ciclopi, le sirene, i trogloditi e tutti gli altri esseri fantastici sono svaniti da tempo, a misura che il mondo si è rischiarato” (134).
A questi principi si sarebbero uniformati sia il luogotenente inglese William Paterson che fra il 1777 ed il 1779, accompagnato per un tratto da un ufficiale scozzese, Robert Jacob Gordon, il quale era già penetrato più di qualsiasi altro europeo, assieme ad un Ottentotto, nella parte interna dell’Africa australe, si spinse ad Ovest sino al fiume Orange costeggiando il paese dei Boscimani e ad Est fino al paese dei Cafri (135); sia il naturalista, originario delle Antille olandesi, François Levaillant, che fra il 1781 ed il 1784 si inoltrò prima nella terra dei Cafri fino al fiume Groot ris Rivier, esplorando al ritorno anche la regione delle Sneeuw Bergen (le montagne di neve), e poi, dopo una marcia estenuante attraverso il deserto dei Piccoli Namachesi, giunse fino alle rive del fiume Orange, entrando in contatto con popolazioni indigene ancora sconosciute come i Corachesi, i Cabobichesi e gli Uzuana che abitavano l’odierno Namaland.
Sulla base di queste sue esperienze Levaillant avrebbe redatto due diversi diari, il primo pubblicato nel 1790 col corredo di interessanti illustrazioni ad acquarelli elaborate da alcuni artisti sulla base di suoi disegni, il secondo nel 1795 (136). In essi, dopo aver accusato il Kolb di essersi basato sui pregiudizi correnti e sui racconti volutamente ambigui dei selvaggi invece che sull’osservazione diretta della realtà, attraverso una critica radicale dei costumi corrotti dei civilisés e l’elogio sentimentale dell’esistenza ignara e incontaminata dei primitivi, avrebbe messo in discussione i più diffusi luoghi comuni sui costumi degli Ottentotti per giungere alla conclusione che il selvaggio “non è barbaro né brutale”, ma che “il vero mostro è colui che vede il delitto per tutto ove lo suppone, e che lo afferma colla sola ed odiosa testimonianza della sua coscienza” (137). Sarebbe stato infatti in grado di tracciare, sulla base della verifica diretta che permetteva di inserire le acquisizioni ritenute fondate in un preciso sistema di riferimento facendo giustizia dei pregiudizi e della mancanza di metodo dei suoi predecessori, una sorta di mappa antropologica ed etnologica delle popolazioni da lui incontrate e studiate e del loro rapporto con i civilisés con precisi riferimenti agli ornamenti, alle abitazioni, agli utensili, agli strumenti musicali, alle armi, ai dati relativi alle idee di spazio e di tempo, alle credenze religiose, ai riti sociali; nonché di compiere un tentativo di descrizione della lingua fondato sull’analisi dei suoni e sulla ricerca dei loro corrispondenti in grado di permettere la definizione di una prima mappa fonetica capace di rivelare le caratteristica di una lingua che procedeva per analogie e non conosceva le astrazioni e che accanto a vocaboli primitivi registrava la presenza di espressioni contaminate e “sfigurate” dalla mescolanza con l’olandese parlato nella colonia (138).
Con questo tipo di resoconti cominciava a realizzarsi quello che in quegli stessi anni, nei quali fra l’altro sorgeva a Londra la Association for Promoting the Discovery in the Interior Parties of Africa, il futuro idéologue, Jean-Nicolas Buache, auspicava in una memoria sulla geografia di Tolomeo redatta per l’Accademia delle Scienze di Parigi in cui affermava che il compito di questa disciplina era ormai diventato quello di rivedere scientificamente gli oggetti che i predecessori avevano creduto di conoscere, di ricercare i fondamenti delle loro affermazioni individuandone gli errori e, infine, di riconoscere che esisteva un numero infinito di oggetti a proposito dei quali la vecchia scienza non aveva potuto formulare alcuna ipotesi. Facendo notare che le carte antiche non potevano essere degne di fede né per la determinazione delle latitudini e delle longitudini, né per la configurazione delle coste e dei fiumi, Buache concludeva il suo rapporto segnalando in particolare la mancanza di informazioni sull’interno dell’Africa (139), alla quale proponeva di rimediare inviandovi “quelque Européen voyageur à la suite des caravanes” (140).
Note
(1) Enneades Marci Antonii Sabellici an inclinatione romani imperii ad annum salutis millesimum quingentesimum quartum, Venezia, 1504, cc. CXXXVv.-CXXXVIr.
(2) Una relazione dello stesso ambasciatore (Legatio Magni Indorum Imperatoris Presyiteri Johannis ad Emanuelem Lusitaniae Regem) fu pubblicata nel 1532 ad Anversa dello storico portoghese Damião de Goes, che nel 1540 diede alle stampe, a Lovanio, un opuscolo dal titolo Fides, religio moresque Aethiopum imperio Preciosi Joannis (quem vulgo
Presbyterum Ioannem vocant) degentium, dedicato a papa Paolo III, che prima della fine del secolo avrebbe superato le dieci edizioni (A. LEITE FARIA, Estudio bibliográficos sobre Damião de Goes e sua epoca, Lisbona, 1977).
(3) Per la conoscenza e la diffusione in Francia di queste testimonianze vedi l’accurata nota bibliografica di J. PAVIOT, Connaissance et diffusion des découvertes portugaises en France au XVIe siècle (note bibliographique), in La découverte géographique à travers le livre et la cartographie, a cura di Ch. Huetz de Lemps, Parigi, 1997, pp. 157-164.
(4) Per l’importanza e le caratteristiche di queste relazioni vedi C. BECCARI, Notizie e saggi di opere e documenti inediti riguardanti la storia d’Etiopia durante i secoli XVI, XVII e XVIII, Roma, 1903 (ristampa anastatica: Bruxelles, 1969), che le ha poi pubblicate nei volumi X e XI delle Rerum Aethiopicarum Scriptores Occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX, Roma, 1910.
(5) C. F. BECKINGHAM, Ethiopia and Europe 1200-1650, in The European Outthrust and Encounter. The First Phase c. 1400 – c. 1700: Essays in Tribute to David Beers Quinn on his 85th Birthday, a cura di C. H. Clough e P. E. H. Hair, Liverpool, 1994, p. 91.
(6) Queste sorgenti, che per oltre due secoli continueranno ad essere scambiate con quelle del Nilo, erano state peraltro già esplorate e sommariamente descritte fin dal giugno 1588 da Giovanni Gabriel, un mulatto figlio di un’abissina e forse di un veneziano (vedi C. CONTI ROSSINI, Le sorgenti del Nilo Azzurro e Giovanni Gabriel, in Bollettino della Società Geografica Italiana, serie VII, vol. VI, 1941, pp. 38-47).
(7) Questa relazione contiene, ad esempio, una precisa descrizione dell’unicorno (il rinoceronte), la cui esistenza sarà invece messa in dubbio sino alla fine del Settecento.
(8) E’ il più esteso dei tre trattati redatti dal Barradas ed anche il più importante dal punto di vista geografico e storico, soprattutto perché, come sottolinea lo stesso autore nella prefazione, “quello, che diciamo, lo abbiamo veduto coi nostri occhi, toccato colle nostre mani, percorso co’ nostri piedi, udito colle nostre orecchie, praticando e disputando in varie parti di questo regno, per ispazio di sette anni, che in esso risiedei, con varie persone di autorità e di credito, tanto ecclesiastiche, quanto secolari” (citato da C. BECCARI, cit., p. 87).
(9) Vedi F. SURDICH, La relazione sull’Etiopia di Giacomo Baratti, in Miscellanea di Storia delle esplorazioni, II, 1977, pp. 119-185, che ha curato la traduzione italiana dell’edizione inglese del 1670 (nel 1676 apparve a Norimberga anche un’edizione tedesca) di questo resoconto intitolata The late travels of S. Giacomo Baratti an italian gentleman Into the remote countries of the Abissins, or of Ethiopia Interior.
(10) Per un accurato repertorio delle fonti a stampa sull’Abissinia apparse fino al 1799, che aggiorna e completa quello redatto da G. FUMAGALLI, Bibliografia Etiopica. Catalogo descrittivo e ragionato degli scritti pubblicati dalla invenzione della stampa fino a tutto il 1891 intorno all’Etiopia e le regioni limitrofe, Roma, 1893, rimandiamo a G. C. STELLA, Bibliographia Habessinica sive librorum de rebus aethiopicis Catalogus, editorum usque ad annum 1799, Ravenna, 1984. A queste fonti ha dedicato molti studi, in buona parte raccolti in Between Islam and Christianity, Londra, 1983, C. F. Beckingham.
(11) Sul viaggio in Abissinia di James Bruce vedi C. ASTENGO, Il viaggio in Abissinia di James Bruce (1768-1772), in Da Ulisse a… Il viaggio nelle terre d’oltremare. Atti del Convegno Internazionale (Imperia, 9-10-11 ottobre 2002), a cura di G. Revelli, Pisa, 2004, pp. 295-314.
(12) J. GUERIN DALLE MESE, Egypte. La mémoire et le rêve. Itinéraires d’un voyage, 1320-1601, Firenze, 1991, pp. 7-8. Vedi anche J.-M. CARRE’, Voyageurs et écrivains français en Egypte. I. Du début à la fin de la domination turque, Il Cairo, 1932; ed i viaggiatori francesi presi in considerazione da N. BROC, La Géographie des philosophes. Géographes et voyageurs français au XVIIIe siècle, Parigi, s.d. (ma 1974), pp. 55-58, che ha messo in evidenza l’importanza dei viaggi di Paul Lucas e del padre Claude Sicard, autore anche di una pregevole carta dell’Egitto (1722), ma soprattutto di Bernard de Maillet, console della Francia al Cairo dal 1692 al 1702.
(13) G. LUCCHETTA, I viaggiatori veneti dal Medioevo all’età moderna, in Viaggiatori veneti alla scoperta dell’Egitto, a cura di A. Siliotti, Venezia, 1985, p. 62; ma vedi anche IDEM, Viaggiatori, geografi e racconti di viaggi dell’età barocca, in Storia della cultura veneta, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Il Seicento, Vicenza, 1984, 4/II, pp. 215-233.
(14) Vedi F. PIGAFETTA, Viaggio da Creta in Egitto ed al Sinai 1576-1577, a cura di A. da Schio, Vicenza, 1984, edizione corredata da un elenco delle opere a stampa e di quelle manoscritte del Pigafetta.
(15) Questi aspetti del resoconto di Filippo Pigafetta sono stati messi in evidenza da G. LUCCHETTA, In Egitto e lungo il Nilo, in AA.VV., Africa. Storie di viaggiatori italiani, Milano, 1986, pp. 110-112; IDEM, Viaggiatori, geografi…, cit., pp. 206-208.
(16) R. RAINERO, La scoperta della costa occidentale d’Africa nelle relazioni di Gomes Eanes de Zurara, Diogo Gomes, Eustache de la Fosse, Valentim Fernandes e Duarte Pacheco Pereira, Milano, 1970, pp. 272 e 274.
(17) Ibidem, pp. 268-270.
(18) Su tutte queste fonti e sui loro autori vedi i contributi di S. DAVEAU, La Géographie dans les Roteiros Portugais du XVème et XVIème siècles, Lisbona, 1980; J. B. de CARVALHO, A la Recherche de la Spécificité de la Renaissance Portugaise. L’“Esmeraldo de Situ Orbis” de Duarte Pacheco Pereira et la Littérature Portugaise de Voyage à l’époque des Grandes Découvertes, Parigi, 1983; J. ROCHA PINTO, A Viagem: mémoria e espaço. A Literatura portuguesa de Viagens. Os primitivos relatos de viagem ao Indico, 1497-1550, Lisbona, 1989; J. da SILVA HORTA, A representação do Africano na literatura de viagens, do Senegal à Sierra Leoa (1453-1508), in Mare Liberum, n. 2, giugno 1991, pp. 209- 338 (con un’ampia bibliografia sull’argomento); L. de MATOS, L’expansione portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Lisbona, 1991; P. MASONEN, The Negroland Rivisited. Discovery and Invention of the Sudanese Middle Ages, Vaasa, 2000; nonché la bibliografia segnalata da F. SURDICH, L’Africa nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento, in Columbeis, V, 1993, pp. 165-240, cui rimandiamo anche per ulteriori indicazioni concernenti tutta la parte relativa al Cinquecento di questo nostro contributo.
(19) Ricordiamo a questo proposito che tra il 1500 ed il 1800 la letteratura geografica relativa all’Africa ed alle sue popolazioni raggiunse soltanto, per quanto riguarda la Francia, i quattrocento titoli, rispetto ai quasi ottocento relativi all’America ed ai quasi novecento concernenti l’Asia (P.E. H. HAIR, The Task Ahead: the Editing of Early European Language Texts on Black Africa, in Paideuma, XXXIII, 1987, p. 30).
(20) Vedi, a questo proposito, il saggio di W. G. L. RANDLES, L’empire du Monomotapa du XVe au XIXe siècle, Parigi, 1975.
(21) Come comandante del forte di Sao Jorge de Mina (Elmina) aveva anche potuto conoscere per esperienza diretta la zona costiera del golfo di Guinea tra il 1522 ed il 1525.
(22) A. MAURO, Al modo di un portolano. Un caso di informazione geografica nelle pagine dell’Asia di João de Barros, in Congresso Internazionale “Il Portogallo e i mari: un incontro tra culture” (Napoli, 15-17 dicembre 1994), a cura di M. L. Cusati, Napoli, 1997, I, p. 120.
(23) G. B. RAMUSIO, Navigazioni e viaggi, a cura di M. Milanesi, Torino, 1971, II, p. 1053.
(24) C. ZAGHI, L’Africa nella coscienza europea e l’imperialismo italiano, Napoli, 1973, pp. 66-67. D’altra parte ancora all’inizio del Settecento, nel suo Mèthode pour étudier la Géographie (Parigi, 1716), N. Lenglet du Fresnoy, dopo aver affermato che “les autres partes du monde ne demandent point une étude aussi détaillée que l’Europe” (p. XCVIII), sosteneva che l’Asia è “la plus curieuse et intéressante” e che “à l’exception de l’Egypte et de la Barberie, l’Afrique ne nous intéresse pas plus qu’elle ne nous est connue” (pp. CI-CII).
(25) Su questi problemi vedi A. TEXEIRA DA MOTA, A cartografia antiga da Africa central, Lourenço Marques, 1964; Africa on maps dating from XII to XVIII centuries, Lipsia, 1968; K. Y. FALL, L’Afrique à la naissance de la cartographie moderne, Parigi, 1982; L’Africa ritrovata. Antiche carte geografiche dal XVI al XIX secolo, Palermo, 1986; M. T. DE PALMA, L’Africa nella cartografia moderna: dalla congettura alla realtà, in AA.VV., Africa. Storia di viaggiatori italiani, cit., pp. 154-160; F. RELANO, The Shaping of Africa. Cosmographic Discorse and Cartographic Science in Late Medieval and Early Modern Europe, Burlington, 1988.
(26) Lo stesso avrebbe fatto, per i mercanti inglesi (Thomas Wyndham, John Lock, William Taverson, William Rutter, George Fenner, ecc.) che a partire dalla metà del Cinquecento raggiunsero le zone costiere dell’Africa occidentale, Richard Hakluyt nel secondo volume di The principall navigations, voiages and discoveries of the English nation, made by sea or over land, to the most remote and furthest distant quarters of the earth at any time within the compass of these 1500 yeres, un’antologia di resoconti di viaggio pubblicata fra il 1598 ed il 1600 e completata, dopo la sua morte, da quattro volumi (Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrims) curati da Samuel Purchas.
(27) “Gli uomini sono senza capelli, col capo tignoso e brutto, con gli occhi cispi; e il corpo fino alla cintura è vestito di pelli pelose […]. Le donne portano detto abito di pelli, e a esso appiccano una coda pilosa di simil bestia […]. Legge nessuna non tengono; mangiano carne cruda […]; parlano in gola con cenni e fischi, e giamai gli abbiam veduti esplicar parola espedita, perché avevamo fra noi uomini che sapevano varie lingue, me giamai potettono pigliar costrutto di loro lingua: e in conclusione sono uomini bestiali” (G. B. RAMUSIO, cit., I, pp. 744-745). Si tratta di una descrizione che contiene già alcuni degli ingredienti dell’immagine stereotipata di queste popolazioni dell’Africa australe che, assieme a quella coeva del tedesco Baltasar Springer arricchita anche da un’illustrazione, accompagnerà, come vedremo, tutta la storia della percezione europea di quel territorio.
(28) G. B. RAMUSIO, cit., I, p. 5.
(29) A. TRIULZI, L’Africa dall’immaginario alle immagini, in L’Africa dall’immaginario alle immagini. Scritti e immagini dell’Africa nei fondi della Biblioteca Reale, a cura di A. Triulzi (Torino II Salone del Libro, 12-18 maggio 1989), p. 6.
(30) G. BENZONI, L’Africa affabulata, in Africa. Storia di viaggiatori italiani, cit., pp. 92-94 (il corsivo è nostro).
(31) J. BODIN, La Mèthode de l’Histoire (1566), citato da O. ZHIRI, Les sillages de Jean Léon l’Africain du XVI eau XXe siècles Casablanca, 1995, p. 36.
(32) L. MASSIGNON, Le Maroc dans les premières années du XVIe siècle. Tableau géographique d’après Léon l’Africain, Algeri, 1906, p. 43, ha definito la Descrizione di Leone l’Africano “un manuel pratique de la géographie de l’Afrique du Nord”.
(33) Per queste valutazioni delle culture africane espresse da Leone l’Africano vedi il saggio di O. ZHIRI, L’Afrique au miroir de l’Afrique: fortunes de Jean-Léon l’Africain à la Renaissance, Ginevra, 1991, al quale rimandiamo anche per la ricostruzione della fortuna che questa opera conobbe, diventando “la base sur la quelle s’est constitué un fonds commun de savoir sur l’Afrique, ses pays et ses peuples” (p. 102), grazie agli adattamenti ed alle traduzioni in lingua latina, francese, spagnola, inglese e fiamminga, curati rispettivamente da Giovanni Floriano (Anversa, 1556), Jean Temporal (Anversa, 1556), Luis de Marmól de Carvajal, che visse ben ventidue anni in Africa (Granada, 1573), John Pory (Londra, 1600) e Arnout Leers (Rotterdam, 1665).
(34) O. ZHIRI, L’Afrique au miroir de l’Afrique, cit., p. 166; ma vedi anche P. MASONEN, cit., pp. 215-233.
(35) G. R. CARDONA, Introduzione a F. PIGAFETTA, Relazione del Reame del Congo, a cura di G. R. Cardona. Milano, 1978, p. XVIII
(36) F. PIGAFETTA, cit., p. 89.
(37) Nobili o selvaggi? L’immagine dell’Africa e degli Africani nelle illustrazioni europee dal Cinquecento al Settecento, Milano, s. d. (ma 1987) p. 11. D’altra parte, come ci ha fatto notare sempre Ezio Bassani, la stessa aura classica pervade anche le numerose figure di Africani disegnate nella raccolta di Habiti antichi et moderni di tutto il mondo di Cesare Vecellio, cugino di secondo grado di Tiziano, stampata a Venezia nel 1598, nella quale, ad esempio, l’immagine del moro di Zanzibar non può non richiamare alla mente le raffigurazioni di Ercole di tanta pittura classica e della scultura antica: per le caratteristiche di questa raccolta rimandiamo a J. GUERIN DALLE MESE, L’occhio di Cesare Vecellio. Abiti e costumi esotici nel ‘500, Alessandria, 1996.
(38) Per una dettagliata descrizione del contenuto e delle caratteristiche di questa carta, oltre che della sua “fortuna”, rimandiamo a R. BIASUTTI, La carta dell’Africa di G. Gastaldi (1545-1564) e lo sviluppo della cartografia africana nei secoli XVI e XVII, in Bollettino della Società Geografica Italiana, 1920, pp. 327-346 e 387-436.
(39) Vedi R. ALMAGIA’, Il globo di Livio Sanudo, in La Bibliofilia, XLVIII-L, 1946-1948, pp. 23-28.
(40) La diffusione del modello mercatoriano dell’Africa fu agevolata dal suo inserimento come tavola separata, dal titolo Africa: ex magna orbis terrae descriptione Grandi Mercatoris desumptis, nel terzo volume dell’Atlante pubblicato dal nipote un anno dopo la sua morte.
(41) M. MILANESI, Tolomeo sostituito. Studi di storia delle conoscenze geografiche nel XVI secolo, Milano, 1984, p. 76.
(42) L. MORALES OLIVER, Africa en la literatura española, Madrid, 1957, II, pp. 37-38.
(43) S. MUNSTER, Cosmographie universelle, Parigi, 1565, p. 1285. All’Africa è dedicato il secondo volume della Cosmographie universelle de tout le monde di François de Belleforest, pubblicata a Parigi nel 1577, che rappresenta un aggiornamento dell’opera del Münster.
(44) Le Relationi Universali di Giovanni Botero divise in quattro parti, Venezia, 1605.
(45) Vedi W. J. W. BLAKE, European Beginnings in West Africa, Londra, 1937; E. D. JONES, The Elizabethan Image of Africa, The University Press of Virginia, 1971.
(46) D. PEROCCO, L’invenzione dell’ignoto: il cuore dell’Africa nelle relazioni dei viaggiatori italiani, in AA.VV. Africa. Storie di viaggiatori italiani, cit., p. 72.
(47) O. ZHIRI, cit., pp. 25-26.
(48) Vedi l’ampia casistica esemplificata a questo proposito da R. M. COKE, South Africa as seen by the French (1610-1850). A bibliography, Città del Capo, 1957; W. G. L. RANDLES, L’image du sud-est africain dans la littérature européenne au XVIè siècle, Lisbona, 1959; R. MERCIER, L’Afrique noire dans la littérature française. Les premières images (XVII-XVIII siècles), Dakar, 1962; B. TURBET DELOF, L’Afrique barbaresque dans la littérature française aux XVIe et XVIIe siècles, Ginevra, 1973; A. J. BAKER, The Afrikan Link. British Attitudes to the Negro in the Era of the Atlantic Slave Trade, 1550-1807, Londra, 1978, W. B. COHEN, The French Encounter with Africans. White Response to Blacks, 1530-1880, Bloomington-Londra, 1980; Afriques imaginaries. Regards réciproques et discourse littéraire, XVIIe-XXe siècles. Actes des XIIe assises de l’A.F.S.S.A., a cura di A. Winchank e PH.-J. Salazar, Parigi, 1995; U. BITTERLI, Die Entdeckung des Schwarzen Afrikaners. Versuch einer Geistsegeschichte deu europaisch-afrikanischen Beziehungen ander Guineaküste im 17. und 18 Jahrhundert, Zurigo-Friburgo, 1980; A. THOMSON, Barbary and Enlightement. European Attitudes towards the Maghreb in the 18th Century, Londra, 1987; M. DOS SANTOS LOPES, Afrika. Eine neue Welt in deutsche Schriften des 16. und 17. Jahrunderts, Stoccarda, 1992; e L’Afrique au XVIIe siècle. Mithes et réalités. Actes du VIIe colloque du Centre Internationale de Rencontre sur le XVIIe siècle, Tunis 14-16 mars 2002, a cura di A. Baccar Bournaz, Tubingen, 2003.
(49) S. DU PLEIX, Corps de Philosophie. La Physique ou Science des choses naturelles, libro VII, cap. 22 (Les Monstres), Ginevra, 1623, p. 336, citato da C. CANGUILHEM, La monstrosuité et les monstreux, in Diogène, XL, 1969, p. 32.
(50) Concetti questi ribaditi alla fine del secolo da Antoine Furetière nel suo famoso Dictionnaire universel, dove si poteva leggere che “l’Afrique est pleine des monstres, a cause de l’accouplement des bestes feroces de differents especes qui s’y rencontrent” (citato da S. POLI, Stéréotypes d’Afrique dans la lexicographie du XVIIe siècle, entre tradition et modernité, in L’Afrique su XVIIe siècle. Mythes et réalités. cit., p. 53).
(51) F. NEGRI, Viaggio settentrionale, a cura di E. Falqui, Milano, 1929. Poche sono di conseguenza le immagini accattivanti, come quelle fornite, ad esempio, da René Du Chastellet des Boys che, ne L’Odyssée ou diversité d’avantures, rencontres et voyages en Europe, Asie et Afrique, dévisée en quatre parties (1665), seconda parte, p. 106, presenta l’Africa come un paese delle meraviglie “n’y ayant point de partie du monde si remplie de choses extraordinaires et nouvelles que celle-là”.
(52) Un motivo questo presente anche in un’edizione francese del 1747 del Dictionnaire Geographique Portatif, ou description de tous les royaumes, provinces, villes de quatre parties du monde di L. Echard, il quale, nella voce relativa alla Guinea, riferiva che “les moutons de ce pays ont du poil au lieu de laine et les hommes de la laine au lieux des cheveux”.
(53) Per il canonico Giovanbattista Barpo (1634) anche lo sperma degli Africani doveva essere nero, come nera doveva essere l’anima delle donne congolesi per il missionario cappuccino Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo (1687): vedi A.TRIULZI, cit.
(54) J. J. VIREY, Dictionnaire des sciences médicinales, Parigi, 1821, XXVI, p. 379; e R. JOBSON, The golden trade, or a discovery of the river Gambra, and the Golden Trade of the Aethiopians, Londra, 1623: citazioni tratte dal saggio di P. DARMON, I viaggiatori dell’età dei Lumi alla scoperta dell’Africa, in AA.VV., I viaggi nella storia. Le strade, i luoghi, le figure, Bari, 1968, p. 146.
(55) P. TARDIEU, Du bon usage de la monstruosité: la vision de l’Afrique chez Alonso de Sandoval (1627), in Bulletin Hispanique, LXXXVI, 1984, pp. 146-178. Ma vedi anche D. D. LOYD, African Animals in Renaissance Literature and Art, Oxford, 1979; ed E. HEVELMANS, Les bêtes humaines d’Afrique, Parigi, 1980.
(56) A questo argomento è dedicato il secondo capitolo (Les Africains et le mythe biblique de Cham) del saggio di A. QUENUM, Les Eglises chrétiennes et la traite atlantique du XVe au XIXe siècle, Parigi, 1993. Numerosi autori del XVII e XVIII secolo e dei primi decenni dell’Ottocento – da Richard Jobson (1623) a Jean Louis Hanemann (1677), Hugh Jones (1724), William Byrd (1736) – fecero propria la storia della maledizione di Cam, fondata su un oscuro passo del libro della Genesi, mettendola quasi sempre in rapporto con la tratta degli schiavi (vedi W. SOLLORS, La maledizione di Cam: ovvero dalla generazione alla “razza”, in Il razzismo e le sue storie, a cura di G. Imbruglia, Napoli, 1992, p. 193).
(57) Il rapporto tra la crescita di interesse e di attenzione per l’Africa occidentale e, di conseguenza, del numero dei testi che ad essa facevano riferimento e lo sviluppo della tratta può trovare conferma anche nel fatto che nel corso del Seicento prevalsero le edizioni pubblicate nei Paesi Bassi, nei quali nel 1621 venne costituita la West-Indische Compagnie (WIC) che controllava allora la maggior parte dei traffici commerciali delle zone costiere della Guinea (E. VAN DEN BOOGAART, Books on Black Africa. The Dutch publications and their owners in the 17th and 18th centuries, in B. HEINTZE – A. JONES, a cura di, Europeans sources for sub saharan Africa before 1900: use and abuse, Frankfurt am Main, 1987, pp. 115-126, ha fatto notare come uno dei direttori della WIC, Joannes de Laet, disponesse di un cospicuo numero di opere sull’Africa), mentre nel corso del Settecento prevalsero quelle pubblicate in Inghilterra, le cui compagnie commerciali erano riuscite a prendere il sopravvento nella gestione della tratta.
(58) Ricordiamo in particolare A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave Trades del capitano William Snelgrave, pubblicato nel 1727, e le Memoirs of the Reign of Bossa Ahadee, King of Dahomey di Robert Norris, edite nel 1879.
(59) Questa ipotesi è stata avanzata e sostenuta da L. K. WALDMAN, An Unnoticed Aspect of Archibald Dalzel’s History of Dahomy, in Journal of African History, VI, 1965, pp. 185-192.
(60) A. DALZEL, History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa, Londra, 1793, pp. 26 e 217.
(61) Per queste considerazioni vedi C. MIOTTI, La “History of Dahomy” di Archibald Dalzel (1793), in Miscellanea di Storia delle esplorazioni, XIII, 1988, pp. 236-237.
(62) Vedi, a questo proposito, i repertori di A. JONES, Double Duthc? A survey of Seventeenth century German sources for the West African history, in History in Africa, IX, 1982, pp. 141-173; IDEM (a cura di), German sources for West African history, 1680-1700, Wiesbaden, 1983; IDEM, Semper aliquid veteris. Printed sources for the history of the Ivory and Gold Coast, 1500-1750, in Journal of African History, XXVII, 1986, pp. 215-235; mentre, per un panorama delle pubblicazioni relative anche alle altre aree del continente africano, rimandiamo a G. BOUCHER DE LA RICHARDERIE, Bibliotèque universelle des voyages ou notice complète et raisonnée de tous les voyages anciens et modernes dans les différents parties du monde, Parigi, 1806-1808 (ristampa anastatica: Ginevra, 1970, che ha dedicato all’Africa cinque sezioni della seconda parte del suo ancor utile repertorio); G. ATKINSON, La literature géographique française de la Renaissance. Répertoire bibliographique, Parigi, 1935 (ristampa anastatica: Ginevra, 1969); E. G. COX, A reference guide to the literature of travel, Seattle, 1935-1938.
(63) Sull’incapacità di comprendere l’alterità africana che emerge da questi resoconti ha sviluppato alcune considerazioni meritevoli di attenzione W. MAC GAFFEY, Dialogues of the deaf: European on the Atlantic coast of Africa, in Implicit Understandings. Observing, Reporting and Reflecting on the Encounter Between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era, Cambridge, 1994, pp. 249-267.
(64) In questa famosa raccolta, corredata da un consistente apparato iconografico, oltre che il resoconto della relazione di Pieter de Marees, vennero inseriti anche la Navigatio et Itinerarium in Orientalem Indiam di Jean Huyen van Linschoten e la relazione di Samuel Brun (1624).
(65) Su questo problema vedi le considerazioni di R. LAW, Problems of plagiarism, harmonization and misunderstanding, in B. HEINTZE – A. JONES, cit., pp. 338-358; e H. M. FEINBERG, An 18th century case of plagiarism: William Smith’s A new voyage to Guinea, in History in Africa, VI, 1979, pp. 45-50.
(66) K. DELAUNAY, Voyages à la Côte de l’Or (1500-1750. Etude historiographique des relations de voyage sur le littoral ivorien et ghanéen, Parigi, 1994, pp. 35-37. Vedi pure K. DELAUNAY, La Côte de l’Or vue par les Européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, in Cahiers d’études africaines, 1989, 115-116, pp. 447-453.
(67) “On sera sans doute surpris – faceva notare questo missionario – d’y avoir des royaumes dont le monarques sont des paysans, des villes qui ne sont faites que des roseaux, des vaisseaux construits d’un seul arbre; et sourtout des peuples qui vivent sans soin, qui partent sans règle, qui négocient sans écriture, qui marchent sans habit”.
(68) Dapper sarebbe stato a sua volta accusato di plagio nei confronti della Description generale de l’Afrique second partie du monde, compilata da Pierre d’Avity e pubblicata a Parigi nel 1637.
(69) O. DAPPER, Description de l’Afrique, contenant Les Moeurs, la Situation & les Confins de toutes ses Parties, leurs Rivieres, leurs Villes & leurs Habitants, leur Plantes & leurs Animals; les Moeurs, les Coûtumes, la Langue, les Richesses & le Gouvernement de ses Peuples…, Amsterdam, 1686.
(70) T. FILESI, Realtà e prospettive della storiografia africana, Napoli, 1978, p. 98. Ma vedi anche G. THILMANS, Le Senegal dans l’oeuvre d’Olfried Dapper, in Bulletin de l’Institut Française de l’Afrique Noire, serie B, XXXIII, 1971, pp. 508-563; A. JONES, Olfert Dapper et sa Description de l’Afrique, in Objets interdits, Parigi, 1989, pp. 73-84; IDEM, Decompiling Dapper. A preliminary search for evidence, in History in Africa, XVII, 1990, pp. 171-209.
(71) Questo espediente, al quale era già ricorso anche un commerciante di La Rochelle, Jean Barbot, per la sua Description des Côtes d’Afrique, redatta fra il 1683 ed il 1688 e rimasta inedita fino a quando A. e J. Churchill non la avrebbero inserita, in traduzione inglese, nella loro collezione di relazioni di viaggio, venne utilizzato pure da Paul Erdman Isert, medico-ispettore della corona danese nei possedimenti africani nel resoconto dei suoi viaggi in Guinea e nelle isole dei Caraibi, pubblicato a Copenaghen nel 1790; e da Jhon Matthews nel resoconto del viaggio da lui compiuto fra il 1785 ed il 1787 lungo la zona costiera della Sierra Leone pubblicato a Londra nel 1788.
(72) W. BOSMAN, Nouveau Voyage de Guinée contenant une description nouvelle et très exacte de cette côte, Parigi, 1705, pp. 2-5.
(73) F. MOORE, Travels into the inland parts of Africa, Londra, 1738, pp. V-VI (la traduzione ed il corsivo sono nostri)
(74) M. MILANESI, cit., pp. 80-81 (il corsivo è nostro).
(75) Ann Thomson rigetta infatti come “not totally accurate” (A. THOMSON, cit. p. 3) quanto in questo senso avevano già affermato e sostenuto pure studiosi come Lucette Valensi, Wadi Bouzar e Numa Broc.
(76) Fra le più significative, fra quelle a suo tempo pubblicate, ricordiamo le testimonianze, frutto di esperienze dirette, trasmesseci da Laugier de Tassy, un ufficiale di marina addetto al console francese di Algeri che, grazie alla sua funzione, potè raccogliere una documentazione di prima mano per redigere una Histoire du Royaumes d’Algérie, avec l’état présent de son gouvernement, de ses force de terre et de mer, de ses police, justice, politique et commerce, Amsterdam, 1725; George Hoest (Efferetninger om Marokos och Fez, Samlete der i landene, fra 1760 to 1768, Copenaghen, 1771); Thomas Shaw (Travels or Observations Relating to Several Parts of Barbary and the Levant, Oxford, 1738), il cappellano della fattoria inglese di Algeri, che fra il 1720 ed il 1732 percorse in tutte le direzioni le reggenze di Algeri e Tunisi; Alexander Jardine (Letters from Barbary, France, Spain, Portugal… by an English officer, Londra, 1788), un cadetto della Royal Military Academy; l’abate Jean-Louis-Marie Poiret (Voyage en Barbarie, ou lettres écrites de l’ancienne Numidie pendant les années 1785 et 1786, sur la religion, les coutumes et les moeurs des Maures et des Arabes-Bédouins, avec un Essai sur l’histoire naturelle de ce pays, Parigi, 1789), che, alla ricerca di nuove piante ed animali selvaggi, ma anche delle tracce dell’antichità, esplorò la pianura di Tunisi, i dintorni di Bona e Bugia e si spinse fino a Costantina; William Lamprière (Tour from Gibraltar to Tangier, Sale, Mogador, Santa-Cruz, Tarudant and ver Mount Atlas, in Marocco, Londra, 1791), medico inglese, che si recò in Marocco per curare il figlio dell’imperatore che correva il rischio di perdere la vista; Johan von Rehbinder (Narichten und Bemerkungen über den algierischen Staat, Altona, 1798-1800, tre volumi). Per un’articolata analisi di queste, come di molte altre fonti rimaste inedite, o pubblicate successivamente, sugli stati barbareschi, vedi i saggi di G. TURBET-DELOF, L’Afrique Barbaresque, cit.; IDEM, La Presse périodique française et l’Afrique barbaresque au XVIIe siècle (1611-1715), Ginevra, 1973; IDEM, Bibliographie critique de l’Afrique barbaresque dans la littérature française (1532-1715), Algeri, 1976 D. BRAHIMI, Opinion et regards des Européens sur le Maghreb aux XVIIe et XVIIIe siècles, Algeri, 1978; A. THOMSON, cit.
(77) G. TURBET-DELOF, L’Afrique Barbaresque, cit., p. 313.
(78) Lettere di Giovanni Pagni medico, ed archeologo pisano a Francesco Redi in ragguaglio di quanto egli vidde, ed operò in Tunisi, Firenze, 1829.
(79) Vedi S. BONO, Il paese dei Barbareschi, in AA..VV., Africa. Storie di viaggiatori italiani, cit. pp. 141-142, il quale, definendola “un testo fondamentale per la nostra conoscenza del mondo barbaresco” (p. 139) sottolinea anche l’interesse di una relazione (Africa overo Barbaria) trasmessa al doge di Venezia da un oriundo genovese nato a Costantinopoli, Giovambattista Salvago, che era stato incaricato di sollecitare dai governanti di Tunisi e di Algeri la liberazione di alcune centinaia di sudditi veneti catturati nel 1624 nell’assalto di una flotta corsare nella località di Perasto, nelle bocche di Cattaro, nonché di raccogliere notizie ed osservazioni sulle due Reggenze.
(80) Introduction a Trois français au Sahara Occidentale en 1784-1786, a cura di M. Barbier, Parigi, 1984, p. 27 (edizione dei resoconti delle tre vicende che ebbero loro malgrado protagonisti i francesi Follie, Saugnier e Brisson, che fecero naufragio fra il 1784 ed il 1785 e restarono a lungo prigionieri nel Sahara occidentale).
(81) Ma vedi anche quelli di Le Sieur de Rocqueville (Relations des Moeurs et de Gouvernement des Turcs d’Alger, Parigi, 1675: resoconto di cui si è occupato F. LOUALICA, Alger au XVIIe siècle: le regard d’un captive porteur d’eau (le sieur de Rocqueville), in L’Afrique au XVIIe siècle. Mythes et réalités, cit., pp.181-188, che lo ha definito “un témoignage édifiant et vivant sur le mode de vie des algérois au XVIIe siècle et sur l’organisation urbaine de la ville d’Alger”, p. 188); Simon Ockley (An Account of the South-West the Barbary, containing what is most Remarkable in the Territories of the King of Fez and Morocco Written by a Person who had been a Slave there a considerable Time, Londra, 1713), e di J. Foss (A Journal of the Captivity and Suffering of. J. Foss; several years a Prisoner at Algiers, Newburyport, 1728).
(82) Cfr. M. MORSY, La relationde Thomas Yellow, une lecture du Maroc au XVIIIe siècle, Parigi, 1983; e F. SURDICH, Dalla Cornovaglia alla Berberia: l’avventurosa vita di Thomas Pellow, in Da Ulisse a…. Il viaggio nelle terre d’oltremare, cit., pp. 281-294.
(83) Per queste fonti rimandiamo all’accurato studio di T. FILESI-I. DE VILLAPADIERNA, La “Missio antiqua” dei Cappuccini nel Congo (1645-1835). Studio preliminare e guida delle fonti, Roma, 1978.
(84) G. A. CAVAZZI DA MONTECUCCOLO, Istorica descrittione de’ tre regni Congo, Matamba, et Angola, situati nell’Ethiopia inferiore occidentale et delle Missioni Apostoliche esercitatevi da Religiosi Cappuccini, Bologna, 1687, p. 260.
(85) ANTONIO DA GAETA-F. M. GIOIA DA NAPOLI, La meravigliosa conversione alla Santa Fede di Cristo della Regina Singa e del suo Regno di Matamba nell’Africa Meridionale, Napoli, 1669, p. 124. Piuttosto frequenti sono nei resoconti di questi missionari i riferimenti alla presenza del diavolo nelle manifestazioni religiose e della vita quotidiana di quelle popolazioni, come ha sottolineato F. SURDICH, Il “Diavolo” nella cultura del viaggio del Cinque e Seicento, in Cultura e innovazione, IV, n. 2, giugno 1999, pp. 12-19.
(86) V. MACONI, Antologia missionaria africana tratta da un manoscritto inedito del sec. XVII, in Miscellanea Carlo Figini, Vengono Inferiore, 1965, p. 341.
(87) A. ZUCCHELLI DA GRADISCA, Relazione del viaggio e Missione di Congo nell’Etiopia Inferiore Occidentale, Venezia, 1712, pp. 199-200.
(88) A. DA GAETA-F. M. GIOIA DA NAPOLI, cit., pp. 405-406.
(89) Il primo manoscritto della Missio antiqua ad essere pubblicato fu in realtà una breve relazione indirizzata da Pinda, l’8 giugno 1646, al convento dei cappuccini di Siviglia dal padre spagnolo Angelo da Valencia, stampata a Cadice nel 1646 e, sempre nello stesso anno, anche a Siviglia (E. DE SOLLANA, Escritores de la provincia capuchina de Valencia. Ensayo bibliográfico: impresos de 1592-1962, Valenza, 1963, pp. 34-37).
(90) C. PIAZZA, Dionigi da Piacenza, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 1991, LXI, p. 198.
(91) Il punto di riferimento furono probabilmente tre manoscritti autografi del Cavazzi di complessive 1568 pagine, che si conservano presso la famiglia del dottor Carlo Araldi di Modena (vedi G. PISTONI, I manoscritti “Araldi” di Padre Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo, in Atti e Memorie della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, serie VI, vol. XI, 1969) e che comprendono anche 33 disegni ad inchiostri colorati, di cui però solo sette sarebbero stati ripresi nell’edizione a stampa, che, come ha sottolineato E. BASSANI, Un cappuccino nell’Arica Nera del Seicento. I disegni dei Manoscritti Araldi del Padre Giovanni Antonio Cavazzi da Montecuccolo, in Quaderni Poro, n. 4, 1987, costituiscono la prima testimonianza figurativa (1665) eseguita in Africa da un europeo, con i personaggi, i costumi e i manufatti locali sotto gli occhi.
(92) Servendosi di quest’opera, Jean-Baptiste Labat, che, dopo essere rientrato da undici anni di attività missionaria nei Caraibi, aveva già curato, come abbiamo già visto, l’edizione del resoconto del viaggio del cavaliere Des Marchais in Guinea ed avrebbe successivamente assemblato anche le memorie dei viaggi del cavaliere d’Arvieux in Asia, Siria, Palestina e Barberia, compilò, integrandola con le relazioni di diversi autori portoghesi, una Relation historique de l’Ethiopie occidentale contenant la Description des Royaume de Congo, Angola, & Matamba, edita in sette volumi a Parigi nel 1732. Questo domenicano, che F. WOLFZETTEL, Le discours du voyage. Le récit de voyage en France, du Moyen Age au XVIIIe siècle, Parigi, 1996, ha definito “le premier écrivain ‘professionel’ de la littérature de voyages” (p. 261), compilò, attingendo soprattutto al Journal di André Bruë, che, prima fra il 1697 ed il 1722 e poi fra il 1714 ed il 1720, aveva diretto la Compagnie du Sènégal ed aveva risalito il corso del Senegal creando uno scalo commerciale a Galamv, pure un’erudita Nouvelle Relation de l’Afrique occidentale, contenant une Description exacte du Senegal et des Pais situés entre le Cap-Blanc & la Rivière de Serre-lionne, jusqu’à plus de 300 lieues en avant dans le terres, apparsa in cinque volumi a Parigi nel 1728, nella quale “l’Afrique est insérée dans un réseau d’intérêts européens qui en conditionnent lourdement l’image” (questa precisazione è di C. BIONDI, L’Afrique des philosophes: lieu mythique, terre d’hommes ou entrepôt des marchandises?, in L’homme des Lumière set la découverte de l’autre, a cura di D. Droixhe e P.-P. Gossiaux,Bruxelles, 1985, p. 191) .
(93) T. FILESI-I. DE VILLAPADIERNA, cit., pp. 112 e 153.
(94) C. PIAZZA, Alcune tradizioni orali sulle origini del regno di Kongo, in Annali del Pontificio Museo Missionario Etnologico già Lateranensi, XXXVIII, 1974, pp. 237-259.
(95) Vedi G. BALANDIER, La vie quotidienne au Royaume de Kongo du XVIe au XVIIIe siècle, Parigi, 1965; e W. G. L. RANDLES, L’antico regno del Congo, Milano, 1979.
(96) V. MACONI, Saggi di alcune note etnografiche in un manoscritto ineito del 1600 sul Congo, in Atti del I Congresso di scienze antropologiche etnologiche e di folklore, Torino, 1961; IDEM, Antologia missionaria africana., cit.; IDEM, Magische Handlungen der Eingeborenen Nord-West Angolas, in Kôlber Ethnologische Mitteilungen, IV, 1965, pp. 135-159.
(97) M. G. PARODI DA PASSANO, Frammenti di vita bantù in un manoscritto inedito del Seicento: società e simboli kimbundu nella relazione di Fra Giovanni Belotti da Romano, in Miscellanea di Storia delle esplorazioni, VII, 1982, pp. 101-132.
(98) C. PIAZZA, La prefettura apostolica del Congo alla metà del XVII secolo. La relazione inedita di Gerolamo da Montesarchio, Milano, 1976, p. 288.
(99) Per ulteriori indicazioni su questi testi vedi T. FILESI-I. DE VILLAPADIERNA, cit., pp. 79-91 e 182-192.
(100) A quelli concernenti i territori di cui ci siamo occupati in questa sede si dovrebbero aggiungere pure quelli relativi al Madagascar che, come ha posto in rilievo J.-M. RACAULT, Madagascar dans les littératures de voyage de la seconde moitié du XVIIe siècle. Mythes et réalités, cit. , p. 203, “demeure jusqu’à la fin du XVIIe siècle et même au-delà un territori mal connu qui focalise spéculation , mythes et fantasmes”. Per la descrizione di questa grande isola, riconosciuta per la prima volta nel maggio 1500 da Diogo Dias, capitano di una delle navi della flotta portoghese di Pedro Alvares Cabral, ci si può rifare alla monumentale Collection des Ouvrages Anciens Concernant le Madagascar, costituita da nove volumi messi assieme all’inizio del Novecento da Alfred et Guillaume Grandidier, che hanno raccolto e commentato le principali testimonianze trasmesse dai viaggiatori europei fino all’Histoire de la Grand Isle de Madagascar di Etienne de Flacourt, frutto di un soggiorno di oltre dieci anni (1648-1758) a Fort-Dauphin, che, pubblicata a Parigi in due versioni nel 1658 e nel 1661, resta ancor oggi la principale fonte storica ed antropologica dell’antica società malgascia all’epoca dei primi stanziamenti francesi. Ma vedi anche il repertorio di N. GALIBERT, Chronobibliographique analytique de la littérature de voyage imprimée en français sur l’Océan Indien (Madagascar-Réunion-Maurice) des origines à 1896, Parigi, 2002.
(101) Per la struttura ed i contenuti di queste raccolte rimandiamo a G. R. CRONE-R. A. SKELTON, English collections of voyages and travels, 1625-1846, in Richard Hakluyt and his successors. A volume to commemorate the Centenary of the Hakluyt Society, a cura di E. Lynam, Londra, 1946; ed a Le monde en ordre. Les collections de voyage, a cura di M. Duchet, Parigi, 1984.
(102) I primi sette volumi vennero tradotti dalla A New General Collection of Voyages and Travels, consisting of the most esteemed relations, wich have been hitherto published in any language, comprehending everything remarkable in its kind, in Europe, Asia, Africa and America, pubblicata a Londra fra il 1745 ed il 1747 da John Green per iniziativa di Thomas Astley, di cui J. J. Schwabb avrebbe curato, fra il 1747 ed il 1774, un’edizione tedesca in ventuno volumi (Allgemeine Historie der Reisen zu Wassser und Lande)
(103) Tre volumi di supplemento ed un Atlante vennero pubblicati tra il 1761 ed il 1770 per iniziativa di Meusnier de Querlon, che dopo la morte di Prévost ne aggiornò l’opera. Parallelamente venne pubblicata anche un’edizione in-12° in 64 volumi.
(104) J. SGARD, Prévost, de l’ombre aux lumières, in Studies on Voltaire and Eighteenth Century, a cura di Th. Bestermann,Ginevra, 1963, pp. 1484-1485: IDEM, Prévost romancier, Parigi, 1968, p. 497.
(105) Per queste valutazioni dell’opera del Prévost ci siamo rifatti al lavoro di M. DUCHET, Le origini dell’antropologia. I. Viaggiatori ed esploratori del Settecento, Roma-Bari, 1976, pp. 79-95.
(106) Ma vanno ricordati anche alcuni repertori tematici come, ad esempio, la Recueil d’observations sur les moeurs, les différents langues, le gouvernement de différents peuples de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, compilata da C. F. Lambert e pubblicata a Parigi nel 1749; l’Histoire des différents peuples du monde, contenant les cérémonis religieuses et civiles, l’origine des religions, leurs sectes et superstitions, et les moeurs et usages de claque nation, compilata da G. Contant d’Orville e pubblicata a Parigi fra il 1770 ed il 1771; ed i volumi, ricchi di oltre duecento illustrazioni, sulle Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde représentées par des figures dessinées de la maison de Bernard Picart avec des explications historiques…, pubblicati ad Amsterdam fra il 1723 ed il 1743, per i quali rimandiamo a D. PREGARDIEN, L’Iconographie des Cérémonies et coutumes de B. Picart, in L’homme des Lumière…, cit., pp. 183-190; e, per la parte relativa alle religioni africane, a P.-P. GOSSIAUX, Image des religions noires dans la littérature occidentale classique (1530-1570), in Revue universitarie du Burundi, I, nn. 1-2, 1972, pp. 9-43 e 83-103; nn. 3-4, 1973, pp. 219-244.
(107) Questo termine non designava allora un territorio ed una etnia particolari, tanto che Le Grand Dictionnaire historique del Moréri, pubblicato a Parigi nel 1759, alla voce Cafrerie o Côtes des Cafres precisava che “Cafre veut dire sans loi et vient du mot cafir […], que les Arabes appliquent à tous ceux qui nient l’unitè d’un Dieu, et qu’ont a donné aux habitants de ces pays, parce qu’on a cru qu’ils n’avaient ni princes, ni religion” (citazione tratta da CH. BIET- S. ROQUEMORE, L’Afrique à l’envers ou l’endroit des Cafres: tragédie et récit de voyage au XVIIe siècle, in L’Afrique au XVIIe siècle. Mythes et réalités., cit., pp. 391.392).
(108) Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni e correzioni degli antichi e moderni viaggiatori, Venezia, 1765, vol. XXVI.
(109) Questo tipo di approccio eserciterà la sua influenza anche sulla letteratura utopica, come ci attesta La terre Australe connue […] par Mr Sadeur (1670) di Gabriel de Foigny, dove, secondo P. CARILE, Huguenots sans frontiers. Voyage et écriture à la Renaissance et à l’Age classique, Parigi, 2001, p. 185, “le personnage du Cafre-Hottentot fait sa première apparition”.
(110) Vedi D. LANNI, L’Europe classique à l’epreuve de l’extrême alteritè: le Cafre et le Hottentot dans le discours des voyageurs au XVIIe siècle, in L’Afrrique au XVIIe siècle. Mythes et réalités, cit., p. 220.
(111) Per un’esauriente e documentata ricostruzione “de ce que les Européens ont aperçu ou vu, compris, deviné, de ce qu’ils ont dite et écrit au sujet des habitants de l’extremité de l’Afrique, des hypothèses qu’il se sont cru autorisés à émettre, des certitudes qu’il ont transmises aux générations suivantes, des actions qui en ont découlé, des remises en question, des changements d’opinion” che a questo riguardo si sono sviluppate a partire dalle relazioni dei viaggiatori portoghesi di fine Quattrocento fino all’attenzione riservata a queste popolazioni dai naturalisti ed antropologi dell’Ottocento, vedi l’accurato saggio, al quale pertanto rimandiamo per le molte cose su questo argomento che non ci è stato possibile riprendere e riproporre in questa sede, di F.-X. FAUVELLE-AYMAR, L’invention du Hottentot.. Histoire du regard occidental sur le Khoisan (XVe-XXe siècle), Parigi, 2002.
(112) Vedi M. CORBETT-M. NORTON, Engraving in England in the sixteenth and seventeenth centuries, Cambridge, 1964, III, pp. 163-164.
(113) Nell’appendice del titolo di questo resoconto si segnala che si sarebbe fatto riferimento “alle costumanze, all’abbigliamento, all’organizzazione familiare, al matrimonio, all’educazione dei figli, alle superstizioni, alle usanze amorose, alle armi, alle danze, al commercio ed ai mestieri, alle abitazioni, alla concezione della morte, ai ritii funerari di quelli che si chiamano Ottentotti”.
(114) Voyages de Nicolas de Graaf aux Indes Orientales et en d’autres lieux de l’Asie, Amsterdam, 1719, pp. 14-15 (l’originale olandese è del 1701).
(115) Vedi P. KOLB, Description du Cap de Bonne-Espérance, où l’on trouve tout ce qui concerne l’Histoire naturelle du pays, la Religion, les Moeurs, les Usages des Hottentots, Amsterdam, 1741.
(116) J.-PH. ROUSSELOT de SURGY, Mélanges intéressants et curieux, ou abrégé d’histoire naturelle, morale, civile et politique de l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, et des terres polaires, Parigi, 1765, X, pp. 164-166.
(117) M. QUAINI, La centralità del paradigma cartografico-statistico nella conoscenza dell’Africa fra Settecento e Ottocento, in Culture dell’alterità. Il territorio africano e le sue rappresentazioni, a cura di E. Casti e A. Turco, Milano, 1998, pp. 333-334
(118) La scelta di concentrare l’analisi sulla percezione degli Ottentotti viene giustificata da questa studiosa in base al fatto che nessun popolo più di questo sembra incarnare meglio “l’ambiguità tipica di una certa idea di savaugerie, simbolo speculare di una primitività felice ed innocente ed espressione al tempo stesso delle più arretrate forme di degradazione umana”, per cui nel trasformarsi e nel precisarsi della sua immagine “si possono forse cogliere insieme i segni del superamento di questa ambiguità e del maturarsi dello sguardo etnografico, entrambi frutto di una conoscenza che si va facendo sempre più precisa e particolareggiata” (p. 137). Sull’iconografia relativa agli Ottentotti vedi anche il contributo di E. BASSANI – L. TEDESCHI, The image of Hottentot in the seventeenth and eighteenth centuries. An iconographic investigation, in Journal of the History of the Collections, II, 1990, pp. 157-186.
(119) Per queste considerazioni (ma anche per molte altre altrettanto stimolanti di cui non ci è stato possibile tener conto in questa sede), vedi la circostanziata analisi, corredata da un utilissimo apparato iconografico adeguatamente commentato, di G. PALUMBO, L’immagine e la parola: il progresso della conoscenza dell’Asia e dell’Africa e la trasformazione della simbologia iconografica, in La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX, a cura di A. Gallotta e U. Marazzi, vol. II, tomo, I, Napoli, 1989, pp. 131-189
(120) Secondo R. HALLETT, The european approach to the interior of Africa in the XVIIIth century, in Journal of African History, IV, 1963, pp. 191-206, la carta dell’Africa del D’Anville, pubblicata nel 1751 ed aggiornata nel 1761, 1770 e 1777, ha messo in evidenza i grandi limiti delle carte precedenti spingendo i Francesi e gli Inglesi a sviluppare in maniera più decisa l’esplorazione delle parti interne dell’Africa.
(121) Per questa nuova fase della scienza geografica vedi il saggio di N. BROC, La Géographie des pholosophes, cit., al quale rimandiamo (vedi in particolare pp. 333 e sgg.) per tutte le considerazioni sviluppate nella parte conclusiva di questo nostro lavoro.
(122) M. DUCHET, La nascita dell’antropologia. I. Viaggiatori ed esploratori del Settecento, Roma-Bari, 1976, pp. 26 e 29.
(123) Ivi, p. 30.
(124) J. MOUNIAMA, Adanson, un naturalista in Senegal, in Declinazioni d’Africa, a cura di A. Turco, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1997, p. 200, contributo al quale abbiamo largamente attinto anche per le notizie successive ed al quale rimandiamo per ulteriori indicazioni bibliografiche sulla figura e l’attività scientifica di Adanson.
(125) M. ADANSON, Histoire naturelle du Senegal […] avec la relation abrégée d’un voyage fait en ce pays pendant les années 1749, 1750, 1751, 1752 & 1753, Parigi, 1757, p. 3 (il resoconto di viaggio, che in alcuni aspetti risulta influenzato dai racconti di altri viaggiatori da cui Adanson riprende alcuni tradizionali stereotipi, occupa duecento pagine).
(126) J. MOUNIAMA, cit., p. 199.
(127) A lui si deve la prima descrizione di carattere scientifico del baobab (non a caso poi battezzato Adansonia digitata dai naturalisti): “C’était un calebassier […] que les Oualofes nomment gouic. Sa hauteur n’avait rien d’extraordinaire […] mais son tronc était d’une grosseur démesurée. Je ne crois pas qu’ont ait jamais rien vu de pareil dans aucune partie du monde […]. Du tronc partaient plusieurs branches, dont quelques unes s’étendaient horizontalement et touchaient la terre par leurs extrémités; tout l’ensemble paraissait moins former un seul arbre qu’une fôret” (pp. 54-55).
(128) J. MOUNIAMA, cit., p. 210.
(129) “De quelque côté que je tournasse les yeux dans ce riant séjour – scrive ad esempio Adanson -, tout ced que j’y voyais me retraçait l’image la plus parfaite de la pure nature; une agréable solitude qui n’était bornée de tous les côtés que par la vue d’un paysage charmant; la situation champêtre des cases au milieu des arbres, l’oisivité et la mollasse des négres couchés à l’ombre de leur feuillage, la simplicité de leur habillement et de leurs moeurs tout cela me rappelait l’idée des premiers hommes, il me semblait voir le monde à sa naissance” (M. ADANSON, cit., pp. 210-211: il corsivo è nostro).
(130) Vedi M. DUCHET, cit., I, p. 54.
(131) J. MUONIAMA, cit., p. 213.
(132) Sui viaggi compiuti nella seconda metà del Settecento nel territorio sudafricano vedi V. S. FORBES (a cura di), Pionneer Travellers of South Africa. A Geographical commentary upon routes, records, observations and opinions of travellers at the Cape, 1750-1800, Città del Capo, 1965.
(133) Vedi H. HOP (ma il resoconto fu redatto da Brink), Nouvelle description du Cap de Bonne-Espérance, avec un journal historique d’un voyage de terre (…) dans l’intérieur de l’Afrique, Amsterdam, 1778 (l’originale olandese, in due volumi, è del 1777).
(134) A. SPARRMAN, Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autour du monde avec le capitaine Cook, et principalement dans les pays des Hottentots et des Caffres, Parigi, 1787, I, pp. XXVII-XXIX (la traduzione è di Silvia Contarini): l’edizione originale in svedese è del 1783: per una bibliografia completa relativa al viaggio dello Sparrman al Capo, vedi A. M. LEWIN-ROBINSON, A contribution to the bibliography of Sparrman’s voyage to the Cape of Good Hope, in Quarterly Bulletin of South African Library, X, 1946. Sulle osservazioni relative agli Ottentotti di La Caille e Sparrman vedi le considerazioni di A. GUNNY, Voyageurs européennes aux Mascareignes et en Afrique du Sud, in L’homme des Lumières…, cit. pp. 163-175, che ha tenuto conto anche del resoconto dell’inglese Thomas Herbert (A Relation et some years travaile, begunne anno 1626 into Afrique and the greater Asia, Londra 1634), uno dei primi viaggiatori europei che soggiornò a Città del Capo; e del protestante François Leguat (Les Voyages et Aventures de François. Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes orientales, Amsterdam- Londra, 1708), che non si soffermò però solo sugli aspetti pittoreschi o stravaganti per un europeo delle abitudini degli Ottentotti, come l’usanza di togliere un testicolo ai neonati, ma rivolse la sua attenzione anche alla loro economia politica ed alle loro istituzioni.
(135) Vedi W. PATERSON, A Narrative of four journeys into the country of the Hottentots and Caffraria in the years one thousand seven hundred and seventy-seven, eight, and nine, Londra, 1789; un resoconto nella cui prefazione sottolineava polemicamente come fosse “più facile inventare che osservare con esattezza, per cui molti fatti meschini sono bastati a molti Autori per scrivere nei loro gabinetti delle relazioni assai brillanti”.
(136) Fra il 1796 ed il 1812 Levaillant avrebbe compilato e pubblicato anche una Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique in sei volumi.
(137) F. LEVAILLANT, Primo viaggio all’interno dell’Africa pel Capo Buona Speranza, Milano, 1816, II, p. 244 (la citazione è dalla traduzione italiana del 1816 di Francesco Contarini inserita nella Raccolta di viaggi più interessanti eseguiti nelle varie parti del mondo dopo quelli di James Cook, pubblicata da Giambattista Sonzogno).
(138) Siamo debitori di queste riflessioni sui resoconti di Levaillant a S. CONTARINI, Introduzione a F. LEVAILLANT, Primo viaggio nell’interno dell’Africa, a cura di S. Contarini, Firenze, 1994.
(139) Anche Pierre-Louis Moreau de Maupertuis poco più di trent’anni prima (1752) nella Lettre sur le progrés des sciences aveva raccomandato l’esplorazione dell’Africa con lo stesso calore con cui si raccomandava allora quella delle terre australi perché “tutto questo vasto continente ci è quasi altrettanto poco noto” (p. 48).
(140) J. N. BUACHE, Mèmoire sur la géographie de Ptolémée, et particulièrement sur la description de l’intérieur de l’Afrique, in Histoire de l’Académie Royale des Sciences, année 1787, Parigi, 1789, pp. 119-120 e 127.
DIGNITE’ DES OBJETS DE CULTE ADJA-EVHE’
Albert de Surgy
DIGNITE’ DES OBJETS DE CULTE ADJA-EVHE’
(articolo pubblicato in “Archeologia Africana – Saggi Occasionali” 2003-2004 numero 9/10)
Les populations riveraines du Golfe de Guinée entretiennent des rapports avec une multitude d’objets de culte qui n’ont cessé d’étonner, de fasciner, d’inquiéter, souvent même d’horrifier, les observateurs européens. Tantôt dévalorisés comme objets de curiosité plus ou moins diaboliques car incarnant de mystérieuses puissances utilisables à des fins répréhensibles, tantôt valorisés, au contraire, en tant qu’objets d’art, pour ce qu’ils ne sont pas, ils demeurent profondément méconnus.
Je me propose, ci-dessous, sur la base d’enquêtes effectuées au sein des groupes de langue évhé qui se répartissent, au Togo et au Ghana, entre l’embouchure du Mono et celle de la Volta, d’aider à comprendre ce qu’ils représentent pour ceux-là même qui en font usage. Bien entendu une telle compréhension ne vaut nullement approbation des pratiques correspondantes, mal adaptées aux conditions de vie et à la problématique de notre époque. Elle n’en est pas moins utile pour élargir notre connaissance de l’humanité et, en réaction à d’autres manières que les nôtres d’appréhender le monde, nous amène à réviser certaines conceptions philosophiques ou théologiques que nous imaginons aller de soi du seul fait que nous y avons baigné dès l’enfance.
I – Catégories d’objets à prendre en considération
Pour y voir clair dans la multitude des objets de culte observables à l’ancienne Côte des Esclaves (du Ghana oriental jusqu’au Nigéria), il me paraît nécessaire d’y distinguer trois grandes catégories.
- a) Des objets purement représentatifs, nous renvoyant à différentes sortes de créatures ou d’entités invisibles :
– personnages imaginaires du monde prénatal,
– représentants des exigences du projet d’existence ayant été élaboré au sein du monde prénatal, assimilés à des émissaires spirituels (gbetsi) de ce monde,
– petits jumeaux de brousse invisibles (gbetôagè),
– jumeaux humains absents ou morts,
– esprits de mauvais morts,
– certains ancêtres, notamment l’ancêtre tutélaire (amedzôdzô) ayant communiqué à un sujet son type d’énergie spirituelle et l’ayant accompagné prendre naissance.
1. b) Des objets de culte appelés vodu (ou trô) se présentant sous forme de simple lieu naturel délimité ou d’objet naturel, mais aussi bien d’objet résiduel ou d’objet savamment composé, rituellement transformé en symbole efficient d’une invisible puissance d’action intelligente et souveraine, assimilable à une divinité.
Il arrive par exemple qu’un individu soit soudain confronté à une singularité naturelle ou à un objet bizarre, fascinant, impressionnant fortement son imagination : vieille souche, rocher, statuette ou bijou préhistorique exhumé de terre, etc. Éclairé à ce sujet en rêve ou par les propos d’un devin, il apprend qu’une puissance vodu se signale ainsi à son attention et demande à recevoir un culte au lieu en question ou sur l’objet transformé en autel. Il ne lui reste qu’à aménager le lieu ou à mettre en valeur l’objet élu conformément aux directives qui lui sont communiquées.
Parfois l’objet transformé en vodu est une ancienne possession ou l’un des attributs d’une personne défunte. Il s’agit là d’une sorte de relique susceptible de donner accès à la puissance dont jouissait son possesseur. Il peut s’agit, en particulier, du reposoir d’une âme errante ayant été recueillie par un ancêtre. Cette âme se comporte alors en acolyte du vodu.
Dans les deux cas précédents les objets sacralisés tiennent lieu de symboles ou d’autels de vodu uniques, spécifiques d’une famille, d’un lignage, d’un clan ou d’une tribu.
Lorsque le vodu est susceptible d’être partagé entre plusieurs groupes de culte différents, autrement dit dans le cas où il recrute des adeptes en dehors des cercles familiaux, lignagers, claniques ou tribaux, lorsqu’il les recrute en particulier sur la base d’inclinations caractérielles ou d’aptitudes professionnelles, ou encore de leur affectation par une maladie ou tel ou tel genre de malheur, alors l’objet de culte, destiné à être répliqué en plusieurs exemplaires est un objet que l’on fabrique. Il s’agit essentiellement d’une composition savante d’ingrédients en sympathie avec les caractéristiques spirituelles de la puissance.
- c) Des objets appelés bo, ou assimilés en tant qu’instruments rituels à des bo, permettant d’exercer un charme magique par enchantement, subjugation, asservissement ou ligature symbolique de certains esprits (esprits de vivants, esprits de la nature ou esprits de mauvais morts). Ce sont des objets transportables, de taille réduite, pouvant être possédés en grand nombre par un même individu. Ils sont pour la plupart noircis, enduits de sang, et portent souvent collées sur eux des plumes de volailles leur ayant été sacrifiées.
De tels objets nous renvoient à des sortes d’armatures psychiques désincarnées ou à des mobilisations psychiques errantes devenues sans objet après la mort des individus en ayant été les auteurs. Ils sont utilisés pour écraser, blesser, intimider, asservir ou amadouer des corps spirituels. Les puissances, très spécialisées, auxquelles ils donnent accès ne sont pas intelligentes. Elles réagissent automatiquement, à la manière d’animaux dressés, aux ordres de ceux qui en disposent.
Ils peuvent servir à :
– pratiquer une divination élémentaire par enchantement du propre esprit du devin et renforcement de ses capacités d’intuition,
– provoquer une chute de pluie,
– se protéger des sorciers,
– écarter divers vecteurs spirituels de maladies ou d’événements douloureux,
– s’attirer la sympathie d’autrui,
– embobiner ou subjuguer ses rivaux, son patron, une femme convoitée, etc.,
– paralyser ou agresser ses ennemis, leur attirer des accidents, les rendre fous ou malades, à la limite les faire périr.
Leur efficacité dépend théoriquement aussi d’ingrédients dont quelques-uns sont semblables à ceux utilisés pour composer des vodu, mais dont plusieurs autres évoquent assez précisément les résultats escomptés.
Cependant les distinctions précédentes se compliquent du fait que :
– certains vodu peuvent être identifiés par des statuettes anthropomorphes tandis qu’à l’inverse des figurations d’ancêtres tutélaires peuvent être complétées par des restes d’objets magiques ayant été utilisés par eux,
– les vodu s’entourent souvent, à titre de soldats, policiers et commissionnaires, de puissances magiques de la catégorie des bo ainsi que d’esprits errants désincarnés,
– des bo ou des collections de bo peuvent se transformer en vodu une fois associés à l’âme défunte de la personne les ayant acquis ou dès lors que l’on se propose de vénérer en eux le principe de constitution de l’énergie spirituelle mobilisée dont ils permettent de tirer profit.
II – Composition et esthétique de ces objets
Les statuettes représentatives de personnes humaines (de jumeaux par exemple), de personnages imaginaires du monde prénatal (notamment du conjoint idéal appelé dzôgbemesrô ou ñôlimesrô) ou encore de vodu sous la forme qui leur est attribuée par l’imagination populaire, sont certes confectionnées avec plus ou moins d’habileté et un certain souci de perfection artistique.
Les objets qui, chez certains groupes voisins du Mono, représentent un ancêtre protecteur (notamment l’ancêtre tutélaire) se résument en des sortes de piquets à tête humaine, dépourvus de bras ou aux bras confondus avec le buste. Néanmoins ils sont fabriqués eux aussi avec plus ou moins de soin, pour plaire aux regards des passants ou des visiteurs.
Ceux qui représentent des esprits (appelés luvhô, d’un mot désignant également une ombre portée ou une silhouette) consistent en de grossières ébauches de silhouettes humaines ne comportant systématiquement aucun détail.
Les objets représentatifs d’émissaires du monde prénatal ou de substituts du sujet recherché par de tels émissaires sont le plus souvent confectionnés en argile fraîche, non cuite, matériau caractéristique du sein de la terre. De facture grossière, ils sont destinés à être abandonnés à l’issue d’un rite de détournement du mal.
Quant aux lieux ou aux objets naturels sacralisés, ils n’ont pas été choisis pour leur beauté mais en raison du sentiment d’étrangeté, de l’émotion ou de l’inquiétude qu’ils suscitent naturellement ou du fait des événements qui s’y sont déroulés ou auxquels ils ont été mêlés.
Ne posent problème, d’un point de vue esthétique, que les objets de culte artificiels de la catégorie des bo ou des vodu se laissant pertinemment désigner, me semble-t-il, par le terme de fétiche.
En effet de tels objets sont essentiellement constitués d’une mixture d’ingrédients qui ne se donnent pas à voir. Nous n’en apercevons jamais que l’emballage ou les accessoires qui leur sont adjoints afin de pouvoir les localiser et les identifier.
Ces ingrédients sont essentiellement végétaux. Il s’agit surtout de feuilles, mais parfois aussi de racines, d’écorces, de fruits ou de graines, etc. Ils ne sont pas traités en représentants de plantes particulières mais en évocateurs des vertus attachées aux espèces d’où ils proviennent.
Y figurent souvent aussi des restes d’animaux : petits animaux entiers desséchés, morceaux de peau ou griffes d’animaux féroces, têtes de serpents, coquilles d’escargots, morceaux de termitière ou de nid de fourmis arboricoles, plumes d’oiseaux singuliers, moustaches ou poils de quadrupèdes, notamment de l’écureuil fouisseur de savane, etc. On les juge imprégnés du caractère et du type de force de l’espèce animale correspondante. Ils ne sont jamais utilisés pour commander un travail à l’esprit désincarné de la créature dont ils faisaient partie du corps.
Peuvent en outre y figurer des cadavres crus d’animaux de petite taille, égorgés ou enterrés vivants, dont on pense que l’esprit désincarné sera capable d’exécuter dans l’invisible, au profit de la puissance à laquelle ils seront attachés, des fonctions d’information, de communication ou de transfert d’énergie.
Y figurent éventuellement aussi des éléments minéraux : pierres singulières, particules de mica, concrétions blanches exhumées du sol par les cultivateurs, eaux de certains fleuves, etc. Ils sont traités en produits d’un certain souffle réalisateur ou en restes d’un processus physique ayant été dirigé ou influencé lui aussi par des agents spirituels.
Cependant dans la composition des bo entrent de surcroît des éléments caractéristiques d’une orientation des forces spirituelles sollicitées vers certains types d’événements. Nous y trouvons notamment des restes d’objets ou de substances ayant subi l’influence de certains êtres ou de certaines activités (morceaux de vêtements portés par une évocatrice des défunts, poussière ou détritus du marché, etc.) ou ayant été fabriqués et de préférence utilisés dans une intention précise (cadenas, serrures, hameçons, fusil miniature forgé à partir d’un morceau de vrai fusil ayant explosé, morceau de corde ayant servi à attacher les bagages sur la galerie d’un minibus). Quand ils n’ont pas subi l’influence d’une créature vivante, ils peuvent avoir subi celle d’une divinité (morceau de rideau de porte de sanctuaire) ou celle d’une âme errante ou d’un esprit de la nature ayant résidé à leur emplacement ou à proximité immédiate. Ceux qui ne paraissent marqués par personne n’en évoquent pas moins un certain genre d’action ou d’accident (racines barrant un chemin ou, au contraire, longeant un chemin, herbes ayant poussé les entre les rails du chemin de fer ou à l’emplacement d’une tombe de mauvais mort).
Y figurent parfois aussi des restes humains (ossements, cheveux, morceaux de peau…). De tels restes ne servent nullement à entrer en rapport avec l’esprit du mort correspondant. Ils ne nous renvoient qu’au type de malheur ou de bonheur éprouvé par lui ou au genre de puissance dont il disposait en raison de ses connaissances ou de son autorité.
Les ingrédients d’un bo sont le plus souvent enfermés dans un sac, dans une poterie ou dans tout autre récipient (calebasse, bouteille…). Cependant il leur arrive d’être insérés dans le corps d’une statuette ou de lui être attachés au cou ou aux flancs une fois convenablement enveloppés. Une telle statuette représente soit le type de personne visée, soit le type de force ou d’agent spirituel que l’on cherche à mettre en œuvre, soit encore l’effet recherché : par exemple la capture d’une personne ou son asservissement à une autre.
Les ingrédients d’un vodu peuvent pareillement être enfermés dans un récipient, alors déposé sur une estrade, une étagère ou un piquet fourchu. Cependant ils sont le plus souvent enterrés sous un objet figuratif en bois, en terre pétrie ou en ciment ou sous un vulgaire monticule portant à son sommet ou sur ses flancs des décorations caractéristiques. De telles représentations et décorations sont évidemment plus ou moins soignées, plus ou moins belles ou impressionnantes, mais ne sont jamais considérées comme essentielles. Elles ne sont comparables qu’à celles d’une boite attirant l’attention des consommateurs sur la nature et les propriétés du médicament qu’elle contient.
De surcroît on trouve généralement associés à un vodu, déposés sur lui, accrochés à lui, incrustés dans ses flancs ou abandonnés au sol contre lui, divers objets hétéroclites :
– accessoires rituels (couteaux, clochettes, cannes, verres, écuelles…),
– éléments décoratifs en rapport avec le caractère et les capacités d’action de la puissance (collier de coquilles d’escargot, lunettes de soleil symboles de fer forgé…),
– restes d’offrandes sacrificielles,
– restes de produits ayant été employés ou fabriqués lors de précédentes cérémonies (au cas où ils pourraient être réutilisés, on a évité de les jeter),
– objets abandonnés à titre d’ex-voto par des malades guéris (chapeau, sandalettes, sac de voyage…).
Ce n’est qu’à ce niveau : celui de leur emballage, de leur identification et des accessoires matériels qui leur sont adjoints, que nous pouvons parler d’une esthétique particulière des fétiches souvent présentée comme une «esthétique du désordre».
Enfin, dans un même sanctuaire, plusieurs vodu, éventuellement complétés par des bo, sont généralement installés ou entreposés sans souci apparent de cohérence et selon une hiérarchie singulière, chacun d’eux ayant été adopté par le sujet comme solution à une épreuve plus ou moins sévère que son destin le prédisposait à affronter.
L’esthétique d’un tel sanctuaire obéit à une logique analogue à celle qui préside à la disposition des objets dans l’atelier d’un inventeur ou le bureau d’un intellectuel. Cette disposition, en effet, y est généralement le fruit d’une accumulation d’éléments en rapport plus ou moins direct avec une recherche ou une activité déterminée. Qu’une personne bien intentionnée (épouse, femme de ménage) s’avise d’y mettre de l’ordre et l’occupant habituel ne s’y retrouve plus: le lieu perd pour lui de son charme et il ne s’y sent plus bien.
À une composition épurée, bien ordonnée, évocatrice d’une idée à contempler, s’oppose ici un surprenant ou inquiétant désordre caractérisant l’histoire d’une personne ou d’une série de problèmes auxquels elle a été confrontée. Ce qui nous est montré ne nous oriente vers aucune généralité mais nous confronte à une singularité, à une certaine manière d’être concerné par le monde et de lui faire face. Rien n’est fait pour nous distraire de l’incohérence et de l’inhumanité du monde par l’évocation apaisante de quelque forme pure. Nous sommes au contraire interpellés, émus ou choqués par un arrangement d’ouvertures vers l’au-delà ne convenant qu’exceptionnellement à notre personnalité.
III – Les puissances auxquelles ces objets donnent accès
Il est clair que tout objet sacré élu spontanément comme autel par une puissance invisible sert avant tout de point d’accès à cette puissance.
Il est également clair que toute relique sacralisée a pour fonction majeure d’évoquer l’esprit ou la puissance qui y était attachée.
Un problème de statut et de fonction ne se pose que pour les objets de culte composés de main d’homme méritant d’être appelés fétiches. Renvoient-ils eux aussi à quelque chose d’autre ou ne renvoient-ils qu’à eux-mêmes ? Sont-ils immédiatement efficaces ou ne servent-ils que de moyen d’accès à des puissances autonomes ?
Les ingrédients rassemblés pour constituer de tels objets sont choisis pour autant qu’ils conservent, dans leur structure intime, l’empreinte des forces créatrices ou réalisatrices, ayant contribué à donner forme à l’ensemble dont ils proviennent. On les juge capables d’intensifier autour d’eux, comme par résonance, des forces d’inclination subtiles se trouvant en harmonie avec eux.
Tout fétiche possède de la sorte une certaine efficience par lui-même. Il crée autour de lui une certaine ambiance, à laquelle d’ailleurs les rites contribuent. Il permet d’aménager une atmosphère spirituelle favorable ou défavorable à certains événements objectifs ou purement psychiques.
Néanmoins il est fondamentalement conçu pour donner accès à une puissance spirituelle ou surnaturelle préexistant quelque part indépendamment de lui.
Entrer en relation avec lui permet au sujet de se pénétrer d’un certain état d’esprit, d’un certain style d’action ou d’expression le rendant sympathique à une telle puissance et lui permettant de s’en approcher.
Il n’en est pas moins indispensable d’obtenir l’agrément de la puissance visée pour établir un lien réel avec elle. Le sujet devra accepter son invitation pressante à lui rendre un culte ou obtenir d’elle, par l’intermédiaire d’un devin, l’assurance d’une protection dont elle n’a pas pris l’initiative. Généralement à l’occasion d’un rite de confection et de consécration de l’objet par une personne ayant déjà contact avec elle, une parole plus ou moins mystérieuse, qui en constitue l’intitulé magique, sera révélée au récipiendaire, à l’énoncé de laquelle elle acceptera de se mobiliser en sa faveur conformément à la demande qui lui sera exposée.
En aucun cas l’objet de culte magico-religieux n’est fabriqué techniquement par application d’un code symbolique nous renvoyant à un signifié. Nous ne pouvons parler de code symbolique qu’au niveau de l’identification de la puissance par un emballage, un enrobage ou une adjonction d’accessoires. La puissance ne réagit qu’à l’énoncé rigoureux de son nom. Cependant un tel nom est arbitraire, de pure convention entre elle et le sujet. Nous constatons qu’il peut varier d’un lieu à un autre et au cours du temps.
Effectivement nul ne peut inventer de fétiche à sa convenance. Ou bien il faut aller acquérir celui-ci ou celui-là après de quelqu’un qui en possède déjà un exemplaire, ou bien il faut en recevoir la révélation par un de ses ancêtres, le plus souvent son ancêtre tutélaire (amedzôtô), ou par un génie de brousse (aziza ou gbetôagè).
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les fétiches ne sont pas identifiables à l’aide des éléments, néanmoins essentiels, dont ils se composent. En effet de nombreux fétiches d’une même classe, bien différents les uns des autres, se trouvent fabriqués en puisant dans une collection restreinte de plantes réputées pour leur puissance. Par ailleurs des fétiches de même nom, remplissant des fonctions identiques, ne comprennent parfois aucune plante commune. Enfin il est toujours possible de suppléer au manque de force d’un fétiche en y incorporant une ou plusieurs nouvelles plantes choisies après avoir recueilli, à ce sujet, l’avis d’experts parfois très éloignés.
En détruisant ce qui matérialise un fétiche on ne supprime nullement la puissance qu’il permet d’exercer. Rien n’interdit, après profanation ou accident, de reconstituer au même endroit le même fétiche. Par ailleurs, sans supprimer l’objet, il est jugé possible de le neutraliser, lui et tous les exemplaires analogues qui en ont été diffusés, par suppression de la puissance à laquelle il se rapporte ou annulation de tout droit à l’utiliser. Des familles entières de bo ou de vodu dont l’usage s’est révélé nuisible à une communauté peuvent de la sorte être anéanties. Dans la partie sud-ouest du Togo il suffit pour cela d’apporter l’un des objets qui les matérialisent ou leur sont intimement liés dans la forêt sacrée de la divinité royale Nyigblin, à Bê, ou chez l’un des prêtres ordinaires du même Nyigblin, à Togoville, où le responsable du culte, après avoir exécuté les rites nécessaires à son invalidation, l’enterre sur place sous la bonne garde de son dieu.
L’expression de «dieux-objets», employée par Marc Augé pour désigner les fétiches, me paraît donc regrettable.
Néanmoins les puissances auxquelles ils renvoient n’ont pas le statut de divinités éternelles (1) Elles constituent un ensemble en évolution permanente, parallèle à celle de la société, composé d’émanations ou de créatures de Dieu, mais surtout de fruits éloignés de la désincarnation des âmes humaines, et il ne viendrait à l’idée de personne de confondre l’une d’elles avec Dieu lui-même (Mawu, l’indépassable).
Celles qui se révèlent incapables de satisfaire les vivants sont délaissées par eux et disparaissent de la scène.
De nouvelles ne s’imposent jamais à eux, soit en les perturbant, soit en leur étant révélées par leurs génies ou leurs ancêtres, que dans la mesure où elles peuvent satisfaire leurs besoins.
De même que le peuple des ancêtres se renouvelle à chaque génération, les ancêtres proches chassant devant eux les plus éloignés jusqu’à les repousser derrière l’horizon de la mémoire, le peuple des puissances magico-religieuses utilisables ne cesse lui aussi de se renouveler. Ce qui peut induire à ce sujet en erreur est que certaines divinités interlignagères se laissent classer dans des catégories qui perdurent aussi longtemps et à aussi longue distance que le système de pensée correspondant. Tel est le cas pour certains grands vodu nommés d’après le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent. C’est ainsi que les vodu s’affirmant sous les apparences de la foudre ou du serpent forment souvent des familles de sept vodu (autant que de catégories d’énergie spirituelle) dont les noms varient d’un lieu à un autre. Ce n’est qu’au terme d’un effort d’abstraction que l’on en arrive à hypostasier derrière un groupe de divinités présentant des caractéristiques voisines une divinité singulière permanente.
IV – Les conceptions qui en justifient l’usage
On ne saurait bien comprendre les objets de culte de la région considérée en les isolant du système religieux des populations qui les vénèrent.
- La croyance en un principe divin d’opposition au mal
Ces populations valorisent la vie sur terre. Elles souhaitent trouver satisfaction dans l’existence. Cependant les satisfactions qu’elles recherchent ne sont pas purement matérielles. Elles proviennent surtout de l’estime d’autrui, donc d’une étroite conformité à la morale collective, et du sentiment d’avoir joué correctement son rôle en réalisant au mieux, compte tenu de ses aptitudes, un ensemble d’idéaux préconçus. La perspective de joies posthumes dans une sorte de paradis n’est pas de nature à leur faire accepter, à titre d’épreuve méritoire, les souffrances et les déceptions de la vie quotidienne. De leur point de vue la manifestation concrète surpasse ce qui demeure en puissance. L’être est voué à l’existence et ne témoigne de ses insondables vertus qu’à travers celle-ci. Son premier devoir est de réussir ce qu’il entreprend pour s’attirer le respect. Une divinité qui n’aiderait personne à accomplir sa destinée serait jugée indigne d’être prise en considération. À défaut de révéler concrètement ses capacités, elle n’existerait que virtuellement, en marge de ce qui compte, en marge du réel. Seul un Dieu concerné par le bien-être de ses créatures mérite qu’on entre en relation avec lui, qu’on l’invite à venir siéger au poste de direction de soi-même et qu’on s’y efface devant lui.
Ce n’est pas à de suaves entités que l’homme est immédiatement confronté, à une cohorte d’anges, à de doux protecteurs célestes vers lesquels se tourner ou dans les bras desquels prendre refuge, mais à une multitude de fléaux, à l’échec, à la maladie, à la méchanceté, à l’injustice, bref à un empire du mal dont nul se saurait sans déchoir se résigner à la victoire. Une voix secrète lui susurre que cette victoire n’est pas acquise, qu’elle ne serait pas normale, et le pousse à la révolte. Pour lui permettre de s’opposer à la destruction et au chaos, comme de résister à toute tentation de capituler devant les puissances ténébreuses ou maléfiques, ne saurait donc manquer de subsister quelque part, à sa disposition, des puissances d’ordre et de clarté lui conférant la capacité de faire de son existence non seulement l’expression cohérente de quelque chose (celle du personnage dont il joue le rôle sur la scène du monde), mais encore l’expression de son être même (celle de ses talents d’acteur). À de telles puissances dissimulées, devant nécessairement lui être révélées, il accepte volontiers de rendre un culte et assimile leur source transcendante à l’Être divin.
En définitive le Dieu de la portion d’Afrique considérée n’est autre, en l’homme, que le principe universel de redressement qui s’horrifie de l’insinuation permanente du mal dans le monde. Ce Dieu ne s’affirme que secondairement, en réaction aux tentatives de domination d’un principe contraire au bon ordre des productions de la nature. Ayant besoin d’un tel principe pour s’imposer, il le fait exister tout premièrement par un acte d’abandon, hors de sa sphère de gouvernance, d’une impulsion fondamentale aux actes de méchanceté, de destruction, de corruption et de privation de vitalité. Il s’agit là d’une sorte de sacrifice primordial, par amputation délibérée d’une partie de son pouvoir, symbolisé par l’envol mythique de l’oiseau nocturne des sorciers hors de la calebasse maternelle du monde (2).
- b) L’homme jugé dépendant d’une multitude de puissances
Dès lors qu’il a consenti à la sorcellerie, Dieu est en état de faire apparaître l’homme et toutes les puissances qui, mises à sa disposition, lui permettront de coopérer librement au parachèvement de sa création.
Selon le système de pensée qui prévaut dans l’aire culturelle adja-évhé, toute âme humaine est d’abord introduite par Dieu dans un invisible monde, dominé par une Mère universelle appelée en évhé Bomenô ou Ñôlimenô, où elle s’élabore, en imagination, une existence de référence. Elle s’en échappe bientôt pour prendre vie sur terre, mais doit traverser tout d’abord une étendue analogue à celle de l’espace sauvage (de brousse et de forêt) qui sépare les terres du village de la frontière orientale du monde matérialisée par l’un des fleuves qui, dans la région, coulent du nord au sud. De son existence préalable au royaume de la grande Mère, appelé amedzôphe ou monde de l’origine, le sujet conserve une détermination fondamentale, appelée dzôgbe ou détermination originelle, dont le symbole naturel est le placenta. Tout ce qui le concerne sur terre, qui le heurte ou vers lequel il se dirige, n’est que l’une des réalisations possibles des potentialités qu’il a engrangées dans ce dzôgbe (3).
Nous devons donc prendre en considération:
– un monde de l’origine qui est celui de la conception des phénomènes,
– un monde terrestre qui est celui de la réalisation des potentialités élaborées dans ce tout premier monde,
– et un monde intermédiaire dont la traversée est analogue à une phase de gestation séparant la conception de la naissance, c’est-à-dire de l’apparition au grand jour.
Une fois sur terre, séparé du monde de l’origine, et donc de son dzôgbe (comme séparé du placenta après coupure du cordon ombilical), par ailleurs incapable de discerner ce qui se passe dans le monde intermédiaire, l’homme ne serait rien de plus qu’un vulgaire objet de la nature, incapable de maîtriser son existence, si ses ancêtres et un génie personnel qui lui est adjoint par Dieu lui-même ne lui permettaient d’entrer en rapport avec une multitude de puissances qui gouvernent dans le secret ce qui lui advient.
Parmi ces puissances, les unes, telles les vodu, lui permettent de cultiver à la source l’expression des invisibles ressources qu’il s’est choisies ou que l’univers tient pour lui en réserve. Ce faisant, elles amorcent à son intention, spontanément ou à sa demande, mais parfois aussi à la demande de ses ancêtres, l’envoi au monde de phénomènes normalement inattendus.
Les autres, notamment les bo, lui permettent d’éviter les accidents de parcours de tels phénomènes ou de se protéger de phénomènes indésirables qui se dirigent vers lui. Elles agissent à cet effet sur les divers facteurs spirituels qui interviennent dans leur phase de gestation.
Certes quelques populations, plus à l’est, tout aussi grandes utilisatrices d’objets magico-religieux analogues, ne se réfèrent pas explicitement à une existence préalable dans un monde de l’origine. Cependant elles n’en distinguent pas moins, semblablement, deux sortes de puissances immatérielles, actionnables ou sollicitables par les vivants : les unes ne sont capables que d’interventions ponctuelles, magiques, sur le cours des événements, et ne modifient en aucune manière le sens de l’existence, les autres interviennent plus profondément, à la racine même d’élaboration des événements, jusqu’à modifier ce que les événements représentent, et mettent donc en jeu non seulement des forces mais des symboles.
Bien qu’il soit totalement dépendant de telles puissances, l’être humain n’en a pas moins la liberté d’accepter ou de refuser les secours qu’elles lui proposent. Foncièrement incapable de modifier les volontés manifestées à son égard par Dieu et ses acolytes, il porte l’entière responsabilité de s’ouvrir ou de se fermer aux effusions spirituelles qui en émanent, de se prêter ou non aux transformations bénéfiques de son existence qu’ils daignent amorcer à son profit, enfin d’actionner ou de négliger les moyens occultes qu’ils lui indiquent pour réaliser au mieux son projet d’existence (4).
V – L’approbation divine du recours aux fétiches
Il convient d’insister sur le fait que, du point de vue traditionnel, le recours aux puissances accessibles par les fétiches ne s’oppose en rien au service de Dieu.
- a) Les fétiches aident le sujet à mieux s’accomplir
À défaut de pouvoir être secouru par des puissances mises à sa disposition pour lutter contre des entités foncièrement maléfiques ou contre des forces mobilisées contre lui par des esprits méchants, le sujet humain, privé de tout levier d’action sur le monde, ne serait qu’un être fictif, dénué de réalité. Seul celui qui se risque à recourir religieusement ou magiquement à de telles puissances qui le dominent ou dont il serait autrement le jouet se rend agréable à Dieu. En effet il contribue ainsi à parfaire une création destinée à rendre gloire à son auteur. De surcroît, à l’occasion des rapports sacrificiels qu’il lui faut établir avec elles, il ne cesse de s’enrichir en énergie spirituelle de diverses sortes symbolisées par les couleurs de l’arc-en-ciel, jusqu’à atteindre éventuellement la complétude spirituelle symbolisée par la lumière blanche.
Immanent dans le cœur de l’homme, Dieu (Mawu) l’invite, tant pour réaliser au mieux la destinée qu’il s’est choisie que surtout pour s’épanouir spirituellement, à demander, au moyen de fétiches, aide et protection à de bienveillantes puissances immatérielles.
Certains objecteront que mieux vaut ignorer de telles puissances et s’en remettre à Dieu seul pour traiter avec elles. À cela les meilleurs représentants de la tradition adja-évhé répondront qu’un acte de soumission à Dieu ne saurait aller de pair avec une méconnaissance totale de ses puissances auxiliaires, ni se résumer à une confortable passivité. De leur point de vue il convient de coopérer activement avec Dieu, tant pour répondre à ses avances que pour lui transmettre, ou transmettre à ses représentants, des demandes précises. Ils feront valoir que pour se libérer, notamment dans le rapport à Dieu, de liens encombrants à certaines entités invisibles, il ne convient pas de les ignorer mais d’en prendre connaissance jusqu’à éprouver, par expérience, les limites des relations entretenues avec elles. Ils ajouteront que les rapports qu’ils établissent avec des esprits ou des puissances surnaturelles leur ont été recommandés par cette précieuse émanation de Dieu qu’est leur génie personnel, systématiquement consulté par divination au moindre problème, et qu’en obéissant aux directives de ce dernier c’est finalement à Dieu qu’ils se soumettent.
Les puissances ainsi prises en considération ne sont nullement perçues par eux comme des obstacles devant Dieu mais, de même qu’on ne s’approche d’un roi qu’introduit auprès de lui par une hiérarchie de serviteurs et de dignitaires qui composent sa cour, ils estiment qu’on ne saurait accéder au souverain suprême du monde qu’après être entré en contact et en négociation avec les nobles âmes et les puissances divines qui l’entourent.
- b) Les fétiches n’ont aucune liaison particulière avec le mal
On reproche souvent aux fétiches, du moins à ceux de la catégorie des bo, de servir principalement à faire le mal.
Nul ne saurait nier qu’ils sont souvent utilisés par les hommes pour nuire à certains de leurs semblables. Ils représentent cependant des puissances qui ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Seul l’usage qui en est fait peut être jugé bon ou mauvais. Il en va de même pour toute puissance physique. Le feu qui peut servir à incendier la maison du voisin n’est pas condamnable pour autant : il permet aussi bien de se chauffer et de cuire des aliments. S’abstenir de recourir à des fétiches apparaît à un Africain aussi sot que de s’abstenir de tirer profit des énergies naturelles. De son point de vue nous nous rendons coupables de négligence si nous ne fournissons nous-mêmes aucun effort pour nous protéger de multiples nuisances spirituelles, mais surtout si nous méprisons les faveurs matérielles, et parallèlement les grâces, que les ancêtres et les divinités vodu sont disposés à nous accorder.
Il est vrai que, sous les effets cumulés de la colonisation, de la christianisation, de l’éducation occidentale, de la mondialisation des marchés et de l’accroissement de l’individualisme, la religion traditionnelle n’a cessé de péricliter et que n’en subsistent de plus en plus que les aspects mineurs les plus critiquables : ceux qui permettent à un individu de survivre dans une société décomposée de plus en plus cruelle en s’appuyant sur toutes sortes de moyens magiques d’attaque ou de défense. Il est vrai que des familles entières, voire des villages entiers, comme grisés collectivement par la jalousie et la haine, se livrent sans retenue à des pratiques maléfiques. Cependant de telles déviations n’autorisent pas à condamner sans discernement la religion dans le cadre de laquelle elles sont concevables, mais qui par ailleurs les réprouve.
Pour un Africain de la région, le bien consiste à réaliser au mieux, en pactisant avec des puissances spirituelles ou surnaturelles, conformément aux conseils de son génie, l’idéal d’existence qu’il a conçu, avant de venir au monde, dans le royaume de la grande Mère. Chacun est invité à cultiver à la perfection les productions de la portion de nature qu’il s’y est attribuée et tous les moyens utilisables à cette fin sont estimés bons pourvu qu’ils n’entravent pas, par malin plaisir, la réalisation de la destinée des autres.
Chacun a le droit de jouer des coudes et de bousculer autrui pour tracer sa voie. À autrui de trouver la force de lui résister pour tracer aussi sa propre voie. En définitive ce n’est pas le résultat qui importe mais essentiellement le déploiement des forces auxquelles, pour lutter, le sujet aura dû faire appel et dont son âme se sera à terme enrichie. En revanche nul n’a pas le droit de s’attaquer aux ressorts intimes d’autrui, à sa personne même. Il ne doit entrer en rivalité avec lui qu’au niveau de l’expression des idéaux d’existence. Si, au lieu de construire sa propre vie en répondant favorablement à l’incitation divine de contribuer au parachevement du monde, il s’avise d’utiliser les puissances dont il dispose pour anéantir les réalisations des autres ou rendre leurs réalisations impossibles en les dévitalisant, en les rendant malades, en semant la zizanie dans leurs familles, en faisant périr leurs enfants et leur bétail, en attirant les rongeurs sur leurs récoltes, etc., il se condamne à être rejeté par Dieu et par ses ancêtres, au point d’être transformé après sa mort en esprit serviteur du principe pervers ayant inspiré ses actions, principe qui n’est autre que celui de la sorcellerie.
Alors que la sorcellerie, caractérisée par une infection de l’individu par un esprit gagné à sa cause, reste fondamentalement mauvaise et n’a nul besoin de fétiche pour se propager et devenir opératoire, les fétiches représentent des puissances neutres grâce auxquelles on peut, à volonté, bien agir ou mal agir. Grâce à eux l’homme a le choix de servir Dieu et l’ordre cosmique ou, au contraire, de propager le mal en cédant au principe destructeur qui a pour repaire l’en-dehors chaotique du monde et par réaction auquel le monde se construit.
Tout compte fait, les fétiches d’Afrique noire, en dépit de leur liaison avec des pratiques archaïques, telles que le sacrifice sanglant et, avec des structures sociales difficilement compatibles avec les formes de vie modernes, demeurent dignes de considération. Leur étude, d’autant plus stimulante qu’elle défie constamment nos préjugés ethnocentriques, nous aide en effet à remettre en cause les idées que nous nous faisons de Dieu, du monde, de l’âme humaine, de notre place dans le monde et des forces qui gouvernent notre existence. Elle ne peut que contribuer à enrichir, de la sorte, nos conceptions métaphysiques et religieuses.
Notes
(1) A fortiori en va-t-il de même pour les puissances dont les autels ne sont pas assimilables à des fétiches. Chaque lignage a son protecteur particulier. L’extinction d’un lignage implique l’extinction de sa divinité tutélaire. Sauf alliance préalable, cette divinité ne proposera ses services à aucun autre lignage. Lorsqu’une branche familiale acquiert son autonomie, elle doit se découvrir, sur les indications de ses propres ancêtres, une nouvelle divinité à sa convenance.
(2) Se reporter, à ce sujet, à Bernard Maupoil: La géomancie à l’ancienne Côte des Esclaves, Paris, Institut d’ethnologie, (1943) 1988, aux pages 84 à 111, et à Pierre Verger : «Grandeur et décadence du culte de Iyami Osoronga, ma mère la sorcière, chez les Yorouba», Journal de la Société des Africanistes, 1965, aux pages 141 à 157.
(3) Au sortir du monde de l’origine l’homme n’existe qu’à l’état d’embryon triplement composé d’éléments prélevés dans le dépotoir des existences, d’un arrangement singulier de tels éléments lui constituant un idéal d’existence, enfin d’une énergie spirituelle singulière de réalisation des potentialités qu’il s’est ainsi attribuées.
(4) Selon une telle conception, il y a bien prédétermination du sort des âmes (mais non prédestination intégrale car seul le cours de leur existence terrestre est orienté par leurs choix prénataux), mais entière liberté pour elles d’entraver ou de favoriser, par leur comportement, ce que leur réservent des volontés divines dont elles ne sont en rien responsables. Ce n’est ni au contenu objectif de leur existence, ni à la grandeur des intentions de Dieu à leur égard (exprimées par le génie personnel qu’il délègue auprès de chacune d’elles), mais à leurs actes de rébellion ou à leur soumission aux directives des puissances sacrées se proposant de les prendre en charge, que se mesurent leurs mérites et leur degré d’épanouissement spirituel.
Bibliographie
On trouvera une bibliographie assez complète sur la question à la fin des articles réunis par Giovanna Parodi da Passano dans Évhé-Ouatchi. Un’estetica del disordine, Centro Studi Archeologia Africana, Milano, 2004.
Outre au contenu de cet ouvrage, on pourra se reporter principalement à:
– «Fétiches I. Objets enchantés, mots réalisés» et «Fétiches II. Puissances des objets, charme des mots», Systèmes de pensée en Afrique noire, numéros 8 et 12, Ivry sur Seine,1987 et 1993 (textes réunis par Albert de Surgy),
– SURGY, Albert de :
- a) Le système religieux des Évhé, L’Harmattan, Paris, 1988
- b) Nature et fonction des fétiches en Afrique noire. Le cas du Sud-Togo, L’Harmattan, Paris, 1994.
AFRIQUE PLURIELLE
Marc Augé
AFRIQUE PLURIELLE
(articolo pubblicato in “Archeologia Africana – Saggi Occasionali” 2010-2011 numero 16/17)
On ne peut parler d’un continent en utilisant l’article défini qu’en s’exposant à énoncer des généralités vides ou des évidences discutables. S’agissant de l’Afrique, cet usage de l’article défini a été encouragé par une vision coloniale intellectuellement dominatrice. Ainsi les objets que repéraient et parfois collectaient les voyageurs, les administrateurs, les ethnologues et les esthètes ont-ils pu être considérés comme l’expression indifférenciée d’une «culture» africaine qui se laissait décomposer éventuellement en «sous-cultures» «ethniques». L’existence de ces objets, à elle seule, a pu encourager une vision éventuellement admirative de l’Afrique («Civilisés jusqu’à la moelle des os», pour reprendre la formule de Frobenius), mais d’une Afrique pensée comme plus ou moins homogène et produisant de l’art comme la nature produit des fruits.
Cette vision a bien évolué : la diversité politique, historique et culturelle du continent africain a été progressivement mise en évidence. Des petits groupes nomades aux grands empires, toutes les expériences politiques ont été présentes sur le continent africain. L’ancienneté des contacts avec l’extérieur est un fait établi. Ainsi l’influence ancienne de l’islam a-t-elle été repérée dans des sociétés que l’ethnologie avait été d’abord considérée comme préservée de tout contact extérieur, par exemple la société dogon. Dans le domaine de la culture matérielle et de l’art, l’existence de sculpteurs distincts les uns des autres, identifiés et appréciés, avec chacun sa manière propre, est aujourd’hui reconnue.
L’existence des musées d’ethnographie a toutefois souvent pour effet de nous habituer à une vision à la fois globale et réductrice du continent africain en exposant des objet sans toujours parvenir à faire le départ entre leur intérêt documentaire (par exemple leur fonction ou leur signification religieuse) et leur qualité artistique (elle-même appréhendée à partir de critères aussi hétéroclites que la rareté, l’ancienneté, la matière ou la forme). Je mets au défi le visiteur du Quai Branly de pouvoir appréhender quelque chose de la diversité africaine à partir de ce qui est expose dans ses vitrines, pourtant très riches.
Enfin il ne faut pas confondre pluralité et diversité. Quand je parle d’Afrique plurielle, je ne veux pas dire qu’il n’y a pas des références symboliques globales qui traversent ou transcendent la diversité empirique des systèmes. Tout au contraire. J’ai travaillé d’abord en Côte d’Ivoire dans la région lagunaire. Tout autour de la lagune Ébrié vivaient des petits groupes de quelques milliers d’habitants qui avaient chacun leur langue, leur mode de filiation, leur manière d’organiser les classes d’âge, etc… Il n’empêche que les populations lagunaires dans leur ensemble partageaient des références historiques et culturelles qui les distinguaient globalement d’autres groupes de Côte d’Ivoire. Nous sommes plutôt dans une progression de type «segmentaire», pour reprendre une expression utilisée par l’anthropologie britannique. Ainsi, bien que les «prophètes-guérisseurs» ivoiriens apparus au début du siècle prétendissent œuvrer pour l’Afrique dans son ensemble, leur clientèle, pour diverse qu’elle fut, comportait très majoritairement des ressortissants de la zone lagunaire. Mais en changeant d’échelle, on pourra constater que le phénomène du prophétisme comme réaction à la colonisation, sous des formes variables, s’est manifeste à peu près à la même époque dans des régions aussi éloignées que la Côte d’Ivoire, le Congo ou l’Afrique du Sud.
Parlant d’Afrique plurielle, je ferai donc moins allusion à la diversité incontestable de ses régimes politiques ou de ses systèmes de filiation, qu’à la pluralité interne à chacun d’eux. Ce que partagent toutes les sociétés africaines, c’est l’art de décliner la pluralité sous toutes ses formes. Cet art est inséparable d’une certaine plasticité et d’un sens de l’adaptation qui leur donne une dimension exemplairement historique.
Pluralité des dieux
Les dieux africains sont pluriels en plusieurs sens. Tout d’abord ils composent des panthéons très riches. J’avais été frappé en arrivant au Togo et déjà en consultant les ouvrages des principaux ethnologues de la région du golfe de Bénin (de Maupoil à Verger en passant par Herskovitz) par la ressemblance des divers panthéons (eux-mêmes très proches les uns des autres) avec le panthéon grec, mieux vaudrait dire d’ailleurs : avec les panthéons grecs car dans la Grèce classique comme en Afrique il y avait à la fois une grande diversité régionale des panthéons et une non moins grande proximité entre les diverses figures divines et les systèmes de relation qui, en chaque occurrence, les reliaient les unes aux autres. Chaque figure divine exprime une dimension naturelle comme le ciel, le tonnerre, la mer ou le soleil, elle exerce à ce titre des fonctions particuliers (en ce sens les dieux sont plutôt des puissances que des personnes, pour reprendre la formule que Vernant applique aux dieux grecs) mais elle est reliée aux autres par des liens de parenté ou d’alliance qui peuvent varier selon les endroits ou selon les informateurs mais qui sont toujours reconnus et réaffirmés. Les figures peuvent en outre s’agglutiner le unes aux autres, additionnant par exemple un principe mâle et une principe femelle ; sur certaines figures les deux dimensions se confondent et l’ambiguïté se substitue à l’ambivalence. Cela n’empêche pas chaque dieu d’avoir un nom propre et d’être à ce titre l’objet de récits mythiques qui content sa naissance ou telle péripétie de son existence.
Matériellement les dieux portant le même nom sont légion. Leur image est façonnée par un artiste et souvent les éléments des trois règnes qui entrent dans leur composition sont glissés à l’intérieur de la statue d’argile ou de bois qui implique leur présence réelle. L’autel religieux qui s’organise autour de cette présence est réputé avoir plus ou moins de force en fonction du prêtre qui en a la charge, de l’assiduité des desservants et aussi, comme les saints catholiques assignés à tel ou tel lieu particulier, en fonction de ses qualités spécifiques propres.
Pluralité de la personne
La littérature sur la notion de personne en Afrique Noire est particulièrement riche. Cette richesse ne tient pas seulement à la curiosité des ethnologues, mais au fait que pratiquement toutes les cultures africaines ont accordé une importance systématique aux influences qui peuvent s’exercer d’individu à individu et élaboré des représentations de l’appareil psychique qui partagent au moins deux caractères : le psychisme n’y est pas coupé de la matérialité du corps et il est composé de plusieurs éléments ou instances, dirait-on en langage freudien. C’est ainsi que dans les groupes d’origine akan deux éléments sont plus particulièrement mis en valeur, l’un plus proche de la notion d’identité, l’autre de celle de relation ou d’influence. Ce second élément est censé défendre le premier d’éventuelles attaques ou s’attaquer lui-même à ce premier élément dans la personne d’un autre. Il est désigné dans plusieurs groupes par un terme qui s’applique aussi au sang, cependant que le premier est désigné par le terme qui signifie l’ombre portée de l’individu. Dans les diverses anthropologies locales, d’autres éléments entrent en jeu, mais l’expression d’un principe identitaire et d’un principe relationnel est constante, de même que la double équivalence entre corps et esprit d’une part, entre l’instance et son pouvoir d’autre part.
Cette pluralité s’exprime dans les conceptions de l’hérédité qui varient évidemment d’un groupe à l’autre, mais qui sont toujours extrêmement détaillées et raffinées, reposant sur des faits d’observation comme la ressemblance des traits ou du caractère. Il faut d’ailleurs remarquer que, de ce point de vue, toutes les dimensions sociales sont prises en considération et que le principe d’unifiliation est donc, dans une certaine mesure, toujours relativisé. Dans les groupes matrilinéaires dans lesquels j’ai travaillé, un rôle important était dévolu au père et à la parenté paternelle entendue comme le matrilignage du père, mais le nom et certains pouvoirs se transmettaient dans la ligne agnatique (père, père du père, etc…). Cette complexité trouve une expression spatiale dans les règles de résidence propres aux sociétés dites «dysharmoniques» dans lesquelles il n’y a pas symétrie entre la règle de filiation et la règle de résidence, par exemple dans le cas où coexistent une filiation matrilinéaire et une résidence patrilocale.
Les généalogies royales ouvrent un champ plus large à la mémoire généalogique et nous pouvons suivre sur l’exemple des dynasties des royaumes Fon du Bénin, patrilinéaires, le retour du djoto, composante principale de la personne qui se réincarne dans la ligne agnatique toutes les deux ou trois générations. Ce principe du retour partiel relativise évidemment l’opposition entre passé et présent ou mort et vie, aussi bien dans les sociétés lagunaires de Côte d’Ivoire que dans les sociétés du sud Togo où l’on cherche sur le corps de chaque nouveau-né la trace du principe ancestral qui s’y est réinscrit.
Pluralité de l’immanence
L’expression «pluralité de l’immanence» peut surprendre. La vision immanente propre à l’Afrique polythéiste semble plutôt procéder en effet d’une conception unitaire du réel pour laquelle le corps ne s’oppose pas plus à l’esprit que l’événement à la structure, l’un au multiple, l’intention à l’action ou la vie à la mort. Mais justement c’est la pluralité interne des personnalités humaines et divines qui permet de jouer avec le principe de contradiction et de passer sans rupture du différent au semblable ou de l’autre au même et inversement. Je prendrai deux exemples pour illustrer cette affirmation.
Le premier exemple a trait au statut de l’événement. Dans toutes les sociétés du monde, l’événement fait problème. Le paradoxe qui s’y attache c’est qu’il nécessite un «traitement» rituel aussi bien lorsqu’il revient régulièrement (comme les saisons) que lorsqu’il surgit à l’improviste, comme une maladie ou une épidémie.
Dans le premier cas, on semble vouloir s’assurer que l’événement surviendra bien au moment prévu (le caractère cyclique du calendrier agricole n’empêche pas, au contraire, le sens des échéances). Dans le second cas, il s’agit d’interpréter le malheur inattendu pour réduire sa part apparente de contingence et, en quelque sorte, le rabattre sur la structure. Le fait que dans les sociétés africaines on y réussisse au moyen de ce que l’anthropologie médicale a appelé «étiologie sociale» me paraît exemplaire de ce que je me suis risqué à nommer pluralité de l’immanence. Dans un groupe matrilinéaire, par exemple, pour expliquer la mort d’un individu on mettra d’abord en cause un représentant de son matrilignage, mais si pour une raison ou pour une autre l’accusation n’aboutit pas, elle pourra se retourner contre son père, dont on mettra en cause le pouvoir de malédiction, ou contre n’importe quel autre membre de son entourage, les «sorciers» étant supposés pouvoir, comme dans un film d’Hitchcock, échanger leurs crimes, ou encore contre le mort lui-même, supposé s’en être pris à plus fort que lui. Dans un group patrilinéaire, l’ordre des hypothèses sera différent, mais toute la gamme des possibilités pourra aussi éventuellement être testée. Toujours l’affrontement des parties en présence passe par une épreuve de force et un art rhétorique dont la syntaxe est une extrapolation de la pluralité de la personne.
Lorsque la gravité de l’événement est telle qu’il semble mettre en cause plus qu’une responsabilité individuelle (mort d’un roi, sécheresse, épidémie…), l’enquête ne suffit pas : une négociation avec les puissances supérieures s’impose et elle prend le plus souvent la forme d’une ritualisation « dos au mur » qui fait intervenir une pluralité d’acteurs, au besoin en inversant leurs rôles respectifs comme pour souligner dans une brève parenthèse l’arbitraire de l’ordre habituel. Il existe une littérature très riche sur les rites d’inversion en Afrique Noire. Ceux-ci sont plus particulièrement remarquables par deux aspects : ils mobilisent toute la société et comportent des éléments narratifs virtuellement subversifs qui expriment le côte «limite» des situations pour le traitement desquelles on y a recours.
Dans le groupe Mina du Togo, c’était un collège de femmes sélectionnées par un vodun à l’occasion d’une crise de possession qui était en charge du traitement des épidémies de variole : elles présentaient au vodun de la variole, Sakpata, toutes les nourritures qui lui étaient interdites. Ces femmes dites femmes d’Avlekete étaient en quelque sorte des spécialistes de l’inversion puisque elles mimaient la masculinité, quotidiennement ou à l’occasion de cérémonies particulières, notamment au moment des changements de saisons, sous les formes les plus crues (maniant de grands phallus de bois) et les plus cruellement humoristiques (caricaturant très efficacement les comportements des hommes, leur suffisance et leur machisme). Avlekete est dans la mythologie identifiée à l’écume de la vague et apparentée à d’autres vodun. C’est donc bien l’ensemble des rapports en jeu dans la vie sociales (entre genres, entre hommes et dieux, entre société et nature) qui était mis en scène à l’occasion de l’épidémie de variole.
La parole joue un rôle éminent au cours de ces rites et elle peut prendre une forme explicitement narrative. Par exemple, à propos du changement de régime alimentaire propose par les femmes d’Avlekete au vodun de la variole, Sakpata, on raconte en souriant que celui-ci, écœuré a la vue de tout ce qui lui est interdit, s’enfuit en emportant avec lui le mal auquel il s’identifie mais que, comme Apollon, il est pour cette raison même le seul à pouvoir faire disparaître.
S’amorce donc à cette occasion un récit qui met le dieu à distance et envisage le moyen de le tromper et d’en triompher. On pense à Benjamin et à son analyse du conte comme le premier moyen inventé par l’homme pour sortir du «cauchemar mythique» et maîtriser les figures terrifiantes qui le hantent. On pourrait en dire autant des commentaires que font les acteurs de tous les rites d’inversion. Pensons aux insultes qu’adressent au cadavre du roi défunt, dans les royaumes agni, les descendants d’esclaves auxquels on fait semblant de confier le pouvoir pendant la période de l’interrègne. Leurs propos démontrent, au même titre que ceux des prêtresses d’Avlekete à l’égard des hommes, que personne n’est dupe des ruses du pouvoir ou de la domination. Cette mise en dérision, qui a tout d’une mise en cause, peut s’appliquer aussi bien aux dieux lorsqu’ils sont jugés responsables des malheurs qui peuvent accabler les hommes.
Un deuxième exemple a trait aux phénomènes de possession. On en rend compte généralement en rappelant la métaphore utilisée localement du cheval et de sa monture. Mais des exégètes avisés ont proposé à Bernard Maupoil au Bénin et à Michel Leiris en Éthiopie une interprétation qui ouvre d’autres perspectives. Au Bénin, Gedegbe, ancien devin de Béhanzin, avait déclaré à Maupoil que, en vérité, le vodun était déjà présent dans le rein de celui qu’il possédait et qu’au moment de la possession il lui montait à la tête. En Éthiopie, un informateur confiait à Leiris que ceux qui étaient possédés par plusieurs zar cumulaient des cartes d’identité et que, en chaque occurrence, c’était le cavalier qui ressemblait à sa monture et non l’inverse. La possession n’était donc pas une dépossession mais l’affirmation et le dévoilement d’une identité renforcée. Ces remarques peuvent être mises en relation avec ce que l’on sait par ailleurs des représentations de l’hérédité, pour lesquelles des éléments de la personnalité individuelle se redistribuent dans diverses directions au moment de la mort, certains d’entre eux se réinscrivant dans la filiation. Si l’on prête attention, en outre, au fait que les dieux du type vodun sont presque toujours présentés comme d’anciens hommes, des ancêtres, on peut en conclure que c’est le rapport entre morts et vivants, dieux et hommes, individus et collectivités qui est incessamment remis en jeu dans chaque épisode de la vie rituelle de tous et de chacun sous tous ses aspects, de la naissance à la mort en passant par l’initiation.
Je ne prétends pas conclure l’analyse de certains groupes à celle de l’Afrique en général ; ce serait d’autant plus vain que la pression de l’histoire bouscule depuis longtemps les constituants de la pluralité dynamique dont j’ai essayé de rappeler quelques traits. Mais la richesse des représentations de cette pluralité, constitutive de la personne individuelle, et sa relation étroite avec l’appareil rituel consacré à la gestion de l’événement sont particulièrement remarquables sur le continent africain, et elles sont encore à l’œuvre dans les diverses réactions dites «syncrétiques» à l’épreuve de la colonisation, du pouvoir blanc et éventuellement du pouvoir national. C’est d’ailleurs cette solidité symbolique et structurale dont on peut repérer la trace outre atlantique. Ceux des dieux d’Afrique qui s’y retrouvent, éventuellement sous un autre nom, appartenaient aux panthéons de régimes politiques très structurés, comme les royaumes fon ou yoruba, et, en outre, comme le Legba du Bénin, y exerçaient les fonctions symboliques essentielles qui s’attachent aux notions de rencontre, de carrefour, de seuil et de frontières.
Les objets cultuels qui sont associés aux rites que je viens d’évoquer n’ont pas encore le statut de ruines, c’est-à-dire de traces éparses perdues dans le temps entre plusieurs histoires. Les cultes en question n’ont pas tous disparu. Là où ils ont disparu, ils ne sont pas toujours oubliés et c’est un aspect important de la pluralité africaine que cette fidélité inégale et partielle à des traditions ancrées dans une vision immanente du monde, de la vie et de l’homme. Peut-être demain dans une vision réussira-t-elle à donner un style original à la vie culturelle et politique des démocraties qui essaient de se construire en Afrique. Il serait essentiel, de ce point de vue, qu’elle réussisse à échapper aussi bien aux récupérations médiatiques avides d’images à consommer de suite qu’aux prosélytismes monothéistes toujours tentés par la colonisation des âmes.
I fondi speciali della Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. La raccolta di stampe antiche del Centro Studi Archeologia Africana
 In “Memorie” della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano Vol. XXXIII, Fascicolo III
In “Memorie” della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano Vol. XXXIII, Fascicolo III
A cura di Paola Livi
Milano, 2005
Testo in italiano, 250 pagine, 389 illustrazioni (b/n)
Prezzo: Euro 30
Indice:
– Prefazione di Enrico Banfi e di Gigi Pezzoli
– Paola Livi “Iconografia e letteratura sull’Africa in età moderna. La raccolta di stampe antiche del Centro Studi Archeologia Africana”
– Paola Barbara Piccone Conti “Dialogando con le immagini. Alcune note sul fondo di stampe del Centro Studi Archeologia Africana”
– Introduzione al catalogo
Togo, Regione delle Savane (2003-2004 e 2015)
Nel 2003 e nel 2004 un’équipe mista del CSAA e del Ministero della Cultura del Togo ha compiuto missioni di ricerca nel nord Togo, area di Dapaong. Scopo delle missioni era verificare l’esistenza e documentare siti con pitture rupestri. Nel corso delle prime due missioni sono stati individuati quattro siti (ripari) con un ricco repertorio iconografico. Nel 2015 la ricerca è ripresa sulla base di materiale inedito raccolto dal padre francescano Pierre Reinhard (†). Sono stati repertoriati e documentati oltre 20 siti contenenti pitture rupestri, tracce di frequentazione e resti connessi alla tecnologia di estrazione del ferro (forni, ecc.). Prime verifiche di termoluminescenze datano la frequentazione dei ripari tra il XVII e il XVIII secolo.
Documentazione
Segnalazioni sulla ricerca nel periodico “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”.
ALLUNA – Mondo e spiritualità Hausa
Milano, 2013
Testo in italiano, 64 pagine, 45 foto (colori), 10 foto (b/n).
Prezzo: Euro 20
Prezzo soci CSAA: Euro 16
Indice:
– Presentazione di Maurizio Biordi
– Gigi Pezzoli “Alluna. Mondo e spiritualità Hausa”
– “Gli Hausa”
– “La magia e l’Islam”
– “Educazione e tradizione Hausa, la mia testimonianza” Intervista a B.S.W.
– “Repertorio di tavole coraniche Hausa”
Progetti e ricerche in corso
Stiamo lavorando in Africa e in Italia ad un serie di progetti di ricerca e successive mostre:
Ricerca e pubblicazione su complessi di pitture rupestri nel nord del Togo
Nell’area di Dapaong (nord Togo), nel 2003 e 2004, il CSAA, nell’ambito di una missione di ricerca con il Ministero della Cultura del Togo e con l’Università di Lomé, ha documentato l’esistenza di siti con complessi di pitture rupestri. La ricerca è ripresa nel 2015 con l’obiettivo di pubblicare il materiale inedito raccolto dal CSAA e da padri francescani che hanno vissuto ed operato nella zona.
Ricerca, mostra e pubblicazione sui manifesti di Nollywood e su alcuni artisti africani contemporanei
In Nigeria esiste una copiosissima produzione di film che trattano storie locali. Questi film, sovente prodotti dalle molte chiese cristiane indipendenti, sono accomunati da un immaginario affascinato da magia nera, streghe, zombi e fantasmi che ha trovato un rilevante sbocco commerciale. Per questioni di lingua comune, i film circolano anche in Ghana e sono pubblicizzati mediante manifesti prodotti localmente. Si tratta di grandi tele dipinte che utilizzano come supporto sacchi alimentari riciclati. Si potrebbe dire che si tratta di “arte di strada”. E poichè anche da queste manifestazioni sono emersi artisti africani ormai noti nel mondo, l’ipotesi alla quale stiamo lavorando è esplorare l’immaginario dell’occulto unitamente alla creazione artistica nel Golfo di Guinea.
Ricerca, mostra e pubblicazione sull’etno-estetica della Regione del lower-Volta (Ghana)
Dopo un intenso lavoro preparatorio condotto soprattutto sul terreno e dopo aver raccolto moltissimo materiale inedito, siamo in procinto di concretizzare una mostra sull’etno-estetica della Regione del lower-Volta (Ghana). Stiamo ragionando su un progetto che sia un’esposizione scientifica proposta in un dispositivo culturale post-coloniale mediante il coinvolgimento del mondo dell’arte contemporanea.
Ricerca, mostra e pubblicazione sulle manifestazioni artistiche dei Bariba (Bénin)
I Bariba sono una popolazione stanziata nel nord-est del Bénin e in Nigeria, caratterizzata da una complessa organizzazione sociale di tipo “feudale”. Ai culti della fecondità femminile è associata la produzione di figure lignee che stiamo indagando in collaborazione con ricercatori francesi.
Ricerca, mostra e pubblicazione sulla memoria della schiavitù in Africa
In Africa la memoria della schiavitù è una questione ad un tempo antica e contemporanea. Nell’area che in epoca pre-coloniale era definita la “costa degli schiavi” (dal Ghana all’attuale Bénin), nell’immaginario collettivo e nei culti tradizionali quell’immane tragedia rimane ancora viva. La ricerca indaga la memoria della schiavitù nel mondo dei Fon (l’antico regno del Dahomey) e, più particolarmente, mira a documentare il ruolo africano nella pratica dello schiavismo antico e moderno. Trattandosi di una questione tutt’ora viva, la mostra dialogherà con temi dell’attualità utilizzando anche l’opera di alcuni artisti contemporanei che a questa tematica fanno riferimento.
Nuovo numero del periodico “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”
E’ in fase di impostazione un nuovo numero del periodico del CSAA “Archeologia Africana – Saggi Occasionali”.
Associarsi al Centro Studi Archeologia Africana
La quota annuale di associazione al CSAA è di 30 Euro.
Gli interessati possono fare il versamento sul C/C postale n. 78945540 intestato al Centro Studi Archeologia Africana, Corso Venezia 55, 20121 Milano.
Gli interessati devono indicare: nome, cognome, indirizzo e nella causale dovrà essere riportato: quota associativa dell’anno in corso.
L’iscrizione al CSAA comporta i seguenti vantaggi:
- possibilità di partecipare a tutti gli eventi e manifestazioni dell’associazione;
- copia in omaggio della rivista del CSAA “Archeologia Africana – Saggi occasionali” e possibilità di pubblicare articoli
- sconto del 30% sulle pubblicazioni del CSAA;
- ingresso gratuito al Museo di Storia Naturale di Milano.
La religione della sete: l’uomo e l’acqua nel Sahara
Milano, 1993
Testi in italiano e francese, 143 pagine, 156 illustrazioni (b/n), bibliografie.
Prezzo: Euro 30
Prezzo soci CSAA: Euro 25
Indice:
– Introduzione di Giulio Calegari
– Nicole Petit-Maire “Les variations climatiques au Sahara: du passé au futur”
– Olivier Dutour “L’homme et l’eau au Sahara méridional – aspects paléoanthropologiques”
– Tierry Tillet “La presence de l’homme au Sahara méridional durant le Pléistocène”
– Barbara E. Barich “Il ruolo e la ricerca dell’acqua presso le società sahariane dell’Olocene”
– Axel et Anne-Michelle Van Albada “L’eau et le symbolisme lié à la fertilité dans l’art rupestre du Messak Settafet (Fezzan-Lybie)”
– Karl Heinz Striedter “Recherches récentes au plateau du Djado”
– Giulio Calegari e Giovanna Soldini “Punti d’acqua e invenzione del territorio”
– Marceau Gast “L’alimentation en période de disette au Sahara central”
– Eugenio Turri “Uomini e pozzanghere: la geografia evanescente del Sahel”
– Pierpaolo Faggi “Acqua del cielo – Acqua dello Stato”
– Giulio Calegari, Cristina Ansaloni, Giusi Grungo “La posizione relativa delle figure in alcuni fregi di Taouardei”
L’arte rupestre dell’Eritrea: repertorio ragionato ed esegesi iconografica
La cerimonia funebre di Akoutsa Tegèe
di G. P.
Nel sud del Togo, nella terra del vodu, anche le moderne cerimonie funebri sono impregnate dei culti tradizionali.
Agosto 2012, Albert, il mio vicino di casa, mi segnala che il sabato successivo si sarebbe tenuta nel suo villaggio natale, dalle parti di Afagnan, la cerimonia funebre della zia, Akoutsa Tegèe, una ricca commerciante morta da qualche mese. Da quelle parti i funerali non si fanno a ridosso del decesso. Siccome sono cerimonie costose, occorre che la famiglia raccolga i soldi, convochi i parenti che sovente vivono lontano, che organizzi l’accoglienza e tutto quanto necessario. Nell’attesa, le spoglie defunto attendono in una cella frigorifera della città più vicina.
Ci andiamo. Tutto è stato predisposto: è pronto l’apatam, cioè una tettoia provvisoria fatta di legni e frasche, sono state noleggiate le sedie in plastica, c’è un’orchestrina a fiati, gli amici e i parenti sono tutti lì. Ed ecco che arriva la cassa (foto 1) preceduta dalle adepte del vodu con il busto decorato con il caolino. La cassa viene deposta nel bel mezzo del cortile coperto con la foto della defunta in bella vista (foto 2). Attorno si affollano i parenti che per l’occasione sono tutti vestiti con lo stesso tessuto (foto 3). L’orchestrina suona (foto 4) per introdurre il sermone del pastore (foto 5). Akoutsa Tegèe era nata vodu ma poi si era convertita al cristianesimo pentecostale. In un’atmosfera mesta il pastore racconta la vita della defunta, ne tesse le lodi di madre e di nonna amorevole. La predica è lunga, si parla del bene e del male, del senso dell’esistenza e della morte, il tutto secondo la visione cristiana. I presenti ascoltano in silenzio mentre una mamma allatta il suo bambino (foto 6), la vita continua.
Poi, fatta la benedizione, la cassa trasportata a spalle dai parenti si avvia lentamente verso il villaggio per accompagnare la defunta a salutare, casa per casa, i vicini e i conoscenti (foto 7). A quel punto la situazione cambia: la cassa viene strattonata, i parenti la spingono a destra e a sinistra, in alto e in basso (foto 8 e 9). E’ il cerimoniale vodu che simboleggia la strenua lotta tra la vita e la morte: c’è chi cerca di allontanare Akoutsa Tegèe dalla fossa come in un disperato tentativo di trattenerla in vita, c’è chi invece la spinge verso l’estrema dimora riconoscendo che la vita è finita. L’atmosfera sembra concitata, ma è un rito e tutti partecipano attivamente. Alla fine la cassa viene interrata accanto alla capanna dove la defunta aveva vissuto.
Ma la cerimonia non è finita, ora può cominciare la festa tradizionale. Sotto un grande albero frondoso c’è un’orchestra con i tamburi parlanti che, alla loro maniera, raccontano la vita della defunta (foto 10). Improvvisamente l’atmosfera diventa festosa: iniziano le danze che dureranno fine a notte fonda (foto 11), la “sodabi” (la grappa tradizionale) scorre a fiumi e tutto il villaggio ballerà fino a sfinirsi.
Il mio amico Albert, il nipote maschio di Akoutsa Tegèe, quello che ha avuto più successo nella vita e che con il suo denaro ha dato un contribuito importante viene issato sulle spalle dei parenti (foto 12). Albert indossa una collana preziosa, è il suo simbolo di status; da questo momento toccherà a lui occuparsi dei bisogni della famiglia.
Lomé, 2012
Testi e immagini di questa storia sono protetti da diritti di copyright del Centro Studi Archeologia Africana e pertanto non possono essere riprodotti (né in toto, né in parte) senza esplicito consenso scritto del CSAA.